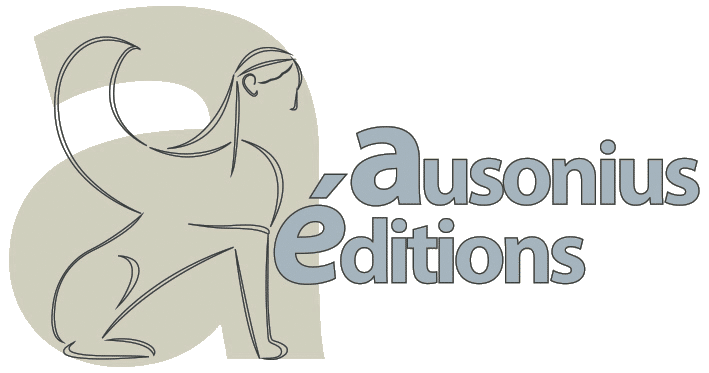In the context of a research project on the Golasecca belt plates, in this study we intend to define a chrono-typology of this accessory, focusing on the triangular and rectangular Golasecca plates. The territory associated with the Golasecca culture spans from Eastern Lombardy to Western Piedmont, bounded to the North by the Alps and to the South by the Po River. Based on the discovery sites, this type of ornamentation seems to be characteristic of the western area of the Golasecca culture.
By examining the collected data, the research suggests a new typology entrusted to an alpha-numeric series of Golasecca belt plates, with the aim to highlight their different typological and chronological characteristics. For the overall recognition of the belt plates the number identifying the form is flanked by a lowercase letter, a-b-c-d, to indicate the presence of four (a) or five flaps (b), residual flaps (c) and holes for fixing (d), which is followed by the determination of the decoration (D), also identified in the different variants with progressive numbers. The type is thus defined by shape, fastening system and decoration if identified.
Six distinct forms of belt plates have been identified according to their shape and size. These different forms also reflect a chronological sequence. Form 1, with a triangular shape and deriving from the models of French Final Bronze Age, is attested from the late 7th Century BC to the first quarter of the 6th Century BC. Form 2 seems to testify a transitional phase between form 1 (triangular) and the subsequent rectangular form and is mainly attested between 575 BC and 525 BC (G. II AB). Rectangular-shaped forms (forms 3-6) have been subdivided according to their dimensions, and their frequency indicates that the smallest type (form 3) slightly predates the others, as it is only found in G. II AB contexts, while the others are all dated between the late 6th Century BC and the early 5th Century BC (G. II B).
All 144 known belt plates in the Golasecca area are presented, and in particular those that were unpublished are illustrated in the tables, with a detailed analysis of numerical data regarding frequency, discovery contexts, and typology.
To date, two production centers have been identified: one in Castelletto Sopra Ticino-Cascina Riviera in the province of Novara and one in Gropello Cairoli-Santo Spirito in the province of Pavia. In the first site, where a bronze working area related to the second and final phase of settlement (second half of the 6th Century BC-beginning of the 5th Century BC) has been identified, three belt plates in the process of production were found, preserved in a semi-finished state just after being removed from a single-valve mold. In the second site a single-valve mold attests to its production in the context of bronze worker’s atelier. These findings confirm the serial production in molds of these ornamental objects, a production that must have responded to a high demand for belt plates from the community.
The research was complemented by diagnostic investigations using ED-XRF and RX performed on belt plates located at the Civic Archaeological Museum of Milan.
Premessa
Il progetto di ricerca sui fermagli di cintura golasecchiani di forma triangolare e rettangolare ha consentito di definire alcuni punti fermi ed evidenziare anche alcune problematiche; si sottolinea che l’ambito della ricerca si limita esclusivamente ai fermagli rinvenuti nell’areale golasecchiano, tralasciando quelli trovati in altre aree geografiche, benché pertinenti al tipo1#.
Il territorio interessato dalla cultura di Golasecca è compreso tra Lombardia orientale e Piemonte occidentale, limitato a nord dalle Alpi e a sud dal fiume Po (fig. 1).

A partire dal lavoro di Stefania Casini2 è stato effettuato un controllo di tutta la bibliografia successivamente edita e soprattutto sono stati direttamente visionati, disegnati e fotografati i fermagli conservati presso i musei archeologici di Milano, Novara, Varese, Sesto Calende, Arona, Domodossola, nonché quelli conservati presso i Musei Reali di Torino e quelli delle collezioni Borromeo Isola Bella di Stresa e Ponti di Varese3. Ad oggi non è ancora stato possibile prendere visione diretta dei fermagli conservati presso il Museo Archeologico di Como, di cui si dispone delle schede SIRBeC4.
Tale lavoro ha portato quasi a raddoppiare il numero degli esemplari precedentemente segnalati e i risultati qui presentati, relativi alla frequenza, ai contesti di rinvenimento e alla tipologia, riguardano tutti i 144 fermagli individuati in area golasecchiana. A questi si deve aggiungere quello rinvenuto nella t. 13 di S. Ilario d’Enza in loc. Fornaci (n. 144)5 e quello della necropoli di Oppeano Ca’ del Ferro trovato nella t. 2-scavi 1981 agganciato su un fermaglio tipo Sant’Ilario (n. 145), tra l’altro modalità d’uso fino ad ora sconosciuta6; questi ultimi due, trattandosi certamente di importazioni dirette in ambito emiliano e veneto, non sono stati considerati nei grafici di frequenza7.
Nelle figure sono illustrati solo i nuovi fermagli individuati e quelli rivisti personalmente. A tutti i fermagli è stato attribuito un numero progressivo con il quale sono citati nel testo e nelle figure (vd. Appendice 1). Alla stessa appendice si rimanda per i riferimenti bibliografici dei fermagli non illustrati.
Un problema di definizione tipologica
Tre sono i tipi di fermagli di cintura in uso in ambito golasecchiano. Il tipo ticinese, decorato a sbalzo e peculiare della provincia alpina della cultura di Golasecca dall’inizio del VI sec. a.C. fino a tutto il V sec. a.C. Il tipo Cerinasca d’Arbedo, in lamina bronzea quadrangolare generalmente inornato, presente in tutte le fasi del G. III A e forse anche già a partire dal G. II B e caratteristico anch’esso del Canton Ticino. Il tipo definito Golasecca da Stefania Casini e da lei suddiviso in variante triangolare (A) e sub-rettangolare (B). Proprio la definizione di quest’ultimo tipo è stata oggetto recentemente di revisione da parte di Francesco Rubat Borel in occasione dello studio dei materiali di Chiusa Pesio8. Rubat Borel propone di mantenere la definizione tipo Golasecca per i fermagli sub-rettangolari e definire tipo Castelletto Ticino quelli triangolari, in considerazione del fatto che questi ultimi sono stati, ad oggi, rinvenuti quasi solo nel territorio castellettese. Nelle successive pubblicazioni vengono citate le due diverse proposte di classificazione.
Propongo in questa sede una nuova tipologia (fig. 2) affidata ad una serie alfa-numerica che identifichi i diversi modelli di fermaglio, poiché la presente ricerca ha portato all’individuazione di nuove forme intermedie. La forma è definita da un numero e per il riconoscimento complessivo del fermaglio al numero si affianca una lettera minuscola, a-b-c-d, per indicare la presenza di quattro (a) o cinque alette (b), di alette residuali (c) e di fori per il fissaggio (d), cui segue la determinazione della decorazione (D), anch’essa identificata nelle diverse varianti con numeri progressivi. Il tipo risulta così definito da forma, sistema di fissaggio e decorazione se individuata: un fermaglio indicato come tipo 3aD1 sarà un fermaglio di forma rettangolare, con quattro alette di fissaggio e con decorazione a effetto tremolo. Le diverse forme hanno valore cronologico (fig. 14).
La forma 1 (fig. 3) è quella triangolare che, come già evidenziato da Rubat Borel9, è molto probabile che derivi dai fermagli del Bronzo Finale francese. I fermagli triangolari sono di dimensioni contenute, con una lunghezza compresa tra i 7,4 e i 5,5 cm e una larghezza alla base tra 1,8 e 2,7 cm (fa eccezione il fermaglio n. 43 di dimensioni più grandi, fig. 3.43). Il gancio si presenta quasi sempre con forma “a goccia” di ridotte dimensioni.
I fermagli di forma triangolare, anteriori a quelli rettangolari, sembravano essere documentati solo a partire dall’inizio del VI sec. a.C. (G. II A), ma sono invece da retrodatare ad un momento avanzato del G. I C. Infatti, nella t. 7/1986 della necropoli di via Aronco a Castelletto Sopra Ticino, un fermaglio di forma triangolare (n. 62), con decorazione a linee longitudinali parallele eseguite ad effetto tremolo, si trova in un corredo risalente a questo momento cronologico10. In questo senso la datazione della t. 21 di Castelletto Sopra Ticino, dove compare un fermaglio di tipo 1 (n. 34, fig. 3.34), ad un momento avanzato del G. I C11 non evidenzia più un’incompatibilità tra ceramiche e bronzi nell’attribuzione cronologica della sepoltura. La supposta confusione nella ricomposizione del corredo per quanto riguarda gli ornamenti bronzei12 vedrebbe come unico elemento estraneo la fibula a sanguisuga di tipo pre tardo alpino con la molla nettamente distinta dall’arco e databile al G. II B13. Nella t. 20/2007 della necropoli di via Cosio, sempre a Castelletto Sopra Ticino, datata tra la fine del VII e l’inizio del VI sec. a.C., è presente un altro fermaglio (n. 64)14 che, benché inserito in questo tipo, presenta forma più tozza e lievemente a losanga che ricorda il fermaglio della t. 75A di Chiavari datata alla metà del VII sec. a.C. (Chiavari II A-B)15.
Per quanto riguarda la datazione è comunque importante sottolineare che su un totale di 18 fermagli triangolari (nn. 34-fig. 3.34, 43-fig. 3.43, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 77, 92-fig. 3.92, 97-fig. 3.97, 107, 128, 143-fig. 3.143, 147) solo 4 (nn. 34, 62, 64, 128) sono parte di contesti chiusi; i primi tre si datano come abbiamo visto ad un momento avanzato del G. I C e solo il fermaglio dalla t. 2 di Pressagona (n. 128) risale ad un contesto di metà VI sec. a.C. (G. II A-B / Tessin B). Agli esemplari in bronzo in esame è da aggiungere quello in ferro presente nella tomba B40 di Ameno-Lortallo datata al G. II A16.
La forma 2 (fig. 4) sembra testimoniare un momento di passaggio tra quella triangolare e quella rettangolare, con profilo dalla parte del gancio più affusolato rispetto ai modelli successivi e con una più evidente distinzione nella forma in due parti: tendente al triangolare dalla parte del gancio e rettangolare in quella posteriore17. Su 17 fermagli (nn. 17-fig. 4.17, 42-fig. 4.42, 45, 46, 49, 61-fig. 4.61, 80-fig. 4.80, 89-fig. 4.89, 98-fig. 4.98, 103, 117, 122, 126, 134, 139-fig. 4.139, 140-fig. 4.140, 141-fig. 4.141) solo 5 provengono da sepolture con corredi affidabili (nn. 17, 61, 122, 126, 134) e si datano quattro al G. II A-B e una al G. II B, confermando che possa trattarsi di una forma di passaggio.
I fermagli rettangolari/sub-rettangolari (forme 3-5) sono stati suddivisi in base alla lunghezza: forma 3 non più lungo di 6 cm (fig. 5), forma 4 lungo tra i 6,5 e i 7,7 cm (fig. 6) e forma 5 lungo tra gli 8 e i 10 cm (figg. 7-12)18.
Queste forme sono documentate dalla metà alla fine del VI sec. a.C. (G. II A-B – G. II B). In un solo caso, nella t. 10 di Ameno (n. 1), i frammenti di un fermaglio rettangolare di tipo non determinabile, forse forma 3, sono presenti in un contesto del G. II A19. Tra i più piccoli (forma 3, 16 fermagli: nn. 2-fig. 5.2, 3-fig. 5.3, 5, 28-fig. 5.28, 56, 58, 65, 66, 67, 78-fig. 5.78, 90, 91, 104, 108, 120, 131-fig. 5.131) e i più grandi (forma 5, 63 fermagli) sembra esserci un lieve scarto cronologico; infatti, la forma 3, per gli esemplari provenienti da contesti certi, si data sempre al G. II AB, fatta eccezione per il già citato fermaglio della t. 10 di Ameno che risale al G. II A.
Anche la forma 4, con 18 fermagli (nn. 20-fig. 6.20, 21-fig. 6.21, 27-fig. 6.27, 47, 72-fig. 6.72, 74-fig. 6.74, 84-fig. 6.84, 86-fig. 6.86, 96-fig. 6.96, 102, 105, 106, 116, 123, 124, 125, 127, 142-fig. 6.142) di cui 5 provenienti da contesti datati (nn. 20, 84, 123, 124, 127), sembrerebbe avere valore cronologico dal momento che le sepolture risalgono tutte al G. II B.
Allo stesso momento cronologico si data la forma 5, come indicato dai 15 fermagli (nn. 8, 18-fig. 7.18, 19-fig. 8.19, 25-fig. 11.25, 26, 32-fig. 12.32, 33-fig. 10.33, 35-fig. 11.35, 36, 37, 69, 85-fig. 9.85, 133, 136, 138-fig. 11.138, 146) rinvenuti in contesti chiusi. In due esemplari (nn. 73 e 99-figg. 9.73 e 9.99) si nota una sorta di lieve allargamento della placca e un arrotondamento dalla parte del gancio che potrebbero forse costituire una variante ma, considerato l’esiguo numero di individui e il fatto che non si abbiano dati sui contesti di rinvenimento, al momento non è stata valutata come una differenza sostanziale.
La forma 6 (fig. 13) documenta un modello lievemente più largo che conferisce al fermaglio un aspetto meno slanciato, con misure in larghezza comprese tra i 4,8 e i 5,4 cm. La forma risulta decisamente meno frequente (nn. 119-fig. 13.119, 121-fig. 13.121, 135, 137-fig. 13.137) e si data al G. II B.
Infine, esiste un unicum, conservato tra i materiali della collezione Bellini, di forma simile al tipo 2 con doppio gancio e quattro alette di fissaggio20.
I centri di produzione
Ad oggi sono stati individuati due centri di produzione per i fermagli di forma rettangolare: uno a Castelletto Sopra Ticino e uno a Gropello Cairoli in provincia di Pavia, circa a 60 Km a sud lungo il Ticino.
Nel primo sito, in località Cascina Riviera, è stata identificata un’area artigianale di lavorazione del bronzo relativa alla seconda e ultima fase di frequentazione dell’abitato (seconda metà VI-inizi V sec. a.C.)21. Nel livello d’uso relativo alle strutture artigianali sono stati rinvenuti: un frammento di forma di fusione, un piccolo gruppo di bronzi frammentari insieme ad un pane di bronzo del peso di 976 g e tre fermagli di cintura in fase di lavorazione, appartenenti alla forma 4, con le relative bave di fusione (figg. 15, 17)22.
I fermagli sono conservati allo stato di prodotto semilavorato appena uscito dalla stessa matrice monovalva, come testimonia la superficie irregolare di una delle due facce che non è stata a contatto con lo stampo. Il metallo doveva essere colato nella matrice posta in piano; sulla faccia superiore sono ben evidenti quattro lievi cordonature in rilievo (fig. 16), identiche su tutti e tre e terminanti in corrispondenza delle alette. Le corrispondenti scanalature presenti sulla matrice costituiscono un accorgimento tecnico che, in sede di fusione, doveva servire a facilitare lo scorrimento del metallo liquido fino alle estremità dell’oggetto. Il prodotto della fusione, non riuscita come testimoniano i fori sulle placche dei fermagli e l’assenza di diverse alette, era presumibilmente stato accantonato per recuperare il metallo.
Si tratta di un rinvenimento di grande importanza in quanto permette di conoscere le modalità di realizzazione dei fermagli, che prima si pensava ricavati da una lamina ribattuta, e di conseguenza valutare l’importanza a livello sociale di questo ornamento.
A Gropello Cairoli, in località S. Spirito, dove è stato riconosciuto un atelier da bronzista23, è stata rinvenuta una forma di fusione in serpentino verde per la produzione in serie dello stesso tipo di fermaglio, con ben in evidenza le alette di fissaggio (fig. 18). Sull’altra faccia dello stampo vi sono le impronte per quattro oggetti da toelette, ma per questo uso lo stampo doveva essere bivalve, come confermato dalla presenza di un foro per un perno di fissaggio24. La posizione delle alette di fissaggio, localizzate nella parte terminale opposta al gancio, e la larghezza ridotta inducono a ipotizzare che lo stampo fosse utilizzato per la realizzazione di fermagli appartenenti alle forme 2 o 3.
In Lomellina è stata ormai riconosciuta una facies golasecchiana propria di questo territorio, testimoniata principalmente dall’abitato di Gropello Cairoli, loc. Santo Spirito e dalla necropoli di Garlasco, loc. Cascina Bonifica25. La facies, documentata già nel VII sec. a.C. fiorisce a partire dalla metà del VI sec. a.C. e avrà la massima espansione proprio nel momento dell’“abbandono” del comprensorio occidentale (G. III A1, 490/480-450), attivando nuove dinamiche commerciali che mantengono vivo l’itinerario del Ticino, con una nuova organizzazione territoriale lungo un asse nord-sud, in funzione anche dei contatti con la Liguria e il Tirreno settentrionale.
Entrambi i ritrovamenti documentano una produzione seriale di questo tipo di ornamento e l’esistenza di officine legate alla loro fabbricazione, officine che dovevano rispondere ad una forte domanda di fermagli da parte della comunità.
Dal punto di vista tecnologico, i fermagli talora recano tracce evidenti della martellatura della lamina sulla superficie interna, legata alla rifinitura dell’oggetto una volta uscito dalla matrice. In particolare si distinguono serie di colpi stretti e allungati distanziati in modo abbastanza regolare (nn. 18, 19, 29, 33, 34, 38, 41, 59, 70, 94, 118, 125) (fig. 19. 1), eseguiti presumibilmente con un martello a piccola punta allungata e convessa; più raramente si notano fitti segni continui disposti in senso longitudinale (nn. 12, 13, 93) (fig. 19. 2), eseguiti con uno strumento diverso e verosimilmente legati alla natura del supporto utilizzato per la lavorazione. In alcuni casi le martellature, a causa delle alterazioni superficiali, sono visibili solo sulle lastre (nn. 14, 99, 135 vd. infra). La superficie esterna, al contrario, era accuratamente levigata e su di essa veniva eseguita la decorazione. Lo spessore finale della lamina del fermaglio è compreso tra 0,5/0,8 e 1 mm, considerando solo quelli sottoposti ad esame autoptico (73 fermagli) e sebbene sia da tenere in considerazione che l’usura, la corrosione o la presenza di incrostazioni possono talora rendere parzialmente inesatta la misurazione. La sostanziale uguaglianza degli spessori dei fermagli visionati (42 fermagli sono spessi 0,5 mm e i restanti oscillano tra 0,6 e 0,8 mm, più raramente 1 mm) sembra indicare un controllo da parte degli artigiani delle proprietà fisiche della lega, insieme alla conoscenza delle caratteristiche funzionali dell’oggetto prodotto. Non a caso, infatti, la variazione dello spessore nel punto di piegatura del gancio e del gancio stesso, che generalmente presenta uno spessore di 2 mm, è funzionale alla martellatura e ripiegatura della lamina e alle esigenze di robustezza necessarie al bloccaggio della cintura.
In caso di rottura i due frammenti erano sovrapposti, il frammento più grande su quello più piccolo, e uniti tra loro tramite ribattini, in bronzo o ferro; in alcuni casi sono stati utilizzati fili in bronzo a sezione circolare e/o rettangolare (fig. 19. 3-4). Generalmente, quando si tratta di ribattini in bronzo, la testa, posta sulla superficie esterna, era martellata fino ad essere assottigliata e espansa. Il punto di rottura nel fermaglio è pressoché sempre a circa metà della placca e quasi mai al gancio che come abbiamo visto era più spesso rispetto al resto della lamina. Trattandosi del punto di maggior sollecitazione nell’atto di fissare la cintura era anche quello più soggetto a danneggiamenti. La sovrapposizione dei frammenti ne altera evidentemente le proporzioni originarie.#

Contesti di rinvenimento e frequenza tipologica
Di poco più di un terzo dei fermagli non si conosce la provenienza territoriale (35 %) (fig. 20), sebbene sia ipotizzabile che si tratti dell’area occidentale della cultura di Golasecca in quanto l’88 % di quelli di provenienza nota, anche solo indicativamente come “area W della cultura di Golasecca”, sono documentati proprio in ambito occidentale.
Su 144 fermagli soltanto 51 sono associati con certezza a contesti tombali, sebbene sia presumibile che tutti i fermagli fossero in origine parte di corredi26; di questi solo 35 sono stati trovati in sepolture con corredi affidabili, numero che corrisponde a 35 sepolture (fig. 21)27.
Pochi sono i fermagli che mostrano deformazioni evidenti dovute all’azione del fuoco del rogo (nn. 2, 9, 11, 12, 26, 32, 37, 41, 74, 79, 86, 98, 121, 132, 135, 140, 143); alcuni non deformati dal fuoco (nn. 81, 91, 99) conservano numerose concrezioni di dimensioni quasi centimetriche che potrebbero essere frammenti ossei.
Dal punto di vista formale i fermagli rettangolari sono decisamente la maggioranza e tra di essi la forma 5 è quella più frequentemente documentata (fig. 22).
Funzionalità
I fermagli erano fissati alla cintura di cuoio o di altro materiale deperibile (tessuto, fibre intrecciate) tramite alette rettangolari disposte generalmente a coppie lungo i lati lunghi; in alcuni esemplari – 15 di forma rettangolare (forme 5 e 6) (nn. 13, 22, 23, 33, 40, 59, 75, 76, 82, 85, 93, 110, 121, 135, 137) e 2 di forma 1 (nn. 43, 64) – una quinta aletta è localizzata anche lungo il lato breve opposto al gancio, finalizzata a bloccare anche questo lato del fermaglio al supporto sottostante. La presenza della quinta aletta è forse dovuta alle maggiori dimensioni del fermaglio che, più pesante se si esclude il n. 62 che è di piccole dimensioni, necessitava di un ulteriore punto di fissaggio. In due casi i fermagli di forma 1 (nn. 57 e 62) mostrano due alette disposte lungo il lato breve; su un altro fermaglio di forma 1 (n. 77) secondo Castelletti una sola aletta doveva situarsi anch’essa lungo il lato breve28.
Anche l’esistenza in quattro casi (nn. 69, 93, 94, 135 quest’ultimo anche con quinta aletta) di un piccolo foro, in un caso nel mezzo della placca (n. 69) e negli altri lungo il lato opposto al gancio, può essere interpretato con finalità di fissaggio.
La presenza/assenza della quinta aletta non può però essere considerata valida ai fini delle percentuali di frequenza perché in numerosi casi il lato breve opposto al gancio è rovinato o incompleto.
Il sistema di chiusura poteva essere con passanti disposti lungo la cintura (15 esemplari)29 o con anelli (2 esemplari), talora ritrovati ancora infilati sul gancio di chiusura. Generalmente il passante è costituito da una fettuccia in bronzo a sezione rettangolare ripiegata su se stessa e parzialmente sovrapposta; in un solo caso (n. 124) è documentato con funzione di passante un filo di bronzo a sezione circolare.
Non ci sono motivi per ipotizzare che il fermaglio fosse rivolto necessariamente verso destra o verso sinistra dal momento che non compaiono raffigurazione sulla placca e il motivo dell’ornato, quando presente, è di tipo geometrico e disposto in modo simmetrico30.
I fermagli erano in ogni caso manufatti di prestigio, che rimanevano a lungo in uso, come dimostra la presenza degli interventi di restauro antico su 17 fermagli (nn. 10, 11, 19, 35, 45, 47, 51, 53, 75, 81, 88, 91, 95, 108, 131, 138, 141); su alcuni frammenti è conservata solo la traccia dei fori per la riparazione. La sintassi decorativa non era rispettata nel restauro e si nota in alcuni casi la sovrapposizione del motivo ornamentale. Lo stesso tipo di riparazione, con il sovrapporsi della sintassi decorativa, si ritrova anche sui fermagli a losanga di tipo ticinese31. L’intervento di riparazione testimonia anche del valore che questa classe di materiali aveva per il gruppo sociale che lo utilizzava, simbolo forse di uno status o di un ruolo specifico.
Per quanto riguarda il supporto dei fermagli in solo quattro casi32 la cintura doveva essere adornata con borchiette bronzee; è importante sottolineare che l’esiguità del numero delle testimonianze di questo tipo di decorazione per il supporto può anche essere imputabile al fatto che la maggior parte dei fermagli è stata rinvenuta in vecchi scavi dove l’attenzione per gli elementi molto piccoli era certamente minore.
Decorazione
La decorazione (figg. 2, 27), quando individuabile, è quasi sempre dello stesso tipo, sebbene in diversi casi la sua lettura ad occhio nudo sia resa difficile dall’usura e dalla corrosione del fermaglio.
La decorazione è generalmente a effetto tremolo (Tremolierstick) (tipo D1, fig. 23), con la suddivisione della superficie in 3, 4 o 5 campi mediante linee trasversali, riempiti poi con linee a zig-zag, longitudinali, diagonali oppure disposte a X. In un solo caso il fermaglio è diviso in quattro campi in senso longitudinale (fig. 23.30) e ugualmente una sola volta compare una linea longitudinale con linee diagonali disposte a spina di pesce (fig. 23.137). Infine, in una sola occorrenza (n. 62) la decorazione su un fermaglio di forma triangolare sembra essere costituita da tre linee parallele disposte nel senso della lunghezza senza motivi trasversali a riempire lo spazio. Sui fermagli di forma 1 la decorazione a tremolo, più irregolare e a larghe maglie (nn. 51-52, fig. 23.51-52), ricorda quella dei fermagli di tipo Subingen datati all’Hallstatt D133.
Raramente sono presenti triangoli campiti a tratteggio (tipo D2, nn. 22-fig. 7.22, 33-fig. 10.33, 37) e cerchielli incisi (tipo D3, nn. 21-fig. 6.21, 45, 67, 80-fig. 4.80). La presenza della decorazione a cerchielli incisi, documentata solo su quattro fermagli, potrebbe far pensare a un’influenza dell’area emiliana dal momento che tale decorazione si ritrova sui fermagli di tipo S. Ilario34.
In tre casi la superficie reca puntini a sbalzo (tipo D4, nn. 3-fig. 5.3, 120, 146) e in un solo caso (n. 64) puntini incisi (tipo D5).
La decorazione ad effetto tremolo sembra essere non solo esclusiva dell’area occidentale della cultura di Golasecca, ma anche riservata esclusivamente ai fermagli di cintura; in considerazione della presenza di tremolo sui fermagli Hallstatt D1 è forse ipotizzabile che questa tipo di resa decorativa derivi dall’area transalpina.

L’usura del fermaglio in alcuni casi fa sì che la decorazione “a tremolo” sembri a doppia linea di puntini e in questo modo viene talora definita in bibliografia (a titolo di esempio è il caso dei nn. 34, 35 e 66), ma ciò è dovuto proprio al consumo della superficie nella zona centrale dello zig-zag, dove l’incisione era meno profonda; solo la fotografia ad alto ingrandimento ne ha permesso infatti l’individuazione. La possibilità di osservare direttamente i fermagli che ad una prima catalogazione risultavano privi di decorazione e la macro fotografia a luce radente hanno consentito di individuare la decorazione anche su superfici corrose, patinate e/o alterate (figg. 24-26).



Proprio questo risultato ha portato alla scelta di sottoporre alcuni fermagli ad indagini a Raggi X, indagini che hanno permesso di individuare tracce di decorazione su altri tre fermagli (nn. 14, 96, 135) (vd. infra). Su 144 fermagli quelli decorati o con tracce di decorazione usurata costituiscono la metà del totale (fig. 27a); queste percentuali portano ad ipotizzare che la decorazione in origine fosse presente su tutti i fermagli e semplicemente oggi non sia più visibile a causa delle condizioni di conservazione.
Indagini diagnostiche: RX e ED-XRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence)
La disponibilità del Civico Museo Archeologico di Milano, nella persona della direttrice Anna Provenzali, a sottoporre ad analisi diagnostiche i fermagli di cintura conservati nei loro magazzini e la collaborazione in atto tra il Civico Museo Archeologico e l’Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli35, ha permesso di effettuare indagini RX e ED-XRF.
I fermagli nn. 14, 72, 73, 92, 96, 97, 98, 135, 138, che non presentavano in superficie decorazione visibile, sono stati sottoposti a radiografia, al fine di verificare l’ipotesi che tutti i fermagli fossero in origine decorati. Si è infatti ipotizzato che la non visibilità sia dovuta ad usura e/o corrosione dell’oggetto, in considerazione anche del fatto che quelli sui quali la decorazione sembra essere assente presentano una superficie estremamente rovinata, con alterazioni e concrezioni adese. I fermagli nn. 8, 35, 94, 99, per i quali l’osservazione diretta aveva rilevato la decorazione per brevissimi tratti, sono stati sottoposti ugualmente alle radiografie al fine di comprenderne meglio, se possibile, lo sviluppo.
I fermagli sono stati analizzati con la tecnica radiografica denominata CR (Computer Radiography) utilizzando una lastra a fosfori Dürr ad alta risoluzione e sensibilità (blue plate) da 35×43 cm e sistema a scansione Dürr HD-CR 35 NDT in modalità laser spot da 25 μm. Il risultato è un’immagine radiografica da 14508×17674 pixel a 16 bit in livelli di grigio. La sorgente radiogena è un tubo X a finestra di berillio Gilardoni “Radiolight” con anodo in tungsteno con tensione massima 80 kV e corrente 5 mA. La distanza sorgente-fermagli, posizionati con la faccia superiore rivolta verso l’alto, è stata di 90 cm e il tempo di esposizione pari a 90 s.
Nonostante le notevoli alterazioni sulla superficie che per cinque fermagli (nn. 72, 73, 92, 97, 98) non hanno portato a risultati, le radiografie hanno consentito di individuare la decorazione su altri tre fermagli (nn. 14, 96, n. 135-fig. 28); nel caso dei fermagli su cui era nota la presenza della decorazione questa è stata individuata in più zone (n. 8-fig. 7.8, n. 35-figg. 11.35, 29), mentre in altri casi (nn. 14, 99, 135-fig. 28) si possono notare i segni delle martellature di lavorazione.


Tutti i fermagli conservati presso il Civico Museo Archeologico (vd. Appendice 1) sono stati sottoposti ad indagini XRF. L’analisi XRF in dispersione di energia si basa sulla misurazione dell’emissione di fluorescenza e consente di determinare la composizione elementare senza richiedere alcun tipo di campionamento, rendendo nulla l’invasività e la distruttività delle indagini.
Questo tipo di indagine è stato utilizzato al fine di verificare l’eventuale presenza di piombo nella lega di rame. Infatti, un’aggiunta di piombo superiore al 2,5 % è considerata come volontaria, al fine di abbassare la temperatura di fusione del metallo e renderlo nel contempo più fluido allo stato fuso e più malleabile a freddo, permettendo così una più facile lavorazione per la resa della decorazione. Queste analisi possono presentare imprecisioni dovute, come nel nostro caso, al degrado della superficie che presenta un elevato grado di alterazione e corrosione e pertanto in sede di analisi i punti di prelievo, due per ogni fermaglio, uno sulla faccia superiore e uno su quella inferiore, sono stati localizzati nelle aree meno alterate e più lisce, oltre che talora sui ribattini utilizzati per il restauro antico del pezzo. Nel caso di fermagli restaurati i punti di prelievo sono stati raddoppiati al fine di accertare se i due frammenti appartenessero o meno allo stesso fermaglio originario. I parametri utilizzati nelle misurazioni sono illustrati nella tab. 1; il collimatore definisce la dimensione del fascio di raggi X. Poiché i campioni presentavano uno stato di alterazione elevato e non uniforme, si è deciso di utilizzare un collimatore relativamente grande per ottenere un’informazione mediata su di una superficie maggiore.
| Anodo del tubo | Rh |
| Voltaggio | 40 kV |
| Corrente | 60mA |
| Tempo di misurazione | 90 secondi |
| Collimatore diametro | 2 mm |
L’esame qualitativo degli spettri ottenuti ha permesso di elaborare indicazioni di massima circa la composizione dei fermagli, che evidenzia la presenza di elementi riconducibili alla lega originaria e ai suoi prodotti di alterazione, oltre che alla probabile contaminazione da parte del terreno di deposizione (tab. 2).
| n. fermaglio | Cu | Sn | Pb | Fe | Ni | Ca | S | P | Ti | Si | As |
| 8 (1) | xx | x | x | x | x | traccia | traccia | traccia | traccia | traccia | – |
| 8 (2) | x | x | x | x | x | traccia | traccia | – | – | – | – |
| 9 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | traccia | – | – |
| 9 (2) | xx | x | x | x | traccia | traccia | traccia | traccia | – | – | traccia |
| 10 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 10 (2) | xx | x | x | x | traccia | x | – | – | – | – | – |
| 11 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 11 (2) | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – |
| 11 (3) | xx | x | traccia | x | traccia | x | traccia | – | – | – | – |
| 12 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 12 (2) | x | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 13 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | traccia | – |
| 13 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 14 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 14 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 35 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | traccia | – | – |
| 35 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | traccia | – | – |
| 35 (3) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | – | traccia | – |
| 35 (4) | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | traccia | traccia | traccia |
| 70 (1) | x | x | x | x | x | traccia | – | – | – | – | – |
| 70 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | – | – | – |
| 72 (1) | xx | x | x | x | x | traccia | traccia | – | – | traccia | – |
| 72 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | – | – | – |
| 73 (1) | xx | x | x | traccia | x | traccia | – | – | – | – | – |
| 73 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | – | – | – |
| 74 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | – | traccia | – |
| 74 (2) | x | x | x | x | x | traccia | traccia | – | – | – | – |
| 84 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | – | – | – |
| 84 (2) | xx | x | traccia | x | x | x | traccia | – | – | – | – |
| 85 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | x | – | – |
| 85 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 86 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | traccia | – | traccia |
| 86 (2) | x | x | x | x | x | x | traccia | traccia | – | traccia | traccia |
| 92 (1) | xx | x | x | x | traccia | x | traccia | – | traccia | – | traccia |
| 92 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 93 (1) | xx | x | x | x | traccia | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 93 (2) | xx | x | x | x | traccia | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 94 (1) | xx | x | x | x | traccia | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 94 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 95 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | traccia |
| 95 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | – | – | – |
| 96 (1) | x | x | x | x | x | x | traccia | – | – | – | – |
| 96 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | – | – | – |
| 97 (1) | x | x | x | x | x | x | x | – | traccia | – | traccia |
| 97 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | traccia |
| 98 (1) | xx | x | x | x | traccia | x | traccia | traccia | traccia | – | – |
| 98 (2) | xx | x | x | x | traccia | x | traccia | traccia | traccia | – | – |
| 99 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | traccia | – | – |
| 99 (2) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | – | – | traccia |
| 99 (3) | x | x | x | x | traccia | x | traccia | – | – | – | – |
| 135 (1) | xx | x | x | x | x | x | traccia | traccia | – | – | – |
| 135 (2) | x | x | traccia | traccia | traccia | x | – | – | – | – | – |
| 138 (1) | x | x | x | x | traccia | x | – | – | – | – | – |
| 138 (2) | xxx | x | x | x | x | x | – | – | traccia | – | – |
| 138 (3) | xx | x | x | x | x | x | traccia | – | – | – | – |
| 138 (4) | x | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – |
Tutti i punti analizzati presentano una composizione molto simile per quanto riguarda gli elementi principali che compongono la lega (rame, stagno e piombo), oltre alla quasi costante presenza di ferro e nichel, mentre differiscono per gli elementi presenti in misura minore e in traccia, quali zolfo, fosforo, titanio, silicio e arsenico. La presenza in tutti i fermagli di tracce più o meno rilevanti di calcio, elemento sicuramente estraneo alla lega originaria e da ricondurre verosimilmente alla formazione di prodotti di alterazione superficiale della stessa (probabilmente malachite e/o azurite), ha comportato l’esclusione di molti dei campioni nell’analisi quantitativa36.
L’analisi quantitativa (tab. 3), possibile solo in alcuni casi, identifica la presenza principale di rame, seguito dallo stagno e dal piombo, mentre ferro e nichel sono effettivamente presenti in quantità molto piccole (ppm). Poiché l’analisi quantitativa chiude la somma totale degli elementi al 100 %, questo porta a una variazione anche nelle concentrazioni ricavate per i restanti elementi chimici.
| N. fermaglio | Cu % | Sn % | Pb % | Fe (ppm) | Ni (ppm) |
| 8 (punto 1) | 67.67 | 26.96 | 5.36 | 6.46 | 11.29 |
| 8 (punto 2) | 48.84 | 44.28 | 6.88 | 10.69 | 9.10 |
| 9 (punto 2) | 53.83 | 35.87 | 10.30 | 6.86 | 7.19 |
| 35 (punto 4) | 42.06 | 55.11 | 2.83 | 4.27 | 6.46 |
| 70 (punto 1) | 71.25 | 15.38 | 13.37 | 4.55 | 1.92 |
| 72 (punto 1) | 84.61 | 13.19 | 2.20 | 4.23 | 6.99 |
| 73 (punto 1) | 75.46 | 19.91 | 4.62 | 4.50 | 6.97 |
| 74 (punto 2) | 77.95 | 15.55 | 6.49 | 14.18 | 1.10 |
Un dato interessante viene dalla comparazione della composizione dei due frammenti di lamine che in antico sono state giustapposte a ricomporre un fermaglio (n. 35-fig. 11.35 e n. 138-fig. 11.138): per il primo è possibile ipotizzare, sebbene la corrosione dei pezzi induca alla cautela, che i frammenti utilizzati, sulla base del conteggio dei rapporti Cu/Fe e Cu/Ni, appartenessero a fermagli diversi, mentre per il secondo confermano che si tratta dello stesso oggetto ricomposto. Esiste pertanto la possibilità che in caso di rottura venissero utilizzate lamine rotte provenienti da fermagli differenti per ricomporre l’ornamento. Tuttavia, per alcuni di essi non sottoposti ad analisi (n. 19-fig. 8.9, n. 81-fig. 11.81, n. 88-fig. 11.88) la presenza della decorazione resa in modo identico e l’osservazione diretta per quanto riguarda la ricomposizione della forma inducono a pensare che i frammenti uniti tra loro provenissero dallo stesso fermaglio originale.
I risultati qualitativi delle indagini rivelano la presenza pressoché costante di piombo nell’analisi dei prodotti di alterazione superficiale (tab. 2). L’analisi quantitativa identifica in particolare quantità significative di piombo (tab. 3); il dato va però valutato con estrema cautela considerando che la possibilità di errore dovuta alla presenza di alterazioni superficiali è stimata superiore al 10 % e solo future ulteriori analisi archeometriche potranno confermare o confutare questi primi risultati. L’identificazione della presenza di questo elemento fornisce in ogni caso interessanti indicazioni circa le possibili tecniche di realizzazione e decorazione del manufatto.
Come si è già detto, l’addizione di tale metallo migliora notevolmente la fluidità della lega allo stato liquido e la sua colabilità entro lo stampo. Le leghe contenenti piombo sono più malleabili a freddo per rifiniture successive, quali segature, perforazioni e deformazioni plastiche. Proprio deformazioni plastiche sembrano essere i decori a effetto tremolo che si ipotizza realizzati con incisione per deformazione e non per asporto37. Tuttavia l’addizione di questo elemento non agevola le lavorazioni per martellatura a freddo e la sua identificazione risulta dunque nel caso specifico problematica in relazione alla lavorazione delle alette di fissaggio e del gancio. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto la letteratura riporta della possibilità di “un certo grado di prudente lavorazione a battitura” ricorrendo a frequenti ricotture dell’oggetto per favorire la ricostituzione della struttura cristallina interna38.
Marker di genere?
I fermagli sono considerati da sempre marker del genere femminile, un po’ come le fibule a sanguisuga e le fusarole. Non sono molte, come detto, le sepolture con associazioni certe e con fermagli, solo 35. Poche anche le informazioni desumibili dalle analisi osteologiche che, benché fortemente limitate dal tipo di rituale funerario in uso nella cultura di Golasecca, sono a disposizione solo per le sepolture della necropoli di Pombia. Proprio a Pombia però si notano alcune contraddizioni tra quanto desumibile dalle componenti del corredo generalmente utilizzate per l’attribuzione del genere e le analisi osteologiche39. Infatti, considerando i dati pubblicati, le tombe 1/1993 (Planca) e 3/1995 (Quara)40, i cui corredi sembrano indicare un soggetto femminile (fibule a navicella e a sanguisuga di vario tipo), risultano al contrario presumibilmente attribuibili, sulla base delle dimensioni e conformazione di alcuni frammenti ossei, a soggetti maschili. Le tombe 2/1993 (Planca) e 8/1995 (Quara)41, le cui componenti del corredo indicherebbero invece una sepoltura bisoma (fibule a sanguisuga o navicella associate a fibule ad arco serpeggiante), contengono i resti di un solo individuo adulto di sesso indeterminato. Per quanto riguarda le fibule a arco serpeggiante, generalmente attribuite al genere maschile, è stato messo in evidenza che in Italia meridionale queste, in alcuni casi, possono ricorrere singolarmente in sepolture femminili della prima età del Ferro42. Sebbene non si possa generalizzare trattandosi di ambiti culturali diversi anche le due sepolture di Pombia contengono al loro interno una sola fibula ad arco serpeggiante, mentre le altre componenti del corredo, collana in grani d’ambra, pendagli tubolari, fibule a sanguisuga navicella, ad arco rivestito, fusarola e spiraline in filo di bronzo per la t. 2/1993 e una fibula a navicella e una fusarola per la t. 8/1995, sono riconducibili chiaramente a sepolture di genere femminile.
In assenza di analisi osteologiche problemi per la definizione del genere dell’individuo si pongono per almeno quattro sepolture: la tomba Delfinoni-area ovest cultura di Golasecca43, la tomba 4844 e la tomba 2145 di Castelletto Sopra Ticino e la tomba 1 del tumulo XXXIV di San Bernardino di Briona46, tutte con elementi di corredo misti. Infatti, se si considera il fermaglio di cintura marker esclusivamente femminile sarebbe necessario ipotizzare, almeno per le prime tre, la presenza di due individui di sesso diverso per ciascuna sepoltura, mentre per quanto riguarda la terza le fibule a arco serpeggiante, per altro rinvenute in una fossetta carboniosa sul fondo della fossa, non sono, forse, così dirimenti sulla questione del genere. Tuttavia, da Pombia sappiamo che, benché le sepolture sembrino bisome sulla base del corredo, i resti cremati sono relativi ad un solo individuo; pertanto corredi “misti” non sono sempre certezza di sepoltura bisoma.
Queste osservazioni sono da considerare con estrema cautela dal momento che non sappiamo nulla del rituale funerario e non è da escludere che la presenza di fermagli in sepolture di genere maschile sia spiegabile come offerta da parte di soggetti femminili legati da vincoli di parentela e/o dipendenza con il defunto.
Conclusioni
Le pochissime varietà morfologiche all’interno della produzione di fermagli di cintura si spiegano con la realizzazione in serie in centri specializzati come quelli individuati a Castelletto Sopra Ticino e a Gropello Cairoli. Inoltre, possiamo anche ipotizzare che la necessità di una produzione seriale fosse legata ad una “moda” relativa ad un particolare tipo di abbigliamento che necessitava di questo elemento.
Pur accettando che sia esclusivamente un indicatore di genere femminile la ricorrenza dei fermagli di cintura tra le componenti dei corredi è decisamente esigua a fronte delle numerose sepolture femminili rinvenute. A queste sono da aggiungere quelle che, sebbene senza indicatori di genere, potevano riferirsi a donne. Se si pensa per esempio alle fibule i dati di frequenza sono completamente diversi.
I fermagli di cintura, come le fusarole recentemente studiate in questo senso da S. Paltineri e M. Venturino47, sono presumibilmente un indicatore di livello sociale e dovevano costituire il riconoscimento di tipo identitario di una cerchia ristretta di individui. Resta da chiarire quale gruppo sociale si descrivesse con questo ornamento: genere/sesso, età, momento particolare della vita, ruolo all’interno della comunità. Le sepolture con contesti certi sembrano indicare che l’individuo sepolto doveva ricoprire un rango sociale importante, come testimoniato dai numerosi vasi di accompagnamento, dai contenitori bronzei utilizzati per le ceneri e dai molteplici ornamenti bronzei presenti48.
Nonostante i limiti oggettivi dovuti alla mancanza di documentazione un approccio critico sia tipologico che metodologico, qui presentato, contribuisce comunque a un incremento delle nostre conoscenze.
Quando ormai il testo del contributo era in fase di stampa, nel corso di un diverso lavoro, sono stati individuati altri due fermagli di cintura non noti, rinvenuti in sepolture di Castelletto Sopra Ticino. Entrambi appartengono al tipo 1 e sono di fondamentale importanza perché rinvenuti in contesti di pieno GIC49 e confermano, anticipando di qualche decennio, quanto proposto (vd. supra) per il momento della comparsa dei fermagli triangolari.
Il primo fermaglio (t. 3/2004 via Gesiolo) reca una decorazione complessa ad effetto tremolo (tipo D1) e presenta un restauro antico. Il fermaglio aveva perso durante l’uso tutte le alette e due di esse sono state ricavate con la giustapposizione di una sottile placchetta, le cui estremità fungevano da alette, fissata con un ribattino e posta trasversalmente al corpo del fermaglio all’estremità opposta al gancio. Traccia della riparazione di un’aletta localizzata sul lato breve si legge nei resti di un’altra piccolissima placchetta di cui rimane un brevissimo tratto e il foro del ribattino.
Il secondo fermaglio (tomba parzialmente sconvolta, via Ramacci 1994) presenta lunghezza estremamente ridotta (4,9 cm), con quattro alette di fissaggio di cui ne restano solo due ed è privo di decorazione.
Appendice 1
| N. | Provenienza | Tipo | Rest. | Deform. | Dataz. | N. inventario e bibliografia | Fig. |
| 1 | Ameno, t. B10 | rett. n.d. | GIIA | Musei Reali Torino, St. 60440, inv. Barocelli 3724; Pauli 1971, taf. 3, 12 | / | ||
| 2 | Ameno, t. B3 | 3cD1 | X | GIIAB | Musei Reali Torino, St. 60405, inv. Barocelli 3684; Primas 1970, taf. 4, C6; Pauli 1971, taf. 2,7; Casini 2000, n. 98. | Fig. 5 | |
| 3 | Ameno, t. B14 | 3aD4 | GIIAB | Musei Reali Torino, St. 60469, inv. Barocelli 3751; Primas 1970, taf. 7, A11; Pauli 1971, taf. 4, 16; Casini 2000, n. 99. | Fig. 5 | ||
| 4 | Arbedo (TI), Cerinasca, t. 92 | 5 | Casini 2000, n. 109. | / | |||
| 5 | Arbedo (TI), ripostiglio | 3 | X | Schindler 1998, 118, taf. 41, 949; Casini 2000, n. 110. | / | ||
| 6 | Arbedo (TI), Cerinasca, t. 30 | 5D | Primas 1970, taf. 26, 9; Casini 2000, n. 106. | / | |||
| 7 | Arbedo (TI), Cerinasca, t. 3 | 5cd | Tessin B | Primas 1970, taf. 21, E3; Casini 2000, n. 105. | / | ||
| 8 | Area W cultura di Golasecca, coll. Delfinoni, tomba GD 3299 | 5aD1 | GIIB | Museo Arch. Milano, A 0.9.4812; inedito. | Fig. 7 | ||
| 9 | Area W cultura di Golasecca, coll. Giani | 5 | X | Museo Arch. Milano, A 0.9.4895; Casini 2000, n. 48, inedito. | Fig. 7 | ||
| 10 | Area W cultura di Golasecca, coll. Giani | 5D1 | X | Museo Arch. Milano, A 0.9.4896; Casini 2000, n. 49, inedito. | Fig. 12 | ||
| 11 | Area W cultura di Golasecca, coll. Giani | 5D1 | X | X | Museo Arch. Milano, A 0.9.4894; Casini 2000, n. 47, inedito. | Fig. 12 | |
| 12 | Area W cultura di Golasecca, coll. Giani | 5D1 | X | Museo Arch. Milano, A 0.9.4893; Casini 2000, n. 46, inedito. | Fig. 12 | ||
| 13 | Area W cultura di Golasecca, coll. Giani | 5bD1 | Museo Arch. Milano, A 0.9.4892; Casini 2000, n. 45, inedito. | Fig. 7 | |||
| 14 | Area W cultura di Golasecca, coll. Giani | 5c | Museo Arch. Milano, A 0.9.4891; Casini 2000, n. 44, inedito. | Fig. 7 | |||
| 15 | Area W cultura di Golasecca | 5aD1 | Museo Arch. Como, E16968; Castelletti 1968, n. 11; Casini 2000, n. 62. | / | |||
| 16 | Area W cultura di Golasecca | 5aD1 | Museo Arch. Como, E16967; Castelletti 1968, n. 13; Casini 2000, n. 96. | / | |||
| 17 | Arona, Motto Lagone, t. II-2 | 2c | GIIB | Museo Arch. Arona, St. 35669; inedito, Mordeglia c.s. | Fig. 4 | ||
| 18 | Arona, Motto Lagone, t. 2 | 5D1 | GIIB | Museo Arch. Arona, St. 35636; inedito, Mordeglia c.s. | Fig. 7 | ||
| 19 | Arona, Motto Lagone t.1? | 5cD1 | X | GIIB | Museo Arch. Arona, St. 39085; inedito, Mordeglia c.s. | Fig. 8 | |
| 20 | Arona, Motto Lagone, t. 1 | 4aD1 | GIIB | Museo Arch. Arona, St. 35602; inedito, Mordeglia c.s. | Fig. 6 | ||
| 21 | Bellinzago Novarese, Reg. Abbasso del Motto, corredi non distinti | 4aD3 | Museo Arch. Novara, n. 177; Pauli 1971, taf. 42, 31; Casini 2000, n. 40; Spagnolo Garzoli, Gambari, dir. 2004, 187-188. | Fig. 6 | |||
| 22 | Bellinzago Novarese, Reg. Abbasso del Motto, corredi non distinti | 5bD1-D2 | Museo Arch. Novara, n. 178; Pauli 1971, taf. 42, 32; de Marinis 2010, p. 45; Casini 2000, n. 41; Spagnolo Garzoli, Gambari, dir. 2004, 187-188. | Fig. 7 | |||
| 23 | Briona, San Bernardino, corredi non distinti | 5b | Pauli 1971, taf. 42, 10; de Marinis 2010, 45 e nota 184; Casini 2000, n. 36. | / | |||
| 24 | Briona, San Bernardino, corredi non distinti | 5aD1 | Pauli 1971, taf. 42, 11; de Marinis 2010, 45 e nota 184; Casini 2000, n. 35. | / | |||
| 25 | Briona, San Bernardino, t. 29/5 | 5cD1 | GIIB | Musei Reali Torino, inv. Barocelli 9009; Pauli 1971, taf. 40, 5; de Marinis 2010, 45 e note 184, 186; Casini 2000, n. 39. | Fig. 11 | ||
| 26 | Briona, San Bernardino, tumulo XXXIV, t. 1 | 5cD1 | X | GIIB | Musei Reali Torino; Gambari 1987, tav. XXVI, a5; Casini 2000, n. 38. | / | |
| 27 | Briona, San Bernardino, sporadico | 4aD1 | Museo Arch. Novara, n. 158; Pauli 1971, taf. 34, 3; Casini 2000, n. 37. | Fig. 6 | |||
| 28 | Briona/Castelletto Ticino | 3c | Museo Arch. Novara, n. 179; inedito. | Fig. 5 | |||
| 29 | Briona/Castelletto Ticino | 5cD1 | X | Museo Arch. Novara, n. 176; inedito. | Fig. 8 | ||
| 30 | Castelletto Ticino, t. 54 | 5aD1 | Musei Reali Torino, St. 2203; Pauli 1971, taf. 27, 8; Casini 2000, n. 78; de Marinis 2010, 45. | Fig. 10 | |||
| 31 | Castelletto Ticino, t. 27 | 5a | Musei Reali Torino, St. 5234, inv. Barocelli 2075; Pauli 1971, taf. 19, 2; Casini 2000, n. 76. | Fig. 10 | |||
| 32 | Castelletto Ticino, t. 45 | 5c | X | GIIB | Musei Reali Torino, St. 2170; Pauli 1971, taf. 24, 3; Casini 2000, n. 74. | Fig. 12 | |
| 33 | Castelletto Ticino, t. 48 | 5bD2 | GIIB | Musei Reali Torino, St. 2139; Pauli 1971, taf. 25, 28; Casini 2000, n. 75; de Marinis 2010, 45; Spagnolo Garzoli, Gambari, dir. 2004, 277. | Fig. 10 | ||
| 34 | Castelletto Ticino, t. 21 | 1aD1 | GIC | Musei Reali Torino St. 5201; Pauli 1971, taf. 16, 16; Gambari, Venturino Gambari 1997, fig. 6, 8; Casini 2000, n. 77. | Fig. 3 | ||
| 35 | Castelletto Ticino, Bosco del Monte, tomba | 5cdD1 | X | GIIB | Museo Arch. Milano, A 0.9. 4885; Castelletti 1968, n. 9; de Marinis 1998, 288, fig. 5, 6; Casini 2000, n. 61. | Fig. 11 | |
| 36 | Castelletto Ticino, C.na Oldrini, tomba 1874 | 5 | GIIB | de Marinis 1998, 303-304; Casini 2000, n. 73 ; de Marinis 2022, 646-649. | / | ||
| 37 | Castelletto Ticino, Dorbiè Sup., t. 4 | 5D2 | X | GIIB | Musei Reali Torino, St. 62330; Ruffa 1998, tav. I, 3; de Marinis 2010, 45. | / | |
| 38 | Castelletto Ticino | 5cD1 | Museo Arch. Novara, n. 1131; inedito. | Fig. 8 | |||
| 39 | Castelletto Ticino | 5aD1 | Museo Arch. Novara, n. 1132; inedito, foto in Spagnolo Garzoli, Gambari, dir. 2004, 271. | Fig. 8 | |||
| 40 | Castelletto Ticino | 5cD1 | Museo Arch. Novara, n. 1133; inedito, foto in Spagnolo Garzoli, Gambari, dir. 2004, 264. | Fig. 8 | |||
| 41 | Castelletto Ticino | 5D1 | X | Museo Arch. Novara, n. 1134; inedito. | Fig. 12 | ||
| 42 | Castelletto Ticino | 2c | Museo Arch. Novara, n. 1129; inedito. | Fig. 4 | |||
| 43 | Castelletto Ticino | 1b | Museo Arch. Novara, n. 1130; inedito. | Fig. 3 | |||
| 44 | Castelletto Ticino | 5a | Museo Arch. Novara, n. 175; inedito, foto in Spagnolo Garzoli, Gambari, dir. 2004, 264. | Fig. 8 | |||
| 45 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 1cD3 | X | Noseda 2001-2002, p. 94, n. 73. | / | ||
| 46 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 2 | Noseda 2001-2002, p. 94, n. 74. | / | |||
| 47 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 4a | X | Museo Arch. Como, D1051; Castelletti 1968, n. 22; Casini 2000, n. 81; Roncoroni 2005, tav. 17, 164. | / | ||
| 48 | Castelletto Ticino, coll. Garovaglio | 5aD1 | Museo Arch. Como, D1052; Castelletti 1968, n. 12; Casini 2000, n. 85; Roncoroni 2005, tav. 17, 163; de Marinis 2010, 45. | / | |||
| 49 | Castelletto Ticino, coll. Garovaglio | 2cD1 | Museo Arch. Como, D1049; Castelletti 1968, n. 21; Casini 2000, n. 86; Roncoroni 2005, tav. 17, 161. | / | |||
| 50 | Castelletto Ticino, coll. Garovaglio | 5aD1 | Museo Arch. Como, D1050; Castelletti 1968, n. 10; Casini 2000, n. 84; Roncoroni 2005, tav. 17, 162. | / | |||
| 51 | Castelletto Ticino, coll. Garovaglio | 1cD1 | X | Museo Arch. Como, D1048; Castelletti 1968, n. 23; Casini 2000, n. 82; Roncoroni 2005, tav. 17, 160. | / | ||
| 52 | Castelletto Ticino, coll. Garovaglio | 1cD1 | Museo Arch. Como, D1047; Castelletti 1968, n. 24; Casini 2000, n. 83; Roncoroni 2005, tav. 17, 159. | / | |||
| 53 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 1D1 | X | Museo Arch. Como, E16811; Castelletti 1968, n. 15; Casini 2000, n. 92. | / | ||
| 54 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 1D1 | Museo Arch. Como, E16810; Castelletti 1968, n. 14; Casini 2000, n. 91. | / | |||
| 55 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 1D1 | X | Museo Arch. Como, E16806; Castelletti 1968, n. 18; Casini 2000, n. 93. | / | ||
| 56 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 3c | Museo Arch. Como, E16807; Castelletti 1968, n. 26; Casini 2000, n. 89. | / | |||
| 57 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 1c | Museo Arch. Como, E16809; Castelletti 1968, n. 19; Casini 2000, n. 95. | / | |||
| 58 | Castelletto Ticino, coll. Quaglia | 3a | Museo Arch. Como, E16808; Castelletti 1968, n. 25; Casini 2000, n. 89. | / | |||
| 59 | Castelletto Ticino, loc. Mottofalco | 5bD1 | Museo Arch. Sesto Calende, St 5531; Casini 2000, n. 79, fig. 15, 3 (indicato erroneamente in figura come da Sesto Calende, C.na Biassona). | Fig. 9 | |||
| 60 | Castelletto Ticino, C.na Riviera, abitato, n. 3 fermagli in fase lavorazione | 4 | GIIAB-GIIB | Ruffa 1999. | Fig. 17 | ||
| 61 | Castelletto Ticino, loc. Pozzola, t. 2 | 2D1 | GIIAB | Museo Arch. Arona, St. 62167; Ruffa 2024. | Fig. 4 | ||
| 62 | Castelletto Ticino, via Aronco, t. 7/1986 | 1aD1 | GIC | Inedito in studio E. Barbieri. | / | ||
| 63 | Castelletto Ticino, via Cosio, superficie | 5aD1 | Gelfi 2018-2019, tav. XLIII, 2-3. | / | |||
| 64 | Castelletto Ticino, via Cosio, t. 20/2007 | 1bD5 | GIC | Mordeglia, Gelfi 2023, fig. 14,4 | / | ||
| 146 | Castione (TI), Bergàmo | 5aD4 | Tessin B | Primas 1970, taf. 18, E3; Casini 2000, n. 121. | / | ||
| 65 | Como, Ca’ Morta, t. 4 | 3c | GIIAB | Museo Arch. Como; Rittatore 1966, tav. LXVIII; Casini 2000, n. 29. | / | ||
| 66 | Como, Ca’ Morta, t.II/1928 (Baserga) | 3cdD1 | GIIAB | Museo Arch. Como, E3551; Saronio 1968-69, tav. V, 25. | / | ||
| 67 | Como, Ca’ Morta, t.II/1928 (Baserga) | 3cD3 | GIIAB | Museo Arch. Como, E3550; Saronio 1968-69, tav. V, 25; Casini 2000, n. 30. | / | ||
| 68 | Como, Ca’ Morta, t. 177 sud | 5 | GIIB | Museo Arch. Como, E4396; Casini 2000, n. 31. | / | ||
| 147 | Giubiasco (TI), “t. 26” | 1dD1 | Tori et al. 2010, 98, 177, 263. | / | |||
| 69 | Golasecca, loc. Galliasco | 5adD1 | GIIB | Musée St. Germain en Laye, n. 17173 de Marinis 2010, fig. 9, 3. | / | ||
| 70 | Golasecca | 5cD1 | Museo Arch. Milano, A 0.9.27297; Castelletti 1968, n. 4; Casini 2000, n. 57. | Fig. 9 | |||
| 71 | Golasecca | n.d. | Museo Arch. Milano, A 0.9.28270; Castelletti 1968, n. 5; Casini 2000, n. 58. | / | |||
| 72 | Golasecca | 4c | Museo Arch. Milano, A 0.9.4839; Casini 2000, n. 54, inedito. | Fig. 6 | |||
| 73 | Golasecca | 5aD1 | Museo Arch. Milano, A 0.9.27296; Castelletti 1968, n. 3; Casini 2000, n. 56. | Fig. 9 | |||
| 74 | Golasecca, coll. Castelfranco | 4D1 | X | Museo Arch. Milano, A 0.9.28168; Casini 2000, n. 60, inedito. | Fig. 6 | ||
| 75 | Golasecca, coll. Garovaglio | 5b | X | Museo Arch. Como, D2072; Roncoroni 2005, tav. 17, 166. | / | ||
| 76 | Golasecca, coll. Garovaglio | 5b | Museo Arch. Como, D1046; Castelletti 1968, n. 16; Casini 2000, n. 97; Roncoroni 2005, tav. 17, 165. | / | |||
| 77 | Golasecca, coll. Garovaglio | 1c | Museo Arch. Como, D2789; Castelletti 1968, n. 17; Casini 2000, n. 94; Roncoroni 2005, tav. 17, 158. | / | |||
| 78 | Golasecca /Sesto Calende? Coll. Borromeo Isola Bella | 3a | Coll. Borromeo, n. 100; Casini 2000, nn. 63-67; inedito. | Fig. 5 | |||
| 79 | Golasecca/Sesto Calende? Coll. Borromeo Isola Bella | 5c | X | Coll. Borromeo, n. 101; Casini 2000, nn. 63-67; inedito. | Fig. 12 | ||
| 80 | Golasecca/Sesto Calende? Coll. Borromeo Isola Bella | 2D3 | Coll. Borromeo, n. 96; Casini 2000, nn. 63-67; inedito. | Fig. 4 | |||
| 81 | Golasecca/Sesto Calende? Coll. Borromeo Isola Bella | 5a | X | Coll. Borromeo, n. 97; Casini 2000, nn. 63-67; inedito. | Fig. 11 | ||
| 82 | Golasecca/Sesto Calende? Coll. Borromeo Isola Bella | 5b | Coll. Borromeo, n. 98; Casini 2000, nn. 63-67; inedito. | Fig. 11 | |||
| 83 | Golasecca/Sesto Calende? Coll. Borromeo Isola Bella | 5a | Coll. Borromeo, n. 99; Casini 2000, nn. 63-67; inedito. | Fig. 10 | |||
| 84 | Golasecca, scavi Labus 1852 | 4aD1 | GIIB | Museo Arch. Milano, A 0.9. 6116; Castelletti 1968, n. 1; Casini 2000, n. 52; de Marinis 2010, 45. | Fig. 6 | ||
| 85 | Golasecca, scavi Labus 1852 | 5bD1 | GIIB | Museo Arch. Milano, A 0.9. 6117; Castelletti 1968, n. 2; Casini 2000, n. 53; de Marinis 2010, 45. | Fig. 9 | ||
| 86 | Golasecca, Le Corneliane, coll. Castelfranco | 4D1 | X | Museo Arch. Milano, A 0.9.28246; Castelletti 1968, n. 7; Casini 2000, n. 42, inedito | Fig. 6 | ||
| 87 | Golasecca | 5a | Castelletti 1968, n. 30. | / | |||
| 132 | Golasecca, loc. Lazzaretto, tomba del 1886 | 5 | X | de Marinis 1992, fig. 2, 10 ; Casini 2000, n. 70. | / | ||
| 133 | Golasecca, loc. Monsorino, t. 16 | 5D1 | GIIB | Museo Arch. Sesto Calende, St. 2015.26.14; Grassi, Mangani dir. 2016, tav. XXVI, 3. | / | ||
| 134 | Golasecca, loc. Monsorino, t. 39 | 2 | GIIAB | St. 63415; Grassi, Mangani dir. 2016, tav. XXVII, 7. | / | ||
| 135 | Golasecca, loc. Monsorino, tomba, | 6c | X | GIIB | Museo Arch. Milano, A 0.9. 17883; Castelletti 1968, n. 8; de Marinis 1974, fig. 5, 3; Casini 2000, n. 43; Ruffa 2024, fig. 9,3. | Fig. 13 | |
| 88 | Ignota | 5aD1 | X | Museo Arch. Varese, MV5887; inedito. | Fig. 11 | ||
| 89 | Ignota | 2a | Museo Arch. Varese, MV5876; inedito. | Fig. 4 | |||
| 90 | Ignota | 3a | X | Museo Arch. Como, E17819; Castelletti 1968, n. 27; Casini 2000, n. 90. | / | ||
| 91 | Ignota | 3 | X | Museo Arch. Como, E17820; Castelletti 1968, n. 28. | / | ||
| 92 | Ignota | 1c | Museo Arch. Milano, A 0.9. 33731; inedito. | Fig. 3 | |||
| 93 | Ignota | 5bdD1 | Museo Arch. Milano, A 0.9. 33739; inedito. | Fig. 9 | |||
| 94 | Ignota | 5adD1 | Museo Arch. Milano, A 0.9. 33732; inedito. | Fig. 10 | |||
| 95 | Ignota | rett. n.d. | X | X | Museo Arch. Milano, A 0.9. 33734; inedito. | / | |
| 96 | Ignota | 4aD1 | Museo Arch. Milano, A 0.9. 33735; inedito. | Fig. 6 | |||
| 97 | Ignota | 1a | Museo Arch. Milano, A 0.9. 33729; inedito. | Fig. 3 | |||
| 98 | Ignota | 2 | X | Museo Arch. Milano, A 0.9. 33730; inedito. | Fig. 4 | ||
| 99 | Ignota | 5bD1 | Museo Arch. Milano, A 0.9. 33733; inedito. | Fig. 9 | |||
| 100 | Ignota | 5a | Museo Naz. Atestino; Gonzato et al. 2019, tav. I, 6. | / | |||
| 101 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | 5c | Inedito, Cat. Gen. 171616. | / | |||
| 102 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | 4c | Inedito, Cat. Gen. 171617. | / | |||
| 103 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | 2c | Inedito, Cat. Gen. 171619. | / | |||
| 104 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | 3a | Inedito, Cat. Gen. 171614. | / | |||
| 105 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | 4a | Inedito, Cat. Gen. 171615. | / | |||
| 106 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | 4a | Inedito, Cat. Gen. 171620. | / | |||
| 107 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | 1a | Inedito, Cat. Gen. 171621. | / | |||
| 108 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | 3a | X | Inedito, Cat. Gen. 171618. | / | ||
| 109 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | rett. n.d. | Inedito, Cat. Gen. 171622a. | / | |||
| 110 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | rett. n.d. | Inedito, Cat. Gen. 171622c. | / | |||
| 111 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | rett. n.d. | Inedito, Cat. Gen. 171622b. | / | |||
| 112 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | rett. n.d. | Inedito. | / | |||
| 113 | Ignota, coll. Visconti di S. Vito | rett. n.d. | Inedito. | / | |||
| 114 | Ignota, coll. Bellini | 5cD1 | Museo Arch. Sesto Calende; Barbieri 2023, tav. 87. | / | |||
| 115 | Ignota, coll. Bellini | 5cD1 | Museo Arch. Sesto Calende; Barbieri 2023, tav. 88. | / | |||
| 116 | Ignota, coll. Bellini | 4aD1 | Museo Arch. Sesto Calende; Barbieri 2023, tav. 91. | / | |||
| 117 | Ignota, coll. Bellini | 2a | Museo Arch. Sesto Calende; Barbieri 2023, tav. 90. | / | |||
| 139 | Ignota, coll. Ponti | 2 | Museo Arch. Varese, MV4028; inedito. | Fig. 4 | |||
| 140 | Ignota, coll. Ponti | 2a | X | Museo Arch. Varese, MV4048; inedito. | Fig. 4 | ||
| 141 | Ignota, coll. Ponti | 2c | X | Museo Arch. Varese, MV4042; inedito. | Fig. 4 | ||
| 142 | Ignota, coll. Ponti | 4c | Museo Arch. Varese, MV4046; inedito. | Fig. 6 | |||
| 143 | Ignota, coll. Ponti | 1a | X | Museo Arch. Varese, MV4047; inedito. | Fig. 3 | ||
| 118 | Malgesso, tomba del 1871 | 5a | Museo Arch. Varese, MV6045; Primas 1970, taf. 15, A2; Casini 2000, n. 100, de Marinis 2017, fig. 39. | Fig. 10 | |||
| 119 | Malgesso, tomba del 1871 | 6cD1 | Museo Arch. Varese, MV6046; Casini 2000, n. 100, de Marinis 2017, fig. 39. | Fig. 13 | |||
| 120 | Parre, ripostiglio | 3cD4 | Casini 2000, n. 28, fig. 14, 1. | / | |||
| 121 | Pombia, loc. Cimitero, t. 1/2010 | 6bD1 | X | GIIAB | Spagnolo Garzoli et al. 2012, fig. 95. | Fig. 13 | |
| 122 | Pombia, loc. Monticello, t. 1/1993 | 2c | GIIAB | Di Maio et al. 2001, fig. 17, 11. | / | ||
| 123 | Pombia, loc. Monticello, t. 2/1993 | 4c | GIIB | Di Maio et al. 2001, fig. 19, 9. | / | ||
| 124 | Pombia, loc. Monticello, t. 4/1993 | 4a | GIIB | Di Maio et al. 2001, fig. 26, 8. | / | ||
| 125 | Pombia, loc. Quara, t. 3/1995 | 4a | GIIB | Di Maio et al. 2001, fig. 49, 8. | / | ||
| 126 | Pombia, loc. Quara, t. 8/1995 | 2c | GIIAB | Di Maio et al. 2001, fig. 61, 5. | / | ||
| 127 | Pombia, loc. Quara, t. 14/1995 | 4c | GIIB | Di Maio et al. 2001, fig. 72, 10. | / | ||
| 128 | Pressagona (TI), t. 2 | 1a | GIIAB | Primas 1970, taf. 48, B7; Casini 2000, n. 2; Schindler, de Marinis 2000, fig. 12, 2. | / | ||
| 129 | Sesto Calende, loc. Oriano | 5D1 | Museo Arch. Domodossola, n. 82/132a; inedito. | Fig. 12 | |||
| 130 | Sesto Calende, loc. Oriano | rett. n.d. D1 | Museo Arch. Domodossola, n. 82/132b; inedito. | / | |||
| 131 | Sesto Calende, C.na Bassona | 3D1 | X | Museo Arch. Sesto Calende, St. 5634; Casini 2000, n. 72. | Fig. 5 | ||
| 136 | Sesto Calende, loc. Mulini Bellaria, t. 4 (del tripode) | 5cD1 | GIIB | Museo Arch. Sesto Calende, St. 23774a; Casini 2000, n. 69; de Marinis 2009, fig. 14, 8. | / | ||
| 137 | Sesto Calende, loc. Mulini Bellaria, t. 1 | 6cD1 | GIIB | Museo Arch. Sesto Calende, St. 23716; inedito. | Fig. 13 | ||
| 138 | Sesto Calende, loc. Presualdo | 5 | X | GIIB | Museo Arch. Milano, A 0.9. 4840; Casini 2000, n. 55, inedito | Fig. 11 | |
| 144 | S. Ilario d’Enza, loc. Fornaci, t. 13 | 3cD1 | Este III C | Damiani et al. 1992, tav. LXXXVIII, 1381; Casini 2000, n. 2; Zamboni 2018, 109-113, fig. 63, 13.1; 177, fig, 100, 1. | / | ||
| 145 | Oppeano t. 2 1981 | 3a | VI a.C. | Salzani 2018, 89, tav. 21, 12. | / |
Bibliographie
NAB = Notizie Archeologiche Bergomensi
QuadAPiem = Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte
QuadAPiem n.s. = Quaderni di Archeologia del Piemonte
RAC = Rivista Archeologica Comense
Barbieri, E. (2023): “La collezione Bellini al Civico Museo Archeologico di Sesto Calende. Analisi della collezione Bellini e dei suoi reperti”, Ziku. Studi sulla cultura celtica di Golasecca, V, 13-96.
Bedini, E. (2001): “I resti scheletrici umani”, in: Gambari, F.M., dir., La birra e il fiume. Pombia e le vie dell’Ovest Ticino tra VI e V secolo a.C., Torino, 99-105.
Casini, S. (2000): “Ritrovamenti ottocenteschi di sepolture della cultura di Golasecca in territorio bergamasco”, NAB, 6 (1998), 109-161.
Casini, S. (2017): “La necropoli golasecchiana di Brembate Sotto (Bergamo)”, NAB, 15 (2007).
Castelletti, L. (1968): “Placche di cinturone decorate della cultura di Golasecca”, in: Studi in onore di Pia Laviosa Zambotti, Rendiconti dell’Istituto Lombardo, Classe di Lettere, Scienze Morali e Storiche, Milano, 101, f. II, 227 sgg.
Damiani, I., Maggiani, A., Pellegrini, E., Saltini, A.C. e Serges, A. (1992): L’età del Ferro nel Reggiano. I materiali delle collezioni dei Civici Musei di Reggio Emilia, Cataloghi dei Civici Musei di Reggio Emilia, 12, Reggio Emilia.
de Marinis, R.C. (1974): “La situla di Trezzo (Milano)”, Varia Archeologica, Posavski Musej Brezice, 1, 67-86.
de Marinis, R. C. (1982): “La ceramica della prima tomba di guerriero di Sesto Calende e nuove osservazioni sulla cronologia del Golasecca I”, RAC, 163 (1981), 5-35.
de Marinis, R.C. (1992): “Tomba con situla bronzea dal Lazzaretto di Golasecca”, Sibrium, XXI, 1990-91, 157-200.
de Marinis, R.C. (1998): “Gli scavi di Pompeo Castelfranco a Castelletto Ticino”, in: Preistoria e Protostoria del Piemonte, Atti della XXXII Riunione Scientifica I.I.P.P., Alba, 29 settembre-1° ottobre 1995, 279-295.
de Marinis, R.C. (2009): “La necropoli di Mulini Bellaria di Sesto Calende (scavi 1977-1980)”, in: De Marinis, R. C., Massa, S. e Pizzo, M., dir., Alle origini di Varese e del suo territorio. Le collezioni del sistema archeologico provinciale, Roma, 431-454.
de Marinis, R.C. (2010): “Materiali della cultura di Golasecca conservati al Musée des Antiquités Nationales di Saint-Germain-en-Laye”, NAB, 16 (2008), 21-65.
de Marinis, R.C. (2017): “La prima età del Ferro”, in: Harari, M., dir., Il territorio di Varese in età preistorica e protostorica, La storia di Varese, vol. III, Busto Arsizio, 197-237.
de Marinis, R. C. (2019): “Le ciste a cordoni a manici mobili nella cultura di Golasecca”, in: Baitinger, H. e Schönfelder, M., dir., Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Monographien 154, 431-452.
de Marinis, R.C. (2022): “Scavi ottocenteschi nelle necropoli di Golasecca.Sesto Calende-Castelletto Ticino”, in: de Marinis, R.C. e Rapi, M., dir., Presitoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino, Atti della LII Riunione Scientifica dell’Istituto Italia di Preistoria e Protostoria, 17-21 novembre 2017, Rivista di Scienze Preistoriche, 72, S2, 637-650.
Di Maio, P., Gambari, F.M., Gernetti, F., Pirotto, S. e Squarzanti, M. (2001): “I corredi e i reperti”, in: Gambari, F.M., dir., La birra e il fiume. Pombia e le vie dell’Ovest Ticino tra VI e V secolo a.C., Torino, 25-92.
Gambari, F.M. (1987): “La necropoli di San Bernardino di Briona: revisione critica alla luce dei risultati preliminari dei nuovi scavi”, QuadAPiem, 6, 63-95.
Gambari, F.M. e Venturino Gambari, M. (1997): “Corredo di tomba a cremazione a pozzetto da Castelletto Ticino (NO)”, in: Endrizzi, L. e Marzatico, F., dir., Ori delle Alpi, Quaderni della Sezione Archeologica, Castello del Buonconsiglio 6, Trento, 341-347.
Gamsen 3A = Paccolat, O., Curdy, P., Deschler-Erb, E., Haldimann, M-A. e Tori, L. et al. (2019): L’habitat alpin de Gamsen (Valais, Suisse). 3A. Le mobilier archéologique : étude typologique (Xe s. av. – Xe s. apr. J.-C.), Cahiers d’archéologie romande 180, Archaeologia Vallesiana 17, Lausanne.
Gamsen 3B = Paccolat, O., Curdy, P., Deschler-Erb, E., Haldimann, M-A. e Tori, L. et al. (2019): L’habitat alpin de Gamsen (Valais, Suisse). 3B. Le mobilier archéologique: catalogue et planches, Cahiers d’archéologie romande 181, Archaeologia Vallesiana 18, Lausanne.
Gelfi, N. (2018-2019): Le tombe di Via Cosio a Castelletto sopra Ticino nell’ambito della cultura di Golasecca, tesi di laurea, Università Sacro Cuore di Milano.
Giumlia-Mair, A. (1998): “Studi metallurgici sui bronzi della necropoli di S. Lucia-Most Na Soči”, Aquileia Nostra, anno LXIX, 29-134.
Gonzato, F., Grassi, B., Mangani, C. e Voltolini, D. (2019): “«Può riuscire infatti assai utile fornire ai visitatori». Gli scambi di reperti delle età del Ferro fra il Museo Nazionale Atestino e i Musei Civici di Varese”, Ziku. Studi sulla cultura celtica di Golasecca, III, 29-46.
Grassi, B. e Mangani, C., dir. (2016): Nel bosco degli antenati. La necropoli del Monsorino di Golasecca (scavi 1985-1986), Firenze.
Mordeglia, L. e Gelfi, N. (2023): “Le tombe golasecchiane di via Cosio a Castelletto Sopra Ticino (Novara)”, QuadAPiem, n.s., 7, pp. 11-32.
Noseda, A. (2001-2002): La collezione Quaglia al Museo Archeologico di Como e al Museo “L. Pigorini” di Roma. Contributo allo studio della cultura di Golasecca, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano.
Pacciarelli, M. (2007): “Identità di genere e corredi femminili nelle grandi necropoli della prima età del Ferro dell’Italia meridionale”, in: Von Eles, P., dir., Le ore e i giorni delle donne: dalla quotidianità alla sacralità tra VIII e VII secolo a.C., Catalogo della mostra (Verucchio, 14 giugno 2007-6 gennaio 2008), Verucchio, 117-124.
Paltineri, S. (2010): La necropoli di Chiavari. Scavi Lamboglia (1959-1969), Istituto Internazionale di Studi Liguri, Collezione di monografie Preistoriche ed Archeologiche, XVII, Bordighera.
Paltineri, S. e Venturino, M. (2023): “Indicatori di attività tessili nelle necropoli golasecchiane occidentali della prima età del Ferro” in: Caramella, L., dir., Dall’acqua alla terra: cambiamenti nell’occupazione del territorio, Atti delle Giornate di Studi, Varese, 20 novembre – Golasecca, 21 novembre 2021, Sibrium Atti 1, 379-413.
Pauli, L. (1971): Studien zur Golasecca Kultur, München.
Primas, M. (1970): Die südschweizerischen Grabfunde der älteren Eisenzeit und ihre chronologie, Monographien zur Ur-und-Frühgeschichte der Schweiz 16, Basel.
Repetto, A. (1980): Antiquarium Laumellinum Antona, Guida al Museo Civico Archeologico, Gropello Cairoli.
Roncoroni, F. (2005): La cultura di Golasecca nella collezione Garovaglio. L’area occidentale, Archeologia dell’Italia Settentrionale 10, Musei Civici, Como.
Rubat Borel, F. (2009): “Note di tipologia su alcuni elementi di parure dei ripostigli bronzei di Chiusa Pesio”, QuadAPiem, 27, 9-27.
Ruffa, M. (1998): “La necropoli protostorica di Dorbié Superiore-Castelletto Ticino”, QuadAPiem, 15, 13-39.
Ruffa, M. (1999): “Tre fermagli di cintura da Castelletto Ticino”, QuadAPiem, 16, 29-36.
Ruffa, M. (2012): “Produzione metallurgica a Santo Spirito-Gropello Cairoli (PV)”, NAB, 18 (2010), 99-131.
Ruffa, M. (2021): Garlasco (PV), loc. Madonna delle Bozzole, tombe golasecchiane. Revisione dei materiali, NAB, 29, 85-122.
Ruffa, M. (2023): “Un accessorio femminile: i fermagli di cintura golasecchiani in bronzo triangolari e rettangolari. Studio preliminare”, in: Dall’acqua alla terra: cambiamenti nell’occupazione del territorio, Atti delle Giornate di Studi, Varese, 20 novembre – Golasecca, 21 novembre 2021, Sibrium Atti 1, 449-469.
Ruffa, M. (2024): “Corredi inediti con fermagli di cintura dall’area occidentale della cultura di Golasecca”, in: Caramella, L., dir., Insubres sumus, non Latini. Fonti, archeologia e cultura artistica per i 70anni del Centro di Sudi Preistorici e Archeologici di Varese, Atti della Giornata di Studi, Golasecca, 10 novembre 2023,Sibrium Atti, 2, 231-245.
Salzani, L. (2018): Necropoli dei Veneti antichi a Ca’ del Ferro di Oppeano (Verona), Documenti di Archeologia 60.
Saronio, P. (1968-69): “Revisione dei corredi di alcune tombe della Ca’ Morta”, RAC, 150-151, 47-98.
Schindler, M. P. (1998): Il ripostiglio di Arbedo TI e i ripostigli di bronzo della regione alpina dal VI all’inizio del IV sec. a.C., Antiqua 30, Basel.
Schindler, M. P. e de Marinis, R.C. (2000): “L’età del Ferro nel Canton Ticino e nella Mesolcina”, in: de Marinis, R. C. e Biaggio Simona, S., dir., I Leponzi tra mito e realtà, Locarno, I, 159-183.
Spagnolo Garzoli, G., Rubat Borel, F., Cerri, R. e Squarzanti, M. (2012): “Pombia, località Cimitero. Sepolture a incinerazione della cultura di Golasecca”, QuadAPiem, 27, 253-256.
Spagnolo Garzoli, S. e Gambari, F.M., dir. (2004): Tra terra e acque. Carta Archeologica della Provincia di Novara, Torino.
Tori, L. (2019): Costumi femminili nell’arco sud-alpino nel I millennio a.C., Collectio Archælogica 10, Zürich.
Tori L., Carlevaro, E., Della Casa, P., Pernet, L. e Schmid-Sikimić, B. (2010): La necropoli di Giubiasco (TI). Le tombe dell’età del Bronzo della prima età del ferro e del La Tène antico e medio. La sintesi, Vol. III, Collectio Archælogica 8, Zürich.
Zamboni, L. (2018): Sepolture arcaiche della pianura emiliana. Il riconoscimento di una società di frontiera, Reditus-Riflessioni di Archeologia 1, Roma.
Notes
- Desidero dedicare questo lavoro a Filippo M. Gambari, ispiratore di questa ricerca, ricordandone la disponibilità e l’amicizia.
- Casini 2000, 131-135, 155-158.
- Numerose sono le persone che con il loro appoggio e la loro disponibilità mi hanno permesso di visionare e pubblicare i materiali. Grazie a Daniela Locatelli (SABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese) e Lucia Mordeglia (SABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli) per avermi autorizzato lo studio dei reperti di proprietà statale. Desidero inoltre ringraziare i direttori e i conservatori dei musei archeologici che, con grande cortesia, mi hanno facilitato l’accesso alle loro collezioni: Barbara Cermesoni (Museo Archeologico di Varese), Elena Poletti (Museo Archeologico di Arona e di Domodossola), Anna Provenzali, Sara Loreto e Milly Lattanzio (Civico Museo Archeologico di Milano), Mauro Squarzanti (Museo Archeologico di Sesto Calende). Desidero altresì ringraziare il Comune di Novara, che mi ha concesso l’accesso ai suoi magazzini, e Serena Sogno, curator della collezione Borromeo Isola Bella, che mi hanno consentito l’analisi dei fermagli di loro proprietà. Ringrazio Franco Marostegan del Gruppo Archeologico di Castelletto Sopra Ticino che, aprendomi la loro sede, mi ha messo nelle condizioni di poter disegnare un fermaglio da Pombia. Sono grata a Elena Barbieri, Nicoletta Gelfi e Alessandra Noseda che mi hanno riferito i dati delle loro tesi di specializzazione e dei materiali che hanno in corso di studio e pubblicazione. I fermagli conservati presso i Musei Reali di Torino sono stati studiati solo recentemente e per questa possibilità ringrazio Simona Contardi e Alessia Monticone per l’attenzione e la disponibilità nei miei confronti.
- SIRBeC: Sistema Informativo Regionale Beni Culturali-Regione Lombardia. Un preliminare lavoro sui fermagli di cintura è stato pubblicato negli atti del convegno di Golasecca del 2021 (Ruffa 2023); rispetto a quanto pubblicato è stata ridefinita la tipologia e la scansione cronologica.
- Damiani et al. 1992, tav. LXXXVIII, 1381; Zamboni 2018, fig. 63, 13.1.
- Salzani 2018, 89, tav. 21, 12.
- Da attribuire a un fermaglio di forma rettangolare è forse anche il frammento rinvenuto a Brig Gamsen (VS), da strato non databile (Gamsen 3A, 92; Gamsen 3B, 448, pl. 21, 438).
- Rubat Borel 2009, 22-23.
- Rubat Borel 2009, 19-23.
- Comunicazione personale di Elena Barbieri che ha in studio la necropoli e che ringrazio per la disponibilità.
- Gambari & Venturino Gambari 1997, 342.
- de Marinis 1982, 29, nota 39.
- Per una definizione del tipo di fibula: Casini 2017, 112-113.
- Mordeglia & Gelfi 2023, fig. 14, 4.
- Paltineri 2010, tav. 114, 88, 2.
- Pauli 1971, taf. 8, 4; de Marinis 1982, tav. XII, 4.
- Una proposta in questo senso, che considerava il rapporto tra larghezza e lunghezza, era già stata avanzata nella pubblicazione della necropoli di Pombia, definito tipo A (Di Maio et al. 2001, 31).
- I parametri di misurazione risultano particolarmente importanti nella definizione dei diversi tipi. Il gancio è stato generalmente compreso nella misura della lunghezza, quando questo non sia particolarmente deformato e/o allungato, perché tale misura fornisce quella che era la forma visibile del fermaglio indossato; in ogni caso sulla base dei rapporti delle misure noti è comunque possibile molto spesso attribuire fermagli privi di gancio o frammenti di fermagli ai diversi tipi.
- Del fermaglio sono conservati tre frammenti di piccole dimensioni (1,5x 1,3 cm; 2,6×1,95 cm; 1,3×0,8 cm); uno dei frammenti corrisponde a una piccola porzione dalla parte del gancio.
- Barbieri 2023, 62, fig. 109, tav. 89.
- Ruffa 1999.
- I fermagli in lavorazione non sono stati considerati nei diversi grafici di frequenza.
- Ruffa 2012, 103-108.
- La forma di fusione non è stata individuata tra i materiali conservati nei magazzini del Museo Nazionale della Lomellina e il disegno presentato è ricavato da Repetto 1980; non c’è ragione di pensare che il disegno non sia esatto, fatta eccezione forse per l’eccessiva regolarità delle scanalature che facilitavano lo scorrimento del metallo.
- Ruffa 2021 e 2023.
- Nessun fermaglio tra quelli noti è stato rinvenuto in abitato.
- Ruffa 2024, 164, tabella per tombe e componenti dei corredi; nella tabella pubblicata non è stato inserito il corredo della sepoltura di Arbedo, Cerinasca t. 3 (fermaglio n. 7).
- Castelletti 1968, 239.
- Tra questi tre passanti da Golasecca e Castelletto Sopra Ticino, conservati non associati a fermagli, sono nella Collezione Garovaglio (Roncoroni 2005, tav. 17, 167-169).
- I fermagli sono stati disegnati e fotografati sempre con il gancio verso sinistra per uniformità nella documentazione.
- Tori 2019, 100-105, a titolo di esempio: tav. 4, n. 36 e tav. 21, n. 179.
- Piccole borchie sono nella t. 16 della necropoli del Monsorino di Golasecca (Grassi & Mangani 2016, tav. XXVI, 3); nella t. 1 (inedita) e nella t. 2 della necropoli di Mulini Bellaria a Sesto Calende (de Marinis 2009, 443); nella t. 20/2007 necropoli di via Cosio a Castelletto Sopra Ticino (Mordeglia & Gelfi 2023, fig. 14, 6).
- Rubat Borel 2009, tav. IV, c, 7.
- Zamboni 2018, fig. 101 per la distribuzione del tipo.
- Ringrazio Anna Provenzali, direttrice del Civico Museo Archeologico di Milano, per aver consentito l’esecuzione delle indagini e i conservatori del Museo Sara Loreto e Cristina Miedico per l’assistenza e la disponibilità dimostratami. Sono davvero grata a Letizia Bonizzoni a cui si devono le analisi ED-XRF e a Marco Gargano che ha eseguito le lastre a raggi X ed elaborato le immagini, entrambi afferenti al Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli dell’Università degli Studi di Milano; un ringraziamento anche a Ginevra Cappello che, sotto la guida della prof.ssa Bonizzoni, ha redatto una relazione preliminare interpretando i dati raccolti relativi alle analisi ED-XRF.
- A fronte di 56 prelievi in totale sono stati considerati per l’analisi quantitativa solo otto punti di indagine relativi a sette fermagli; l’elevata presenza di calcio in superficie introduce un fattore di attenuazione della radiazione non valutabile che altera però la possibilità di calcolo delle percentuali degli elementi presenti.
- Uno studio sulla resa decorativa dal punto di vista tecnologico, attualmente in fase di ipotesi, potrebbe portare ad una maggiore comprensione dell’intero ciclo produttivo.
- Giumlia Mair 1998, 35-36.
- Bedini 2001.
- Di Maio et al. 2001, 28-32 e 53-57.
- Di Maio et al. 2001, 33-38 e 62-64.
- Pacciarelli 2007, 117.
- Ruffa 2024, 149-153; il corredo bronzeo è costituito da un’armilla a capi sovrapposti e il fermaglio di cintura n. 8.
- Pauli 1971, taf. 25; il corredo è composto da una cista bronzea, un bicchiere, una fibula a sanguisuga a intarsi circolari, diverse fibule ad arco serpeggiante e a drago, due perle in pasta vitrea, un passante per cintura e il fermaglio n. 33; dubbi sull’attendibilità del corredo sono espressi in de Marinis 2019, 438.
- Gambari & Venturino Gambari 1997, fig. 6; il corredo è costituito da un’urna biconico arrotondata decorata a triangoli campiti a tratteggio, tre coppe su medio/basso piede, due armille a estremità sovrapposte, un filo di bronzo avvolto a spirale, due anelli, un frammento di lamina bronzea, due passanti per cintura e il fermaglio n. 34 (più una fibula a sanguisuga di tipo pre tardo alpino estranea al corredo, vd. supra per quanto riguarda le problematiche relative a questa sepoltura).
- Gambari 1987, 78, tav. XXVI, a; il corredo è formato da un’urna a stralucido contenente ossa combuste, un’olletta a stralucido, due fibule ad arco serpeggiante rinvenute fuori dall’urna in due differenti aree carboniose sul fondo della fossa e il fermaglio n. 26 rinvenuto all’interno dell’urna; la sepoltura è stata interpretata come bisoma.
- Paltineri & Venturino 2023, 393-395, 402-403.
- Un approfondimento sulle componenti dei corredi in relazione al genere è stato presentato al convegno di Mergozzo “Non omnis moriar. Novità da scavi e studi di contesti funerari della Cisalpina” nell’ottobre del 2024 ed è in corso di stampa.
- Le sepolture sono attualmente in corso di studio da parte di Silvia Paltineri che ringrazio per la comunicazione.