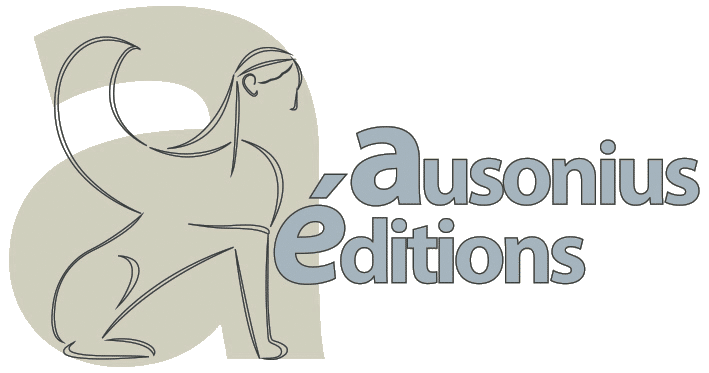The article is based on the PhD Dissertion ‘Costumi femminili nell’arco sud-alpino nel I millennio a.C. Tra archeologia sociale e antropologia’ (Tori 2019). Aim is to illustrate, an hand of the leaf-shaped ‘Ticino-style’ belt plates from the 6th and 5th centuries BC, methodologies and research perspectives that can be applied independently of the specific field of investigation. Three focuses have been here chosen:
REPAIRS – The history of belt was complex and not always linear: They were worn, discarded, hoarded, deformed and modified. The repairs to belts that can frequently be observed testify to the importance and value attached to such worn objects – which far exceeded their worth as purely functional items. An excellent example is that of leaf-shaped ‘Ticino-style’ belt plates from the 6th and 5th centuries BC, which feature almost symmetrical repairs. Cracks developed, as one would expect, in the weak points of the design, i.e. places where the material was subject to strain or under tension. Repairs seem to have been carried out rapidly and in a relatively crude manner – no attempt was made to retain decorative schemes, and minor imperfections were tolerated. Due to a marked technical and qualitative discrepancy between the workmanship involved in the manufacture of such belt plates and that employed in repairing them, it must be assumed that it was not the same craftsperson that was responsible in both cases. The hasty execution of the repairs need not suggest a failing on the part of the craftsperson, but rather that it was imperative that the owner of the damaged items could continue to wear them as they reflected the senior status of the wearer and signified that she had experienced certain events in her life.
SYMBOLIC – Belts are vehicles for symbols and messages: Spoked wheels, waterfowl, horses, cattle and anthropomorphic forms – the figurative representations seen on metal objects found in the canton of Ticino were inspired by a rich repertoire of images that can be traced back to the Bronze Age. It is not only the figures, but also the style in which they are represented that has been appropriated from earlier traditions and combined into a compact and structured code – a kind of iconographic programme. The depictions of the figures are executed with precise lines, yet they are all stylized: the forms have been simplified and reduced to outlines, and the motifs appear very static. This by no means rudimentary style had a concrete aim: it was intended to call to mind images that were anchored in the memory. GENDER – Archaeological findings from Early Iron Age graves in Ticino allow us in most cases to ascertain, in accordance with available anthropological data, a range of gender-specific grave goods. The following tendencies were identified between the 6th and the 5th century B.C.: 1) Despite certain time-specific variations, seriation and correspondence analysis invariably shows two distinct grave clusters: the grave goods of the first cluster appear rarely or never together with the grave goods of the second cluster. The types of grave goods in the first cluster comprise navicella and sanguisuga fibulae, earrings, bronze belt plates and pearl necklaces; those of the second cluster comprise snake-shaped fibulae, Certosa or drago fibulae and tools. On the basis of the anthropological data available, the first and second clusters correspond to female and male gender respectively 2) Graves that can, according to the anthropological data available, be attributed to individuals who died young generally belong to clusters characterized by a less complex ‘Tracht’. 3) On the contrary, bronze belts allow us to draw conclusions regarding not only an individual’s gender (female) but also age (adult) and the role played within the community. 5) The general impression created by the graves examined was that most of the individuals interred had lived in relative prosperity. The ‘female’ graves could be differentiated exclusively on the basis of an abundance of jewellery (particularly fibulae), which can be interpreted as a sign of great prosperity. Male burials sites, on the other hand, can be distinguished by the presence of bronze vessels.
L’articolo che segue è tratto dalla tesi di dottorato “Costumi femminili nell’arco sud-alpino nel I millennio a.C. Tra archeologia sociale e antropologia”1 ed illustra, sulla base delle sole placche da cintura di tipo ticinese, metodologie e prospettive di ricerca applicabili indipendentemente dall’ambito specifico d’indagine.
Nella definizione del tema di dottorato che risale al 2006 si decise di concentrarsi sul “genere femminile”, non solo perché, nell’archeologia celtica, l’attenzione è stata a lungo e di preferenza rivolta a corredi con armi, ma anche perché, in più ambiti della società civile, si affermava la necessità di una rinnovata riflessione sul ruolo della donna e si voleva così partecipare e contribuire, nella disciplina in cui ci si è specialisti, a un dibattito di più ampia natura.
Nel caso specifico delle placche da cintura di tipo ticinese, sulle quali mi è stato richiesto di intervenire in occasione del convegno di Alicante, ci si concentrerà, oltre che sulla questione del “genere”, vale a dire sulla pertinenza di questo oggetto d’abbigliamento a un “sesso” o all’altro, sul modo in cui le cinture sono portate sul corpo, sulle riparazioni che le interessano e infine sui simboli che restituiscono. Si sono lasciate in secondo piano tipologia o cronologia, non perché meno interessanti – sono e rimangono la base per la comprensione del contesto storico e culturale in cui la cintura è prodotta e portata – ma perché, nell’area culturale di cui ci si interessa, già chiarite da una lunga tradizione di studi. I temi privilegiati nello studio non esauriscono tutti quelli possibili : oltre che dalle scelte di chi scrive, la loro scelta è determinata anche e come chiarito di seguito da altri fattori – non da ultimo dal tipo di fonti disponibile nell’area.
La cintura e l’abito
La cintura appartiene, così come tutti gli oggetti portati sul corpo, all’abito (fig. 1). Molto più che semplice protezione contro le intemperie, l’abito è un veicolo d’identità : trasforma la silhouette del corpo ed è un sistema di comunicazione non verbale che interessa e attraversa tutte le civiltà e tutti i periodi storici e presenta aspetti comuni. 1) L’abito è formato da più capi sovrapposti ed è costituito da materie prime differenti, tessuti d’origine vegetale e/o animale oppure da pelli e pellicce ; 2) nella sua materialità va pensato nell’insieme dei rapporti economici che lo hanno generato : tecniche di produzione, materie prime, ceti coinvolti e modalità di scambio ed acquisto ; 3) tra le sue funzioni primarie vi è quella di proteggere il corpo : fattori come l’ambito geografico e il clima, ma soprattutto la traspirazione, l’igiene, il contatto con la stoffa, l’ampiezza dei movimenti che consente e la stessa morfologia del corpo sono determinanti nella sua costruzione ; 4) è, verso l’esterno, l’emblema di un gruppo formato socialmente e, verso l’interno, il veicolo del ruolo che ciascuno ricopre. Concorre così a definire l’identità o meglio le identità : quella del singolo e quella della comunità cui appartiene. Determinanti alla sua costruzione sono : il sesso e il genere ; l’età ; lo status e il grado di parentela ; 5) ha una dimensione temporale : nasce, evolve, è abbandonato ; 6) può dipendere dall’occasione e dalle diverse circostanze della vita, sottolineando i principi costitutivi dell’esistenza, la vita quotidiana contrapposta alla festa, il sacro contrapposto al profano; 7) l’usura, le riparazioni e l’uso secondario che interessano certe sue parti possono diventare emblema di un sottogruppo : oggetti banali o presi da contesti quotidiani assumono un significato altro, se collocati in luoghi insoliti o privati della loro funzione originaria2.
Le cintura e l’abito in archeologia
La ricostruzione dell’abito – e della cintura – in archeologia è fortemente limitata dalla natura stessa della documentazione disponibile : in primo luogo sono percepibili solo le manifestazioni capaci di essere fissate nella materialità ; le evidenze materiali riconosciute dipendono poi dai metodi di scavo applicati e dal momento storico in cui l’indagine si svolge. Delle società protostoriche s’ignorano infine i sistemi semiotici che hanno investito di un significato questo o quell’altro materiale.
Le fonti principali per ricostruirlo si riducono a : 1) citazioni e descrizioni presenti in testi, da cui si possono ricavare una terminologia sui diversi capi d’abbigliamento e informazioni sulle loro circostanze d’uso ; 2) rappresentazioni su supporti di diverso genere, come vasellame in ceramica, pittura su muro, vasellame metallico, piccola o grande plastica in pietra, legno o metallo ; 3) tessuti, conservati soltanto in casi eccezionali e in genere pervenuti in frammenti di limitate dimensioni, mineralizzati grazie all’ossidazione prodotta da oggetti in metallo con cui sono in diretto contatto ; 4) oggetti d’abbigliamento e d’ornamento : posti sul capo, sul collo, sul petto, sulle braccia, intorno o sulla vita, sulle gambe e sulle caviglie o a coprire l’intero corpo. Per la maggior parte provenienti da sepolture e destinati ai morti riflettono solo parzialmente quanto portato dai vivi3.
Le cinture e il gruppo settentrionale della cultura di Golasecca
L’area di ricerca da cui provengono le cinture sulle quali si concentra l’intervento è parte del “territorio” golasecchiano e coincide con le vallate alpine e prealpine oggi situate in Svizzera, nel Canton Ticino, nel Canton Grigioni e nella Val d’Ossola. Durante l’età del Ferro l’area è caratterizzata da un’unità culturale, chiamata gruppo settentrionale della cultura di Golasecca (fig. 2). Tale cultura è tradizionalmente riferita ai “Leponti”, identificati dalla tradizione mito-storica con i mitici compagni di Eracle abbandonati sulle Alpi per aver avuto gli arti congelati : gli stessi sono citati, al volgere della nostra era, nella famosa iscrizione del Tropaeum Alpium che celebra le conquiste di Augusto sui popoli stanziati nell’arco alpino. Dalla stessa area provengono una serie di iscrizioni redatte in alfabeto di Lugano, alfabeto nord-etrusco riformato, vale a dire adattato alle esigenze fonetiche della lingua parlata nella regione che è, sulla base dei nomi restituiti, identificabile come celtica4. Tali iscrizioni, per la maggior parte in genitivo o in dativo, affermano la proprietà dell’oggetto, non dicono però nulla sulla cintura ; ugualmente non sono note fonti letterarie greche o latine che si soffermino sull’abbigliamento portato nella regione.

© Museo Nazionale Svizzero | Atelier Brückner, 2av.
L’unica fonte per ricostruire la cintura nell’area sono gli oggetti d’abbigliamento e d’ornamento. Nella regione sono note più forme di cintura, alcune coesistono all’interno dello stesso periodo cronologico, altre scompaiono da una fase all’altra ; alcune sono comuni all’intero territorio golasecchiano, altre su più vasta scala5. Ci si concentra qui di seguito sulle sole placche da cintura in lamina fogliata, dette “ticinesi”, perché la loro diffusione è circoscritta al gruppo settentrionale di Golasecca o facies di Bellinzona.
Le placche da cintura di tipo ticinese : la morfologia e la cronologia
Le placche da cintura di tipo ticinese sono prodotte a partire da una lamina di bronzo o di ferro dai 3 ai 4 mm di spessore, presentano forma fogliata più o meno allungata e morfologia standardizzata6 : sull’estremità prossimale trova posto il sistema di fissaggio alla cintura in materiale deperibile che avviene attraverso due linguette ripiegate, fissate attraverso chiodi a capocchia globosa ; l’estremità distale è invece occupata dall’uncino ; nella porzione centrale si concentra la decorazione, per la maggior parte a sbalzo e ad incisione (fig. 3).
L’inquadramento cronologico e la definizione del tipo si devono a Margaritas Primas7 e a Raffaele C. De Marinis8. Per la datazione, rilevanti sono la forma complessiva e il numero delle costolature, le più antiche con una risalgono al TI A / Fine del VI secolo ; le più recenti con tre al TI D, vale a dire alla fine del V secolo, qualche esemplare a quattro o a cinque è attestato nel IV / LT B.
Le placche da cintura di tipo ticinese : il modo in cui si indossano
Affermazioni perentorie sul verso di chiusura – a destra oppure a sinistra – sono difficili, perché l’ornato segue nella quasi totalità degli esemplari una logica geometrica ed è organizzato in modo simmetrico. Soltanto la placca attribuita alla tomba 14 di Giubiasco (fig. 4), con decorazione figurata che procede da sinistra verso destra, fornisce una debole indicazione : con l’estremità munita di uncino sul fianco sinistro, in conformità a quanto dimostrato per le placche di forma rettangolare ed a losanga note in ambito atestino. Ugualmente è difficile chiarire, in assenza di probanti associazioni di scavo, se l’uncino s’inserisse direttamente in un’apertura nella cintura in materiale deperibile o se esistesse un elemento di riscontro. L’associazione, seppure limitata, con anelli circolari in filo di bronzo sembra suggerire un sistema che prevedeva un semplice anello stretto da una lamina ripiegata fissata alla cintura mediante uno o più chiodi. La placca attribuita alla tomba 1 di Claro-alla Monda conserva, tra le linguette di fissaggio, resti di materiale deperibile : le analisi di laboratorio confermano essere cuoio – indicazione isolata sul materiale con cui era realizzata la cintola9.
Le placche da cintura di tipo ticinese: le riparazioni
Dei 55 esemplari reperiti, 30 sono interessati da restauri antichi. La rottura di un capo d’abbigliamento rappresenta, oggi come nell’antichità, un evento traumatico : il bene diventa inutilizzabile e un intervento è necessario se si vuole richiamare l’oggetto a nuova vita. Tali riparazioni informano del valore concesso da un gruppo a una classe di materiali ; il loro esame contribuisce però a chiarire anche aspetti tecnici legati all’artigianato e pone interrogativi sulle forme della sua organizzazione.
Le fratture – crepe e rotture disposte in corrispondenza dei punti più sollecitati dalla tensione – sono dovute ad un impiego ripetuto e non ad un atto volontario legato a una specifica circostanza, come nel caso dei cinturoni villanoviani, volontariamente spezzati in occasione della cerimonia funeraria e poi riparati per accompagnare la proprietaria nell’aldilà.
Le riparazioni interessano tutti i tipi e le varianti identificate : 13 esemplari appartengono alla variante con una sola cordonatura centrale (su un tot. di 23) ; 7 a quella con due (su un totale di dieci) ; 8 a quella con tre (su un totale di dodici) ; 2 alla variante con cinque.
Sono stati riconosciuti cinque interventi differenti volti a riparare il danno (fig. 5) :
A) giustapposizione dei frammenti, inserimento di una lamina di rinforzo sul lato posteriore, fissaggio mediante ribattini ; B) sovrapposizione dei frammenti, fissaggio mediante ribattini. Le dimensioni originarie dell’oggetto sono alterate ; C) inserimento sul lato posteriore della placca di una lamina di rinforzo, ripiegata sul bordo, e fissaggio mediante ribattini ; D) inserimento di una lamina con gancio a linguetta ripiegata sul lato posteriore o sul lato superiore della placca, fissaggio attraverso ribattini ; E) applicazione di uno o più rivetti direttamente alla parte in materiale deperibile.
Nelle riparazioni non è mai rispettata la sintassi decorativa originaria – cosa che sembra suggerire una certa rapidità di esecuzione. Tale tempestività lascia supporre l’esistenza di un sistema di valori nei confronti degli oggetti rotti e l’impossibilità del proprietario di separarsi dall’oggetto, in quanto emblema di una condizione o di uno stato sociale. In questo modo il valore del bene trascende il razionale e obbliga a prospettare un’unione con la persona10.
Le placche da cintura di tipo ticinese : i simboli
Le cinture, così come altri oggetti d’ornamento e d’abbigliamento, possono trasmettere simboli e messaggi in forma compressa ma un tempo d’immediata lettura e attingere alla memoria collettiva di uno o più gruppi. Coinvolti in gestualità e rituali che avvengono in luoghi o in contesti di deposizione particolari, possono assumere un significato particolare in occasioni riservate al racconto individuale o collettivo11.
Sulle placche da cintura di tipo ticinese si riconoscono più simboli : ruote raggiate, borchie, uccelli acquatici, cavalli e oranti (fig. 6). Esempio sono le placche della tomba 14 di Giubiasco (fig. 4) e della tomba 93 di Cerinasca (fig. 7), le uniche, all’interno della produzione ticinese, a riunire più motivi figurati. Sull’esemplare di Giubiasco le figure, strette entro le due cordonature, formano una composizione organica : da sinistra verso destra si riconoscono due oranti, tre uccelli acquatici e una croce uncinata, seguiti da tre nuovi oranti e da una croce. Nella placca di Arbedo-Cerinasca le figure riempiono, senza una logica apparente, lo spazio non occupato dalla decorazione a sbalzo : in uno dei due emicicli definiti dalle cordonature trovano posto una teoria di cinque cavalli, due stelle a quattro punte, due uomini e un uccello stante ; nell’emiciclo opposto tre cavalli, un uomo e due simboli di difficile lettura, il primo interpretato come una “medusa” e il secondo, probabilmente non completamente portato a termine, come un doppio gancio12.

Bianco: placche con una cordonatura; grigio chiaro: placche con due cordonature; grigio scuro: placche con quattro cordonature © Tori 2019, Fig. 6.1.
Nell’esemplare di Giubiasco la vicinanza delle officine alpine orientali emerge nella decorazione al tremolo che contorna le due cordonature, nella resa del motivo a croce e nelle figure antropomorfe in marcia. Queste ultime ricordano da vicino gli oranti del cinturone di lamina bronzea dalla tomba 367 di Hallstatt. Raffigurazioni di cavalli o di cervidi, vicine per lo schema generale a quelle della placca di Arbedo, sono note nell’area della cultura di Golasecca su prodotti riferibili a più classi di materiali : un vaso di ceramica rinvenuto a Osco, la situla della tomba Baserga dalla necropoli della Ca’ Morta di Como, la situla di Trezzo d’Adda e la kline di Hochdorf. I migliori confronti non solo per i cavalli ma anche per gli uccelli e per le figure umane provengono però dal gruppo 1 definito per le placche di Fliess e dal cinturone riutilizzato come fondo per la situla della tomba 2439 di S. Lucia/Most na Sočii.

© Museo Nazionale Svizzero, DIG-33534 | A-12385.
Le attestazioni provenienti dall’Austria e dalla Slovenia sono più antiche e in esse sono ancora riconoscibili le originarie connessioni tra motivi ornitomorfi, barca solare, cavalli e motivi solari. Che il repertorio cui le produzioni ticinesi attingono trovi le sue radici nell’età del Bronzo è ugualmente chiaro. Equini, bovini, cervidi, palmipedi e uccelli con becco arcuato sono tutti animali locali, organizzati secondo una logica stringente : nel mondo hallstattiano d’Oltralpe si procede attraverso l’opposizione di coppie standardizzate che associano alcuni animali e ne escludono altri (bovini e palmipedi da un lato, equini, figure antropomorfe e uccelli a becco arcuato dall’altro) ; in Ticino, la placca di Giubiasco sembra aderire a questa logica, al contrario in quella di Arbedo-Cerinasca non si ritrova questa organizzazione.
Non solo i simboli ma anche lo stile con cui sono espressi dovevano essere riuniti in un codice iconografico compatto e coerente : una sorta di vocabolario iconografico diffuso in una vasta area culturale, forse comprensibile oltre la lingua specificatamente parlata. Le figure, realizzate con un tratto preciso, sono tutte caratterizzate da stilizzazione : il corpo e la testa dei cavalli sono resi attraverso semplici linee ; il tronco delle figure umane è formato da un trapezio riempito a trattini ; le braccia, levate all’altezza del corpo, sono suggerite da linee arcuate. Le singole forme, fortemente semplificate, sono ridotte a immagini che tendono alla regolarità, con il solo contorno a definirle, il movimento è assente o limitato a pochi schemi tipici e le figure si susseguono sulla superficie per cui “le cose che in natura sono una dietro l’altra vengono presentate l’una accanto all’altra”13. Un tale stile, per nulla rudimentale, dipende dal fine per cui le figure sono state create : esse sono “pensate per un occhio interiore, che rievoca e non descrive” e sembrano trascrivere “serie di immagini mentali, in particolare quelle fissate dalla memoria”14, secondo un procedimento descritto per altri ambiti culturali e periodi storici, come ad esempio i pittogrammi amerindiani.
Le placche da cintura di tipo ticinese : il genere
Se una cintura appartenga al costume femminile o maschile, vale a dire definire se un oggetto di ornamento o di abbigliamento sia esclusivo di un sesso o di un genere è operazione complessa15 e deve avvenire considerando l’intero contesto funerario da cui l’oggetto proviene. In archeologia tale operazione ha spesso seguito a priori (collane = donne ; armi = uomini) ed è avvenuta senza sistematicità e in assenza di dati antropologici, come nel caso dell’area culturale di cui ci occupiamo.
Che durante la prima età del Ferro nelle associazioni rinvenute nella Svizzera sud-alpina siano ravvisabili modelli dicotomici riconducibili all’opposizione “uomo”-“donna” è stato sottolineato a più riprese, già a partire dagli anni ’70.
A verifica si è scelto di utilizzare la seriazione e l’analisi delle corrispondenze, processi statistici capaci di individuare la polarità esistente nei corredi16. Ben lontano da un’assoluta obiettività, tali metodi permettono però di strutturare il ragionamento e di visualizzarne ogni sua tappa, assicurando una relativa trasparenza nell’analisi.
I principali criteri adottati sono i seguenti : 1) adozione del sistema cronologico di M. Primas17 ; 2) seriazione di tombe provenienti da differenti necropoli ma appartenenti allo stesso orizzonte cronologico ; 3) seriazione delle sole tombe con inventario sicuro ; 4) seriazione delle classi di materiali, delle categorie funzionali, differenziate per materia prima e per numero di attestazioni, e non dei tipi che avrebbero privilegiato la successione temporale ; 5) seriazione delle sepolture con una sola variabile in inventario ; 6) riduzione dei criteri distintivi per evidenziare le caratteristiche rilevanti e giungere a blocchi di sepolture cristallizzati ; 7) correlazione dei gruppi identificati con le analisi antropologiche, qualora esistenti.
Per ciascun periodo cronologico, il calcolo della seriazione è presentato in tabelle, senza interpolazioni o correzioni (fig. 8). Nel caso in cui in una variabile/categoria siano raggruppate più attestazioni, il numero esatto rinvenuto in ogni sepoltura è indicato nella diagonale. Alla seriazione è sempre affiancata l’analisi delle corrispondenze (fig. 9), dove i gruppi di tombe sono più facilmente identificabili : nel primo grafico è visualizzata la posizione relativa delle tombe, nel secondo quella delle variabili/categorie che sono state seriate.
L’analisi condotta sulle associazioni funerarie dal Ti A al Ti D – orizzonti in cui sono diffuse le placche da cintura – permette di enucleare le seguenti linee di tendenza : 1) nonostante le differenze specifiche proprie a ciascun orizzonte cronologico, fenomeni comuni emergono sulla lunga durata ; 2) due gruppi di tombe contrapposti, vale a dire che non condividono categorie in comune, sono ben identificabili in ciascuno degli orizzonti cronologici considerati ; 3) all’interno di ciascun gruppo le categorie di oggetti si mantengono costanti durante i secoli, a conferma di una continuità nei modelli di rappresentazione e dell’esistenza di una norma ben radicata, nonostante l’evoluzione delle singole forme ; 4) la dicotomia indiziata da questi due gruppi sembra riconducibile alla differenziazione di genere/sesso ; 5) l’equivalenza fibule a sanguisuga/orecchini/collane in vaghi di vario materiale/placche o fermagli da cintura di bronzo e “donna” da un lato e fibule serpeggianti/fibule a drago/fibule Certosa/armi/utensili e “uomo” dall’altro sembra plausibile per i gruppi umani stanziati a nord del Monte Ceneri nella prima età del Ferro ed è supportata dai pochi contesti per quali sono disponibili analisi antropologiche ; 6) il dimorfismo legato al genere/sesso influenza dunque la selezione degli oggetti deposti nelle sepolture, in primo luogo di quelli d’ornamento e d’abbigliamento ; 7) nella contrapposizione “uomo”-“donna” le fibule e la loro foggia giocano un ruolo fondamentale, sino al Ti D ; 8) il numero di attestazioni per tomba, e non solo la singola categoria, ha funzione discriminante : è il caso delle perle d’ambra e di vetro o dei pendagli di bronzo che in singoli esemplari compaiono anche nelle tombe riferite a “uomini”, ma in numero maggiore a dieci soltanto in quelle “femminili” ; è il caso anche dei bracciali che nel gruppo attribuito agli “uomini” sono presenti al massimo con un solo pezzo, mentre nelle tombe attribuite alle “donne” ricorrono generalmente con due o più attestazioni ; 9) a partire dal Ti D si registra un netto cambiamento, poiché categorie che avevano caratterizzato i soli corredi “maschili” fanno la loro comparsa anche in quelli “femminili”, come nel caso ad esempio delle fibule Certosa di bronzo : questo significa che attributi di un sesso sono sostituiti o integrati con altri specifici dell’altro ; sulla lunga durata le categorie legate al sesso/genere evolvono e alcune che avevano prima avuto una rilevanza perdono di significato ; 10) i gruppi identificati non sono chiusi in se stessi e “anomalie” e “divergenze” sono sempre attestate, come nel caso delle sepolture in cui, seppure la maggior parte delle categorie presenti sia specifica di un gruppo, un oggetto rientra in categorie caratteristiche di un altro : esempio è la tomba 70 di Castaneda, pure con oggetti d’ornamento “femminile”, ma con coltello di ferro (appropriazione di un elemento caratteristico del genere/sesso “maschile”).

Variabili (sotto) © Tori 2019, Fig. 2.6.
Se si guarda alle sole tombe con elementi da cintura di bronzo e le si correla con le analisi antropologiche note, nessuna di esse può essere esplicitamente ricondotta a soggetti sub-adulti. È verosimile che la cintura di bronzo segnali dunque non solo il genere/sesso (“donna”) ma anche l’età (adulta). Se si guarda alle associazioni (fig. 10), le placche possono essere associate a sole fibule (AD) ; a fibule e perle (ABD) ; a fibule ed orecchini (ACD) ; oppure a fibule, a perle ed a orecchini (ABCD) ; e infine a fibule, perle, orecchini, bracciali (ABCDE). Il numero di fibule, di perle e di bracciali sembra indicare una certa capacità di accumulo ; tale moltiplicarsi di oggetti comuni è uno dei pochi segni di differenziazione che emerge nel corpus analizzato ; non si osservano, come in altre aree della cultura di Golasecca, tombe dotate di chiari elementi di distinzione (Tori 2019, 23-66).
Placche da cintura di tipo ticinese : la prassi museale
Delle 55 placche di cintura ticinesi qualche esemplare è esposto nella mostra permanente “Archeologia Svizzera”, aperta nel 2016 al Museo Nazionale Svizzero (fig. 11). Dei risultati ottenuti dal loro studio si trova ugualmente traccia negli approfondimenti multimediali. Non è un caso : chi ha fatto ricerca è anche chi ha curato la mostra.
Già Raffaele C. de Marinis18 aveva auspicato, in momento storico come il nostro in cui le risorse destinate all’archeologia sono sempre più esigue, più strette collaborazioni tra enti di divulgazione e enti deputati alla ricerca, al fine di sensibilizzare segmenti sempre più ampi della popolazione. Il tema, sul quale si era tornati con Stefania Casini e Marta Rapi in occasione del convegno dell’IIPP a Milano19, ha chiuso anche questo intervento ad Alicante, nella convinzione che la domanda della rilevanza sociale dell’archeologia debba determinare anche gli assi perseguiti e le domande poste dalla ricerca.

Vitrina dedicata all’età del Ferro © Museo Nazionale Svizzero| At elier Brückner.
Bibliografía
Casini, S., Rapi, M., Tori, L. (2022): “Non solo crisi. Elementi di continuità e discontinuità tra IV e III secolo a.C. nelle province di Varese, Milano, Como, Bergamo (IT) e nei Cantoni Ticino e Grigioni (CH)”, in: Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino, Rivista di Scienze Preistoriche, 72 – S2-2022, 715-735.
de Marinis, R. C. (1988) : “Liguri e Celto-Liguri”, in : Chieco Bianchi et al., eds, Italia omnium terrarum alumna, la civiltà dei Veneti, Reti, Liguri, Celti, Piceni, Umbri, Latini, Campani e Iapigi, Milano, 157-259.
de Marinis, R. C. (2013) : “De profundis per la divulgazione scientifica in campo preistorico e protostorico”, Rivista di scienze preistoriche, 63, 255-263
de Marinis, R. C. (2000) : “Le placche da cintura ticinesi in lamina bronzea”, in : de Marinis & Biaggio Simona eds. 2000, vol. 2 :, 11-29
de Marinis, R. C. e Biaggio Simona S., eds. (2000) : I Leponti. Tra mito e realtà (2 vol. ), Locarno.
Nagy, P. (2012) : Castaneda GR. Die Eisenzeit im Misox, UPA 218, Bonn.
Primas, M. (1970) : Die Südschweizerischen Grabfunde der älteren Eisenzeit und ihre Chronologie, Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 16. Basel.
Schindler, M. P. e de Marinis, R. C. (2000) : “L’età del Ferro nel Canton Ticino e nella Mesolcina”, in : de Marinis & Biaggio Simona, eds. 2000, vol. 1, 159-183.
Severi, C. (2004) : Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria, Biblioteca Einaudi 196, Torino.
Tori, L., Carlevaro, E., Della Casa, P., Pernet, P. e Schmid-Sikimić, B. (2010) : La necropoli di Giubiasco (TI), vol. III. Le tombe dell’età del Bronzo, della prima età del Ferro e del La Tène antico e medio. La sintesi, Collectio archaeologica 8, Zürich.
Tori, L. (2019) : Costumi femminili nell’arco sud-alpino nel I millennio a.C. Tra archeologia sociale e antropologia, Collectio archaeologica 10, Zürich.
Notes
- Tori 2019.
- Tori 2019, 11-14.
- Tori 2019, 15-18.
- De Marinis 1988 ; De Marinis & Biaggio Simona 2000.
- Tori et al. 2010, 87-103 ; Tori 2019, 67-79
- Tori 2019, 99-101.
- Primas 1970.
- De Marinis 2000.
- Tori 2019, 99-101.
- Tori 2019, 99-115.
- Tori 2019, 117-127.
- De Marinis 2000, 22.
- Severi 2004, 109.
- Severi 2004, 110.
- Tori 2019, 18-19.
- MAKILA © P. Ruby. PAST/ PAleonthological STatistics © D. A. T. Harper/P. D. Ryan.
- Primas 1970.
- De Marinis 2013.
- Casini et al. 2022, 734-735.