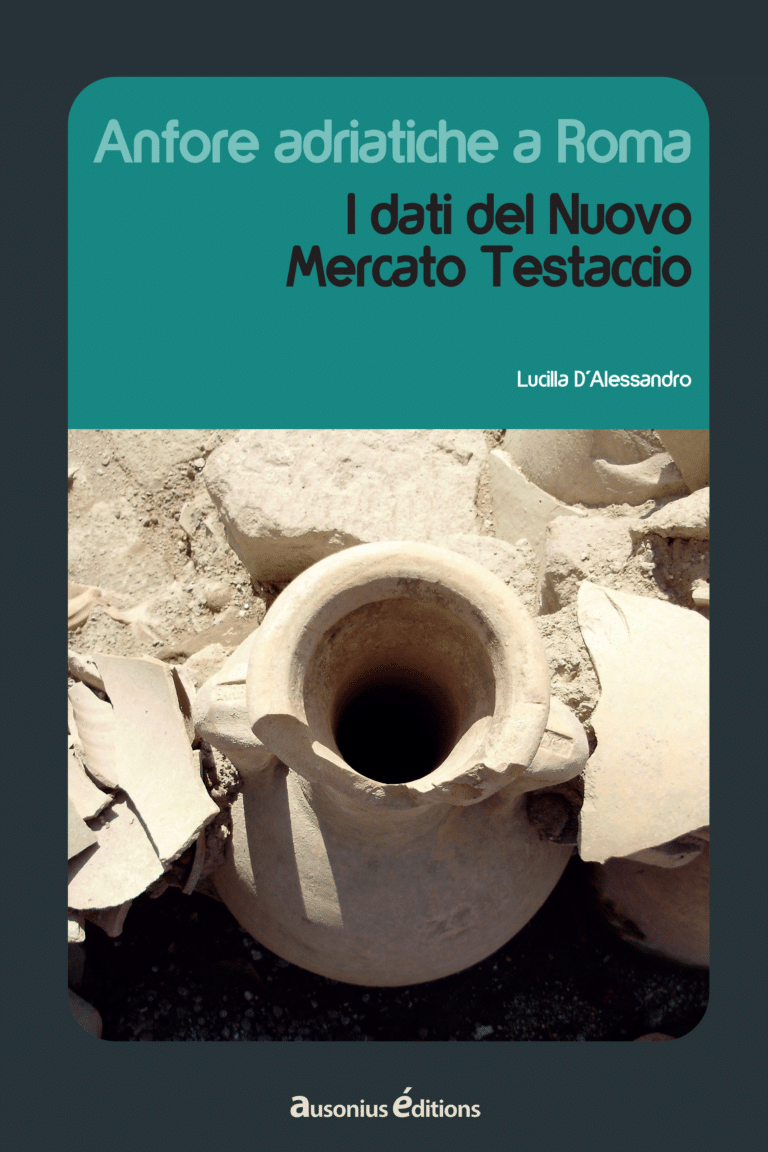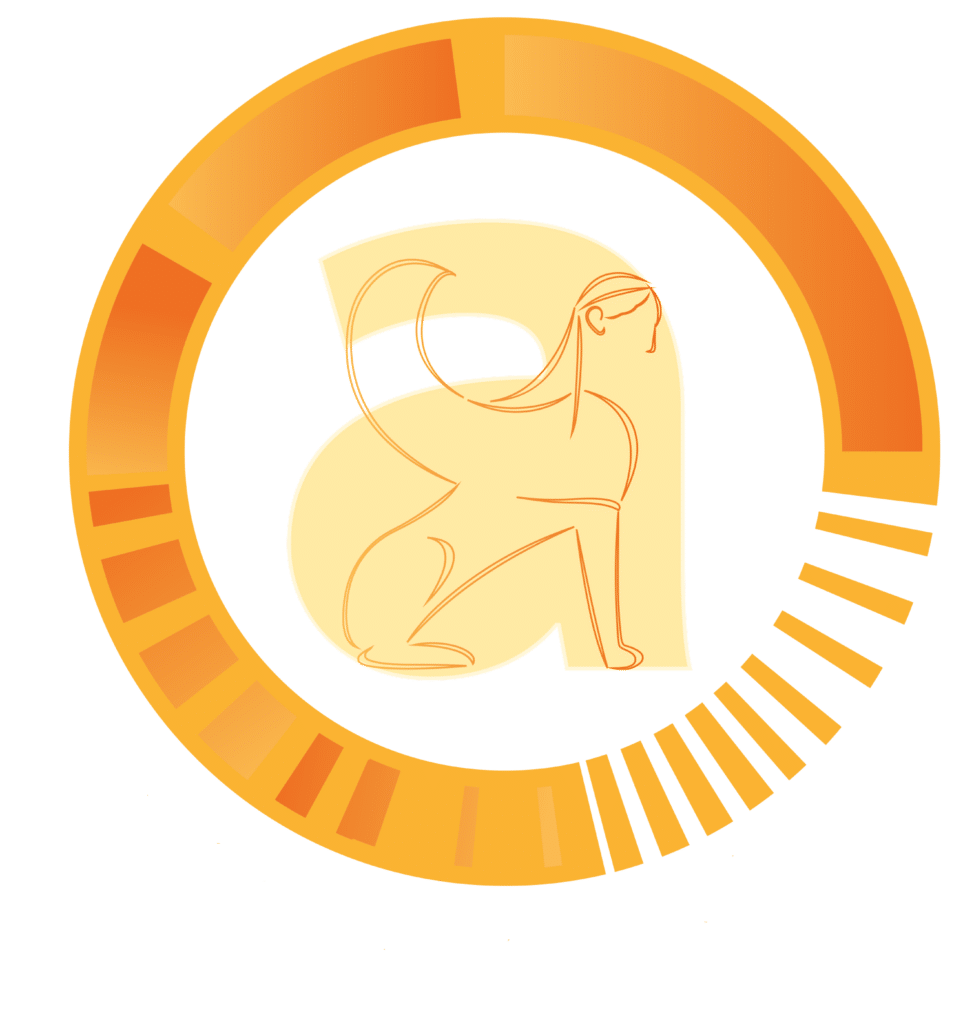I bolli
I bolli schedati, provenienti dall’intero contesto di scavo e non limitati al solo settore di indagine1 (elenco completo in ordine di inventario in Appendice 1), sono stati trascritti secondo le indicazioni contenute nel database RTAR III e ordinati, all’interno delle diverse tipologie, secondo i criteri esplicitati in RTAR I, pp. 9-14. Il presente elenco integra, corregge e sostituisce quello provvisorio pubblicato in D’Alessandro 2013 e inserito nel catalogo on line del Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica (CEIPAC) della Universidad de Barcelona2. Per completezza è stato pertanto incluso in nota, quando necessario, un riferimento a tale corpus, ancorché attualmente superato.
Nel caso di bolli attestati su reperti molto frammentari o del tutto privi di parti significative, l’attribuzione tipologica è stata effettuata con riguardo ai seguenti criteri:
- confronti individuati, ove possibile;
- caratteristiche del reperto conservato (ad es. spessore delle pareti o risega alla base del collo attribuibile a Dressel 2-4 invece che a Dressel 6A);
- elementi distintivi del marchio stesso (ad es. ricorrenza di tria nomina più o meno abbreviati etc.);
- contenitori in situ come parametro per l’interpretazione tipologica dei frammenti (vd. supra, pp. 126-127).
Pur essendo stata effettuata una scelta, eventuali dubbi, ambiguità o problematiche tipologiche sono state segnalate nelle schede dei singoli bolli. Con riguardo all’occorrenza di varianti nei bolli attestati in più esemplari (di volta in volta segnalate), si precisa che minime differenze riscontrate nelle impronte per lo più non sono state ritenute sufficienti a ipotizzare l’esistenza di diversi punzoni, essendo piuttosto imputabili alle diverse condizioni in cui si sono svolti i processi di bollatura, essicazione e cottura o allo stato di conservazione dei reperti. Naturalmente non è escluso che tali leggere diversità siano dovute all’uso del surmoulage, cioè alla creazione di punzoni nuovi utilizzando come matrici i calchi delle impronte3.
In rapporto, invece, a bolli diversi che ricorrono associati o meno sui reperti conservati o che possono essere ad ogni modo ascritti alla medesima produzione, si è scelto di volta in volta se trattarli separatamente (con opportuni rimandi e ripetizioni da un marchio all’altro), allo scopo di valorizzare eventuali specificità, o se riunirli nella medesima scheda, esplicitando le motivazioni di tale opzione.
Da ultimo, a proposito della documentazione, si segnala che nel caso di contenitori bollati che conservassero parti significative ben leggibili sono stati disegnati i reperti con il marchio, mentre, nel caso di materiali frammentari, i soli bolli; nell’ordinamento delle tavole si sono anteposti i reperti che consentissero al contempo osservazioni morfologiche ed epigrafiche. Si precisa inoltre che per i materiali del settore W non sempre è stato possibile reperire i dati sulla provenienza stratigrafica.
Un tentativo di caratterizzazione dei contenitori sulla base di epigrafia, morfologia, aspetto macroscopico e archeometria dei contenitori è contenuto alle pp. 237-250 (infra), con particolare riferimento alle principali serie:
- serie I, produzione dei Rubrii;
- serie II, B“AR”B”VL” // C.I“VL”.POLY;
- serie III, THB.
Un inquadramento di insieme dei materiali bollati e qualche notazione sul significato di essi sono forniti nelle conclusioni del presente lavoro4.
Bolli su Lamboglia 2
1) ER
Er(—
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 2265, UUSS 504+518
posizione: orlo;
caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare; retrogrado;
impasto 4.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 21.2
MORFOLOGIA: NMT_AAD Orlo 1
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (aprile 2021) non sono stati individuati confronti.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
In via d’ipotesi si può riconoscere nelle due lettere l’abbreviazione di un cognomen / nomen singulum5.
Meno probabile che si tratti di un gentilicium o dell’abbreviazione di una formula onomastica bimembre.
Bolli su Dressel 6A
1) M.A“MV*”[
M. Amu[—] o M. A(—) Mu[—] o M. Am(—) V[—]6
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4414, US 1678: M.A“MV*”[
posizione: orlo;
caratteristiche: lettere a leggero rilievo entro cartiglio rettangolare con angoli stondati;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase?
FIGURE: Fig. 34.1
MORFOLOGIA: gruppo I.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (aprile 2021) non sono stati individuati confronti.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nel bollo si può forse intravvedere la parte iniziale di una formula onomastica o una formula onomastica abbreviata.
2) “ANT”
Ant(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4410, US 981: “ANT”
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio;
impasto 3.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a N del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 34.2
MORFOLOGIA: gruppo II.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (aprile 2021) non sono stati individuati confronti puntuali, benché un bollo ANT a rilievo entro cartiglio sub-circolare sia attestato su Lamboglia 2 ad Aquileia7.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nel bollo potrebbe scorgersi, in via d’ipotesi, l’abbreviazione di un gentilicium8 o di un cognomen / nomen singulum9. Si segnala l’attestazione del marchio nei livelli più antichi individuati presso la discarica NE del Nuovo Mercato.
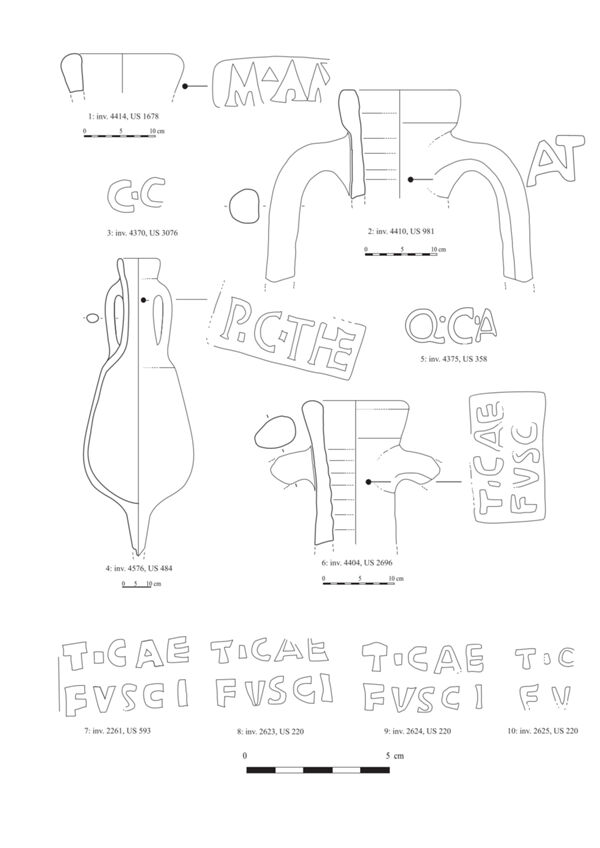
3) BARBARI10
ATTESTAZIONI NMT
Il bollo è attestato in un caso insieme al marchio C“AD”MVS (inv. 1213, US 375): entrambi i bolli sono stati recuperati separatamente in un butto collegato alle fornaci ceramiche di Marina di Città Sant’Angelo (PE)11, ma la testimonianza del Nuovo Mercato Testaccio rappresenta l’unica attestazione al momento nota dei due marchi associati su un solo contenitore. La peculiarità di tale circostanza, congiuntamente al fatto che il marchio C“AD”MVS paia conoscere un’evoluzione autonoma12, suggerisce di trattare il bollo in esame separatamente dall’altro.
Tutte le attestazioni del marchio BARBARI si registrano su ansa, salvo che ove diversamente indicato, e sono in lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare. I punzoni sono almeno 4 (sono stati sottolineati i 3 esemplari che sicuramente si distaccano dal gruppo principale):
- inv. 1213, US 275: BARBARI//C“AD”MVS;
- inv. 1404, US 760: BARBARI (in verticale sul collo);
- inv. 2264, US 387: [BA]R*B“AR”I;
- inv. 2281, US 556: BARBAR[I] (doppio cartiglio o linee guida);
- inv. 3090, US 1747: B“AR”B“AR”I (doppio cartiglio o linee guida);
- inv. 3091, US 775: [B]ARBAR[I]*;
- inv. 3094, US 750: [B]ARB[ARI];
- inv. 3095, US 2524: [B]A*R*BARI*;
- inv. 3096, US 2259: BARBA*R*I*;
- inv. 3098, US 2535: BARBARI.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I-II fase discarica; settore W, livelli pre-horreum e livelli severiani dell’horreum.
FIGURE: figg. 4; 35.2-3; 36.1, 3-9
MORFOLOGIA: NMT_AAD Orlo 5 = D6A, gruppo III (invv. 1213 – 3098). In questo caso la morfologia è riscontrabile su due soli esemplari, ma per una caratterizzazione complessiva dell’intera produzione ascrivibile a Barbarus e alla sua familia cfr. infra, pp. 237-250.
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
L’identificazione del sito produttivo di queste anfore e le ricerche petrografiche e chimiche in corso su campioni che recano i marchi in questione hanno indirizzato verso un approfondimento dei confronti individuati (aprile 2021) rispetto a quelli effettuati per altri reperti bollati13.


Italia
Marina di Città Sant’Angelo (PE), atelier: le anfore provengono da un butto ascritto ad un atelier produttivo14. Parte del materiale della fornace è stato esaminato autopticamente nell’agosto 2014 e sottoposto ad analisi archeometriche.
- BARBARI. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: Staffa 2003, pp. 125-126, Fig. 7,1, irreperibile al momento del controllo autoptico.
Note: nella foto pubblicata si intravvedono doppio cartiglio o linee guida (cfr. NMT_inv. 2281).
- B*ARBA[R]I*. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Note: controllo autoptico (cfr. Fig. 59.3).
Brindisi
- BARBAR(I) o piuttosto BARBAR[I]. Posizione: ? Caratteristiche: ?
Bibliografia: CIL IX, 6079, 10.
Note: rinvenuto in oppido, il reperto è ascritto alle amphorae Calabrae.
Roma (parte dei materiali è stata sottoposta a controllo autoptico presso i Mercati di Traiano, a più riprese tra 2013 e 2015, cfr. infra, pp. 252-259)
- BARBARI. Posizione: sul collo o sull’ansa. Caratteristiche: orlo di morfologia apparentabile al Gruppo III del Nuovo Mercato; lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: CIL XV, 3408 a.
Note: nel CIL risultano due esemplari di Dressel 6A dal Castro Pretorio e un’anfora dal Viminale con questo marchio; su uno di questi reperti era presente inoltre il titulus pictus in rosso P[HIL] “VE”(T?) CL vel P[HL] “VE”(T?) CL (CIL XV, 4660c), assimilabile ad altri attestati su anfore recanti i bolli THB (CIL XV, 2905) e PONTIC“VL” (CIL XV, 3508). Risulta attualmente reperibile solo un contenitore con bollo BARBARI sul collo (MT 74), sottoposto a controllo autoptico.
- B“AR”B“AR”I. Posizione: sulla spalla o sulla pancia. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio o doppio cartiglio rettangolare.
Bibliografia: CIL XV, 3408 b.
Note: nel CIL sono repertoriatidue bolli dal Tevere (in ripa o in alveo) e due esemplari di Dressel 6A, con analogo marchio, per i quali non è indicata la provenienenza; i reperti, attualmente irreperibili, potrebbero aver presentato analogie con i bolli NMT invv. 2264 e 3090.
- BARBA. Posizione: sul collo o sull’ansa. Caratteristiche: orlo di morfologia apparentabile al Gruppo III del Nuovo Mercato; lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: CIL XV, 3408 c.
Note: nel CIL risultano sei esemplari di Dressel 6A con questo bollo di cui uno dal Castro Pretorio; tre esemplari recavano inoltre un titulus pictus in rosso sul collo (CIL XV, 4657), con l’onomastica di un personaggio M. Utan(i) Hyme(naei) o Hym(enaei) che torna anche su un’anfora con bollo THB (CIL XV, 2905), nonché come bollo (?) in lettere cave entro cartiglio su un contenitore di forma non precisata (CIL XV, 3546). Al momento del controllo autoptico risultava solo un esemplare (MT 73), con marchio BARBA(RI) sul collo.
Austria
Magdalensberg
- B“AR”B“AR”I. Posizione: spalla (base del collo?). Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: Maier & Maidl 1992, p. 106.
Note: attribuito ad anfora non identificata, rinvenuto nel contesto MB/82.
Grecia
Abdera
- Barbari. Posizione: ansa? Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: inedito (segnalazione Y. Garlan, per il tramite di M.-B. Carre).
Atene
- BARBARI? Posizione: orlo. Caratteristiche: ignote.
Bibliografia: Mongardi 2013, p. 463; Mongardi 2018, p. 88 (da segnalazione di C. Panella).
Tunisia
Cartagine
- BARBARI. Posizione: ansa. Caratteristiche: ignote.
Bibliografia: CIL VIII, 22637, 21.
Turchia
Sinope
- [B]arbari. Posizione: ansa? Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: inedito (segnalazione Y. Garlan, per il tramite di M.-B. Carre).
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
In letteratura15, è stata proposta l’identificazione del Barbarus che bolla le anfore adriatiche con il P. Rubrius Barbarus di età augustea16, che ricoprì nel 13-12 a.C. la carica di prefetto d’Egitto, vertice della carriera equestre ed espressione della fiducia del princeps, il legame col quale è ben testimoniato nell’epigrafia lapidaria e monumentale17. Tale identificazione è ora rafforzata da diversi elementi.
P. Rubrius Barbarus era figlio di un Marcus (si noti l’esistenza di un bollo M.BARBAR da Dosso S. Maria, PV)18 ed era ascritto alla tribù Maecia19, cui appartenevano i cittadini di Brundisium, Hadria/Hatria, Lanuvio, Libarna, Neapolis, Paestum e forse anche Taranto.
20Notevole coincidenza e circostanza presumibilmente dirimente21 è rappresentata dal rinvenimento nel pescarese, a Marina di Città Sant’Angelo, alla foce del fiume Saline, probabilmente nell’ager dell’antica Hadria – una delle città candidate a patria del praefectus Aegypti – di un butto ascrivibile alla figlina di Barbarus. Tra il 1993 e il 2003, infatti, sono stati ivi intercettati, nei pressi di una fornace antica, livelli archeologici in parte rimaneggiati, eccezionalmente ricchi di anfore Lamboglia 2 e Dressel 6A, tra le quali figuravano anche frammenti di ansa bollati C“AD”MVS, BARBARI e PRIMIBAR, cui era frammisto materiale concotto22.
Un contenitore in situ nell’area del Nuovo Mercato Testaccio, in un allineamento di seconda fase nel settore NE (inv. 1213, US 275; Fig. 35.1-2), conserva, come già si notava, un doppio bollo BARBARI//C“AD”MVS, consentendo di connettere i due marchi, entrambi presenti nel butto di Marina di Città Sant’Angelo, e di ipotizzare un rapporto di dipendenza da Barbarus di Cadmus23, probabilmente più tardi affrancato come testimonierebbero i reperti a marchio RVBRI//CADMI24. Questi doppi bolli anforari, infatti, parrebbero riferirsi ad un momento successivo a quello ricostruibile dall’esemplare del Nuovo Mercato: Cadmus, in seguito all’affrancamento, avrebbe assunto il gentilicium del dominus,mantenendo l’antico nome servile come cognomen e firmandosi al genitivo Rubri Cadmi. Meno plausibile pare invece l’ipotesi di considerare le due coppie di bolli come modi diversi di definire il medesimo rapporto tra schiavo e dominus, rispettivamente espresso nella forma servus domini e (opus?) servi domini; anomala sembrerebbe infatti in tal caso l’identificazione del dominus in un caso mediante il cognomen Barbarus, nell’altro tramite il gentilicium Rubrius.
I doppi bolli RVBRI//CADMI e i marchi del Nuovo Mercato Testaccio, inv. 3093 (RVBRI; vd. infra, p. 196) e inv. 3097 ([]CC.AVG*.II**/R*VBRIAE.PF.F. // “HD”; vd. infra, pp. 197-199), costituiscono, poi, una testimonianza materiale esplicita relativa al coinvolgimento della gens Rubria nella produzione anforaria, utile a confermare l’identificazione del dominus proposta dalla letteratura archeologica. I Rubrii risultano altresì coinvolti nella fabbricazione di laterizi e dolia25.
Con buona probabilità, inoltre, la figlia di P. Rubrio Barbaro, la stessa Rubria Publii filia del bollo inv. 3097 è citata, col cognomen Quinta, nel titulus funerario in cui Daphnus, cellarius di T. Rubrius Nepos (da identificare col curator aquarum del 38-49)26 ricorda Rubria Ichnas, Quintaes Barbari nutrix27. L’epigrafe, oltre a testimoniare un collegamento tra T. Rubrius Nepos e Barbarus, attesta il valore fortemente identificativo del cognomen Barbarus, testimoniato anche dalla dedicabilingue di uno degli obelischi posti dal praefectus Aegypti all’ingresso del Kaisareion di Alessandria28. Coerente con le testimonianze succitate sarebbe l’individuazione del dominus a mezzo del solo cognomen Barbarus29 nell’epigrafia anforaria, circostanza che, pur trovando riscontro anche in altre produzioni30, rafforzerebbe ulteriormente l’impressione della corretta identificazione del personaggio e l’interpretazione proposta per i bolli RVBRI//CADMI.
D’altro canto, tale identificazione è compatibile dal punto di vista cronologico con l’attestazione del bollo in esame nella prima fase della discarica del Nuovo Mercato Testaccio.
La figlia di P. Rubrio Barbaro, Quinta, sarebbe, infine, l’erede delle fortune paterne, consistenti in investimenti in diverse proprietà e attività manifatturiere, come testimonia oltre al già citato marchio su anfora inv. 3097, rinvenuto al Nuovo Mercato Testaccio, ove la donna è citata come Rubria P(ublii) f(ilia)31, anche un bollo laterizio semicircolare, attribuito ad età claudio-neroniana, proveniente da Lucus Feroniae32, la cui matrice parzialmente modificata in seguito al passaggio di proprietà delle figlinae recita:
a) Vicciana (i. e. tegula) St. Mar(ci) Ant(iochi), ex figulin(is) P. Rubr(i) Barb(ari);
b) Vicciana (i. e. tegula) St. Mar(ci) Ant(iochi), ex figulin(is) {P} Rubriaes.
Nel testo a) come dominus delle Viccianae, figlinae attribuibili all’ager di Narni nella valle del Tevere, compare P. Rubrio Barbaro, sostituito dalla figlia Rubria (testo b) che avrebbe continuato la produzione con lo stesso officinator St. Mar(cus) Ant(iochus)33. Il nome della domina termina in –aes secondo una applicazione intuitiva della declinazione latina ascrivibile a chi ha modificato il punzone e non infrequente su opus doliare34. A Rubria appartennero inoltre le figlinae Quintianae – forse una derivazione delle Viccianae, il cui nome potrebbe essere stato mutuato dal cognomen della donna Quinta – in cui vediamo operativo lo stesso Marcio Antioco35.
Per quanto concerne infine i rapporti tra la gens Rubria e altre famiglie coinvolte nella produzione di anfore – principalmente Dressel 6A – lungo la costa adriatica, dubbio risulta, già nella PIR36,il legame parentale di P. Rubrius Barbarus, per il tramite della figlia Quinta, con L. Tarius Rufus37, mentre pare invece significativo ricordare come sia stata recentemente ipotizzata l’esistenza, nella prima età imperiale, di vincoli matrimoniali tra la gens Rubria e la gens Helvia, tra i cui membri si annovera T. Helvius Basila, probabilmente il THB dei bolli anforari38, presumibilmente attraverso il matrimonio di una Rubria con un Helvius39.
La famiglia dunque, risulta in forte ascesa sociale all’inizio del principato, grazie ad accorte scelte politiche e vantaggiose alleanze parentali, che la portarono ad annoveraretra i propri membri consoli e Vestali, mantenendo e incrementando le proprietà e le attività economiche40.
4) B“AR”B“VL” // C.I“VL”.POLY41
Barbul(a) o Barbula(ae) // C. Iul(ius?) Poly(—)
ATTESTAZIONI NMT
Tutte le attestazioni di questo bollo si registrano su collo, salvo che ove diversamente indicato, e sono in lettere cave senza cartiglio.
I punzoni del bollo B“AR”B”VL” sembrano riferibili ad un unico gruppo, per cui le integrazioni nella trascrizione sono state fatte tutte secondo il medesimo schema, sebbene i reperti seguenti presentino alcune specificità
- inv. 3102: assenza della B iniziale, non dovuta a rottura o perdita, eventualmente a mancata impressione.
- inv. 3104, lato a, primo bollo [B“A]R”B[“VL”]: non sembrano rilevabili tracce precedenti le lettere conservate , ma il bollo sembra nel complesso mal impresso, il contenitore è di fattura grossolana e mal rifinito, con grossi riporti d’argilla e ditate all’attacco dell’ansa, proprio dove insiste il marchio; l’altro lato dell’anfora presenta un identico bollo, diversamente conservato.
- inv. 3224: tracce imputabili alla matrice impiegata per l’esecuzione del timbro.
I punzoni del marchio C.I“VL”.POLY paiono assegnabili almeno a due gruppi (sottolineati nel testo i due esemplari, peraltro leggermente differenti, che si distaccano dagli altri), ammesso che non si debba postulare per i reperti invv. 2626 e 3099 una mancata impressione della I, peraltro talvolta difficilmente leggibile anche in altri esemplari. Le integrazioni dei marchi frammentari sono state fatte in via ipotetica, tenendo a modello il gruppo più numeroso tra Dressel 6A e Dressel 2-4, che reca la I. Si notano inoltre anche per l’inv. 3223 tracce dovute al punzone con cui è stata effettuata la bollatura.
Caratteristiche quali incompletezza dei marchi dovuta a pressione ineguale sulla superficie curva del vaso o tracce del punzone sono già state segnalate in letteratura a proposito di questa produzione42.
I due bolli, tra i quali è stata stabilita una gerarchia per l’ordinato inserimento nel presente capitolo, sono riportati di seguito in un’unica lista, non essendo stato possibile stabilire se l’attestazione isolata dell’uno o dell’altro marchio, peraltro associati anche su Dressel 2-4 come si vedrà (cfr. infra, pp. 211-212), possa essere dovuta allo stato di conservazione dei reperti e non essendo state rilevate peculiarità nel quadro tipologico, epigrafico o distributivo dell’uno o dell’altro bollo testimoniato isolatamente:
- inv. 1419, US 387: [C.I“VL”.]POLY;
- inv. 2249, US 387: [C.I“VL”.]P*OLY;
- inv. 2626, US 245: B“AR”B“V*L*”//C.“IVL”.POLY*;
- inv. 3099, US 452: C.“IVL”PO[L]Y*;
- inv. 3101, US 45243: [B]“AR”B“VL”//C.I“VL”.POL[Y];
- inv. 3102, US 3215: [B]“A*R”B“VL*”;
- inv. 3103, US 957: B*“A*R”B“V[L”];
- inv. 3104, US 452: a- [B“A]R”B[“VL”]44//C.I“V[L”]PO[LY] ; b-: [B] “AR”B“V[L”];
- inv. 3223, US 444: [C.I]“VL”.POLY;
- inv. 3224, US 2486: [B]“A*R”B“V[L”];
- inv. 3225, US 1828: B“AR”B“VL” (orlo).
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato e II fase Nord; settore W, fase pre-horreum.
FIGURE: Figg. 37-39 (cfr. anche Fig. 50)
MORFOLOGIA: NMT_AAD 25 (invv. 3102, 3103, 3104, 3224, 3225), cfr. Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 73-80. Si segnala che si tratta spesso di contenitori di fattura molto grossolana (cfr. inv. 3104).
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (aprile 2021)45
- Italia: Fermo (a quest’area e in particolare alla zona di Torre di Palme / Fosso S. Biagio, dove la toponomastica annovera una contrada Barbolano – castellum Barbulanum o Barvulanum nelle fonti medievali – è attribuita la provenienza dei contenitori con questo marchio46); Ascoli Piceno; Aquileia; Concordia Sagittaria (VE); Cremona; Ivrea (TO); Monterubbiano (FM); Milano; Modena47; Padova48; Pegognaga (MN), loc. San Lorenzo49; Roma50; Vercelli; Verona; Vicenza51.
- Albania: Phoinike;
- Austria: Virunum;
- Libia: Apollonia.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Come rappresentato in letteratura52, il cognomen Barbula risulta attestato prevalentemente nel periodo medio e tardo repubblicano, in specie in relazione ad un ramo della gens Aemilia che, tra la fine del IV e il III sec. a.C., annovera tra i suoi membri almeno 4 consoli53; l’alta cronologia di questi magistrati deve tuttavia far escludere un loro possibile coinvolgimento nella produzione delle anfore in questione.
A cavallo tra l’età cesariana e quella augustea è attestato invece un Barbula54 partigiano di M. Antonio che, dopo Azio (31 a.C.), dovette godere della protezione e dell’influenza di un non meglio specificato Marcus, ex-luogotenente di Bruto a Filippi (42 a.C.), cui egli aveva assicurato il proprio sostegno all’indomani della disfatta dei Cesaricidi (App., B. C., IV, 49). Marcus, infatti, fintosi schiavo, sarebbe stato acquistato da Barbula e da questi in seguito reintegrato nella propria condizione e nel proprio censo. Entrambi avrebbero poi rivestito il consolato e sono forse da identificare con i magistrati supremi del 21 a.C., M. Lollius e Q. Aemilius Lepidus55.
La cronologia non sarebbe del tutto incompatibile con la produzione anforaria in esame: si vedano i contesti di Padova e Vicenza, databili dall’età augustea a quella tiberiano-claudia, in cui il bollo è stato rinvenuto56; al Nuovo Mercato Testaccio esso è però attestato nel settore NE soltanto a partire dalla II fase sia S che N, mentre nel settore W compare nella fase pre-horreum.
Sebbene non siano noti dalle fonti i legami di questi con il Piceno, la toponomastica consente di ipotizzare l’esistenza di praedia di un Barbula in territorio fermano, dove, nei pressi del fosso San Biagio a S di Torre di Palme – in un’area collegabile alla produzione del vino palmense, noto dalle fonti antiche57 – sono probabilmente da localizzarsi le officine delle anfore con questo marchio.
Con riguardo a C. Iul(—) Poly(—), lo scioglimento più probabile per il nomen è Iul(ius), come suggerisce l’associazione con il prenome Caius, ben attestato nella gens Iulia; occorre tuttavia precisare che nei repertori onomastici ricorrono anche altri nomina, ancorché più rari58. Il cognomen grecanico Poly(—) conosce una pluralità di possibili scioglimenti, che riconducono comunque ad ambiente servile o libertino59. Il personaggio potrebbe forse essere collegato alla domus imperiale, considerata l’onomastica, benché manchino indicazioni più esplicite e probanti60.
Le considerazioni sopra esposte hanno suggerito che Barbula, identificato a mezzo di un solo elemento onomastico, al pari di Barbarus, fosse un dominus, proprietario di terre e presumibilmente di manifatture ivi impiantate, mentre a C. Iul(—) Poly(—) spettasse il ruolo di produttore delle anfore / conductor della figlina61, senza essere tuttavia liberto del primo (diversità di gentilizi), qualora fosse corretta l’identificazione di questi e/o l’attribuzione alla gens Aemilia. L’interpretazione dei due marchi resta tuttavia piuttosto critica e assai dibattuta in letteratura62.
Recenti analisi chimiche su materiali adriatici bollati sembrerebbero corroborare per i contenitori con marchio C.IVLPOLY l’ipotesi di provenienza medio-adriatica63, dato affine ai risultati delle indagini archeometriche effettuate al Nuovo Mercato Testaccio.
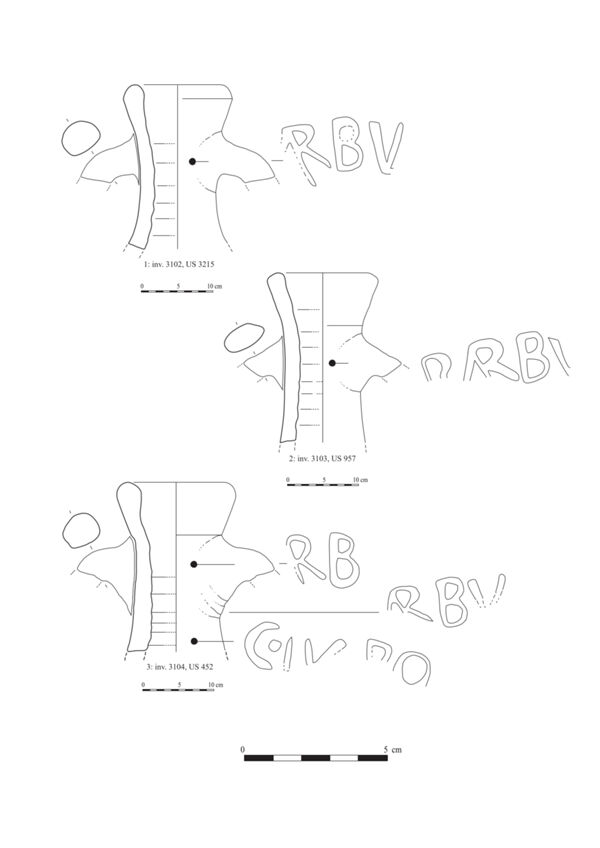
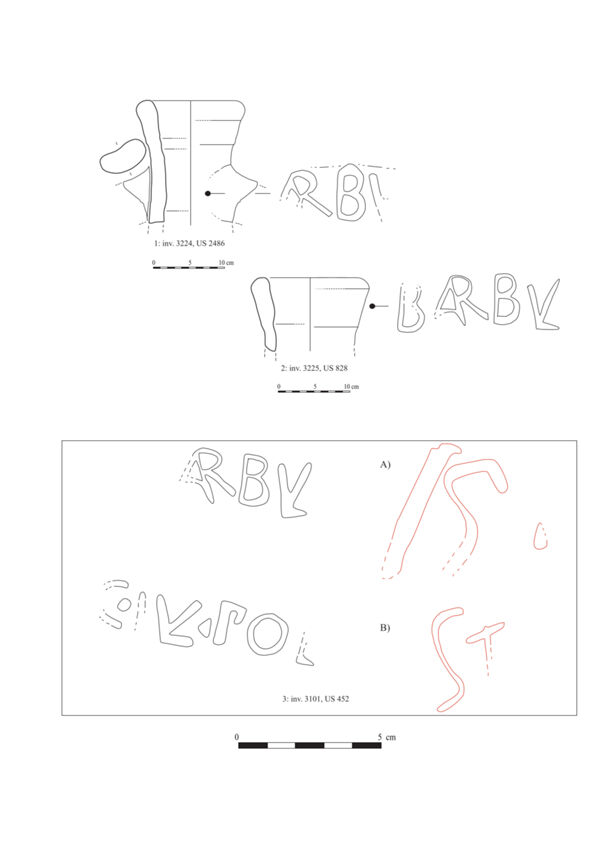
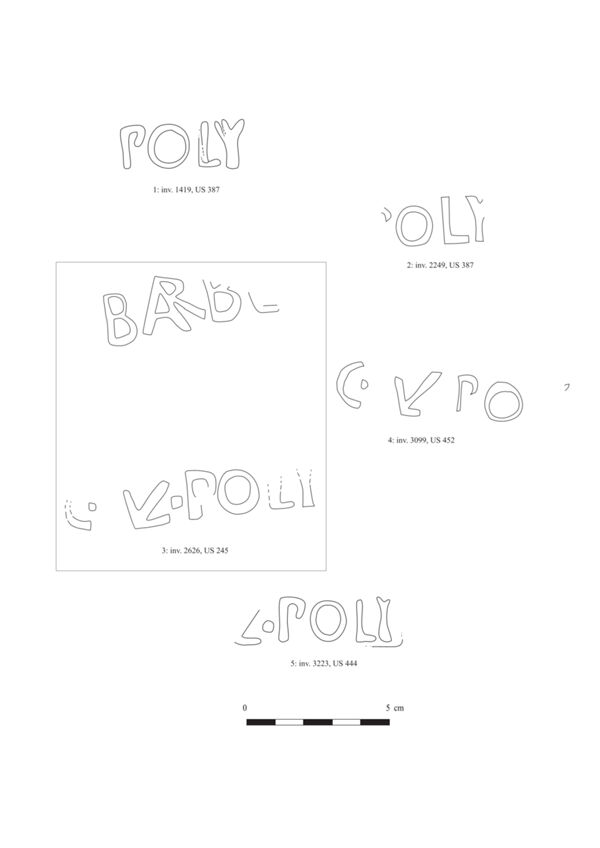
5) C.C
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4370, US 3076: C.C
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio;
impasto 1.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase ?
Figure: Fig. 34.3
MORFOLOGIA: non desumibile dal reperto del Nuovo Mercato Testaccio (spessore pareti 2,1 cm).
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (aprile 2021) non sono stati individuati confronti; in CIL XV, 3413 è segnalato un bollo CC in lettere cave, sul collo di un’anfora non identificata, indicata tuttavia come piccola64.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il bollo, mutilo, potrebbe in via d’ipotesi contenere una formula onomastica.
6) P.C.T“HE”
P. C(—) The(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4576, US 486: P.C.T“HE”
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio; segni d’interpunzione quadrangolari; tracce probabilmente imputabili al punzone utilizzato per la bollatura;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica.
FIGURE: Fig. 34.4
MORFOLOGIA: gruppo I
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Non sono stati al momento (maggio 2021) individuati confronti.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nella sigla si può scorgere l’abbreviazione di tria nomina, con un cognomen, The(—), verosimilmente grecanico con connotazione servile, che potrebbe dar luogo a varie integrazioni65. Nel personaggio del bollo potrebbe pertanto essere riconosciuto un individuo di estrazione libertina. Si segnala l’attestazione del marchio nei livelli più antichi individuati presso la discarica NE del Nuovo Mercato.
7) Q.C.A66
Q. C(—) A(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4375, US 358: Q.C.A
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio; segni d’interpunzione circolari o sub circolari;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 34.5
MORFOLOGIA: non riscontrabile sull’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (maggio 2021)
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nella sigla si può scorgere, in via di ipotesi, l’abbreviazione di tria nomina, ridotti alle sole iniziali.
8) C“AD”MVS69
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
Il bollo è attestato in un caso insieme al marchio BARBARI (inv. 1213, US 375)70.Tutte le attestazioni si registrano su ansa e sono in lettere a rilievo entro doppio cartiglio (o cartiglio con linee guida). La forma del cartiglio del reperto inv. 3089 (sottolineato nell’elenco) si differenzia dalle altre, in quanto non rettangolare, identificando un diverso punzone; leggere differenze rispetto ai restanti bolli si riscontrano nel marchio inv. 2271.
- inv. 1213, US 275: BARBARI//C“AD”MVS;
- inv. 2271, US 310: C“AD”M[V]S
- inv. 3089, US 2710: C“AD”MVS;
- inv. 3092, US 550: [C]“AD”MV[S].
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica e II fase discarica a S del muro in reticolato; settore W, fase ?
FIGURE: Figg. 4; 35.2; 36.10-12
MORFOLOGIA: NMT_AAD Orlo 5 = D6A, gruppo III (inv. 1213, US 375)
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (agosto 2021)71
Italia
Marina di Città Sant’Angelo (PE), atelier
- C*“AD”MVS. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).
Bibliografia: Staffa 2003, pp. 125-126, Fig. 7,2.
Atri (TE)
- C“AD”MVS. Posizione: ? Caratteristiche: doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).
Bibliografia: CIL IX, 6080, 7b.
Civitella Casanova (PE)
- C“AD”MVS. Posizione: ? Caratteristiche: doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).
Bibliografia: CIL IX, 6080, 7a.
Modena
- RVBRI // C“AD”MI. Posizione: anse. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: Mongardi 2013, pp. 462-464; Mongardi 2018, pp. 87-90; p. 176, n. 71; p. 194, n. 106 (Parco Novi Sad, bonifica SE, US 2433, età flavia).
Crotone (controllo autoptico in data 26 agosto 2021 presso Museo Archeologico Nazionale)72
- RVBRI // C“AD”MI. Posizione: anse. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: https://www.progettomusas.eu/portfolio/anfora-dressel-6a/ (consultato in data 18.10.2023).
Roma
- C“AD”MVS. Posizione: ? Caratteristiche: doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).
Bibliografia: CIL XV, 2769, 1-2.
Note: due reperti di cui uno rinvenuto nei pressi delle Terme di Diocleziano, irreperibili.
Austria
Magdalensberg
- C“AD”MVS. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro doppio cartiglio rettangolare (o cartiglio rettangolare con linee guida).
Bibliografia: Maier & Maidl 1992, p. 101.
Note: attribuito ad anfora Lamboglia 2.
Turchia
Efeso
- C“AD”MVS. Posizione: ansa. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare con linee guida (o doppio cartiglio rettangolare).
Bibliografia: Bezeczky 2006, p. 306 = Bezeczky 2013, p. 116.
Note: il frammento è attribuito a Lamboglia 2; esso è attestato in un contesto di incerta datazione73.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Si rimanda alla discussione del bollo BARBARVS (cfr. supra, pp. 145-153).
9) T.CAE / FVSCI74
T. Cae(—) Fusci
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
Tutti gli esemplari sono in lettere cave e impressi verticalmente sul collo. Potrebbe avere un cartiglio rettangolare il reperto inv. 4404 (sottolineato nell’elenco), qualora non si tratti di una traccia molto evidente del punzone utilizzato per la bollatura:
- inv. 1026, US 345 (irreperibile 2015): T.CAE / FVSCI (tracce del punzone utilizzato per eseguire la bollatura), impasto 6;
- inv. 2261, US 593 T.CAE/FVSCI (tracce del punzone utilizzato per eseguire la bollatura), impasto 6;
- inv. 2623, US 220: T.CAE / FVSCI, impasto 6;
- inv. 2624, US 220: T.CAE / FVSCI, impasto 8;
- inv. 2625, US 220: T.C[AE] / FV[SCI], impasto 8;
- inv. 4404, US 2696: T.CAE / FVSC[I], impasto 3.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica e obliterazione discarica a S del muro in reticolato; settore W: ?
FIGURE: Fig. 34.6-10
MORFOLOGIA: gruppo I (invv. 1026, 4404)
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (maggio 2021)
- Italia: Atri (TE)75; Modena76; Oderzo (TV)77; Roma78; Susa (TO)79.
- Israele: Caesarea Maritima, presso Haifa80.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nel bollo si può leggere una formula onomastica con gentilizio abbreviato, che potrebbe sciogliersi come Caesernius, Caecilius o Caesius81. Si segnala tuttavia che la gens Caesia era sicuramente coinvolta nella produzione anforaria (vd. il marchio seguente). Il cognomen latino Fuscus è ben attestato, sia tra ingenui che tra individui di condizione servile e libertina82.
Per questo bollo si ipotizza, sulla base dei contesti di rinvenimento veneti, una cronologia compresa tra l’età claudia e quella flavia, che non è discordante con le fasi di attestazione presso il Nuovo Mercato Testaccio83.
10) CCAESI / NASIC“AE”
C. Caesi Nasicae
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4399, US 3233: CCAESI / NASIC“AE”
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio;
impasto 6.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum?
FIGURE: Fig. 40.1
MORFOLOGIA: non desumibile dal reperto del Nuovo Mercato Testaccio. Il frammento di parete su cui il timbro è apposto ha uno spessore 1,3 cm, mentre l’unico confronto, molto puntuale anche per l’aspetto del punzone e la dimensione delle lettere, è al momento rappresentato da un’anfora opitergina di tipo Dressel 6A.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (maggio 2021)
- Italia: Oderzo (TV)84.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
L’interpretazione del bollo opitergino, data per incerta (Caesi Nasicae, Caesi(ani) Nasicae o C. Aesi Nasicae), viene ad essere precisata dal marchio del Nuovo Mercato Testaccio, soprattutto in considerazione del fatto che il cognomen Nasica, estremamente raro85, si presenta invece nell’onomastica della gens Caesia. Si veda infatti il Caesius Nasica legatus legionis in Britannia sotto A. Didius Gallus, a sua volta legatus Augusti propraetore negli anni 52/53 e 57/5886. La cronologia del personaggio, a proposito del quale non si dispone di ulteriori notizie di rilievo, è coerente con quella dell’attestazione opitergina del bollo87.
11) C*.CA*R.FRON88
C. Car(istanius) Fron(to)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4367, US 461: C*.CA*R.FRON o C*.CA*R.FRO“N[T]”*
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio; segni d’interpunzione rettangolari o sub-rettangolari;
impasto 10.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 40.2
MORFOLOGIA: non riscontrabile sugli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (maggio 2021)89
- Italia: Aosta; Cupra Marittima (AP), Lucera (FG), Modena90, Padova91, Pescara92, Roma93, Verona, Trieste.
- Albania: Dimale.
- Austria: Magdalensberg94.
- Croazia: Cavtat.
- Spagna: villa di Els Antigons (Tarragona)95.
- Tunisia: Cartagine96.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nel C. Caristanius Fronto97 che bolla i contenitori si è voluto riconoscere98, sulla base della cronologia delle attestazioni, un ascendente del console omonimo di età domizianea99, piuttosto che lo stesso magistrato o un suo figlio come adombrato nella PIR100.
Un C. Caristanius Fronto è attestato nell’epigrafia lapidaria della colonia triumvirale o augustea di Sutrium, odierna Sutri, in particolare da una lastra con elenco dei nomi dei pontifices, databile proprio all’epoca di Augusto o al più tardi a quella di Tiberio101, mentre bolli laterizi provenienti da una villa scavata al principio del Novecento lungo la via Cassia, alla biforcazione con la Veientana, databili ancora alla primissima età imperiale, restituiscono il nome di un C. Caristanius102, forse da identificare con il personaggio sutrino, anche in considerazione della rarità del gentilizio103. L’appartenenza all’élite municipale di una comunità dell’Etruria meridionale fortemente legata al princeps, può aver fatto da volano alla crescita economica e alla diversificazione degli investimenti da parte della famiglia, favorendone l’estensione degli interessi verso il territorio adriatico, particolarmente attrattivo per la cerchia augustea104.
Coerentemente con la cronologia delle attestazioni del bollo, anche in ambito orientale un C. Caristianus Fronto Caesianus Iulius o più probabilmente Iullus105, praefectus pro IIviro dei consoli del 12 a.C. e del 3 d.C., è ricordato nell’epigrafia monumentale della colonia augustea di Antiochia di Pisidia106. Se è probabile un’origine italica dei Caristanii,occorre d’altra parte sottolineare che l’onomastica del praefectus ne suggerisce, nel quadro di una prassi di alleanze familiari, l’adozione da parte di un Caristanius e l’originaria appartenenza alla gens Caesia107. Pare suggestivo poter ravvisare anche nell’epigrafia anforaria un legame tra le due gentes sul piano economico, essendo i Caesii coinvolti, al pari dei Caristanii, nella fabbricazione di contenitori da trasporto in area adriatica, come dimostra il bollo CCAESI/NASIC“AE”108.
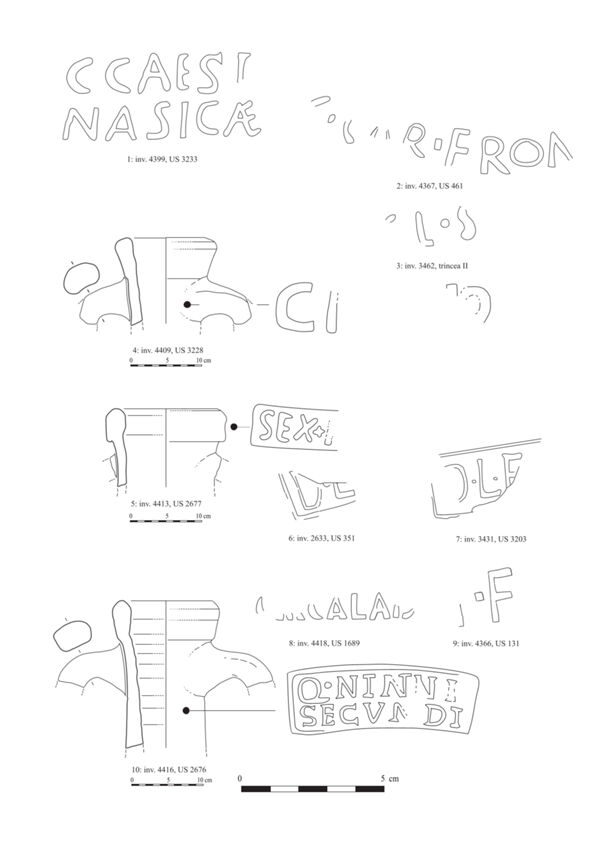
12) [“TI”]C*L.S
Ti. Cl(—) S(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 3462, trincea II: [“TI”]C*L.S
posizione: parete;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio, segno d’interpunzione circolare;
impasto 1.
FASI DI ATTESTAZIONE: sporadico
FIGURE: Fig. 40.3
MORFOLOGIA: non determinabile sulla base dei reperti del Nuovo Mercato Testaccio
CONFRONTI E DIFFUSIONE (maggio 2021)109
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
L’onomastica, considerata la buona probabilità dello scioglimento di prenome e gentilizio in Ti(berius) Cl(audius), denuncia che si tratterebbe di un liberto della gens Claudia, forse addirittura di un liberto imperiale: la proposta formulata non contrasta la cronologia delle attestazioni del bollo e la conseguente attribuzione dei contenitori recanti tale marchio ad un’epoca compresa tra la metà del I sec. e l’80 d.C.114.
Recenti analisi chimiche su materiali adriatici bollati sembrano suggerire per i contenitori con questo marchio una provenienza medio-adriatica115.
13) CI*[]I*P*
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4409, US 3228: CI*[]I*P*
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum.
FIGURE: Fig. 40.4
MORFOLOGIA: gruppo I
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (maggio 2021) non sono stati individuati confronti.
14) [C]RISPIN[I]** / [VA]LE*R*IA[NI]
Crispini Valeriani?
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 2263, US 310: [C]RISPIN[I]** / [VA]LE*R*IA[NI]
posizione: collo;
caratteristiche: lettere a leggero rilievo entro doppio cartiglio; cattiva impressione;
impasto 2
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato.
FIGURE: Fig. 48.6
MORFOLOGIA: non desumibile dal frammento del Nuovo Mercato Testaccio (spessore del collo 2,1 cm).
CONFRONTI E DIFFUSIONE (marzo 2024)
- Italia: Concordia Sagittaria (VE)116.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
L’onomastica del personaggio che bolla l’anfora è ricostruibile grazie a uno dei due reperti di confronto rinvenuti a Iulia Concordia in un contesto di bonifica databile al I sec., una Dressel 6A e una Dressel 6B. Su quest’ultima si legge Crispini / Valeriani. L’iscrizione potrebbe corrispondere al genitivo di due cognomina riferibili a personaggi diversi associati nella bollatura. A favore di tale ipotesi sembrerebbero deporre la specificità del doppio cartiglio e la disposizione dell’onomastica su due righe. In alternativa il marchio potrebbe contenere un unico nome e forse riferirsi al T. Quinctius Crispinus Valerianus, pretore nel 2 a.C., console suffetto nel 2 d.C., curator locorum publicorum iudicandorum sotto Tiberio, frater et magister Arvalium117. Questi si aggiungerebbe a una lunga lista di eminenti esponenti della vita politica di Roma e della cerchia imperiale, coinvolti nella produzione e nel commercio di vino e olio adriatico. A parziale conferma di tale ipotesi si sottolinea che sono scarsamente attestati in ambiente servile e libertino i cognomina Crispinus e Valerianus118, quest’ultimo probabilmente dovuto, nel caso del personaggio in questione, a un’adozione. Non sono tuttavia al momento evidenti i legami di T. Quinctius Crispinus Valerianus con l’Adriatico119. Nell’eventualità in cui sia corretta l’identificazione, risulta suggestiva l’ipotesi formulata in letteratura che nelle mani del console del 2 d.C. siano confluite le manifatture di anfore olearie dei Quinctii e quelle di contenitori vinari dei Valerii, collocate ipoteticamente nel territorio veronese e nella zona della Valpolicella. Tuttavia l’esame macroscopico dell’impasto del frammento bollato del Nuovo Mercato sembra orientare verso l’ambito medio-adriatico.
15) THB o T.H.B120
T. H(elvius) B(asila) o T. H(elvii) B(asilae)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
Come già rappresentato, non è stato possibile rintracciare alcun tipo di correlazione specifica e univoca tra le varianti del bollo, le argille e la morfologia degli orli dei contenitori121. Nelle tavole allegate al presente lavoro sono rappresentati gli esemplari di bollo che consentono osservazioni morfologiche sui contenitori. Tutti gli esemplari sono in lettere cave e privi di cartiglio, talvolta essi presentano tracce del punzone con cui è stata effettuata la bollatura (es. invv. 1447, 1666, 2247), talaltra si verificano casi di punzonature sovrapposte (es. inv. 3112):
| inv. 1190, US 563: [TH]B; | inv. 2275, US 463: T.HB; | inv. 2652, US 797: TH[B]**; |
| inv. 1407, US 760: T.H[.B]; | inv. 2279, US 642: THB; | inv. 3105, US 56: [TH]B; |
| inv. 1447, US 691: T.H.B (doppio); | inv. 2280, US 556: T.H.B; | inv. 3106, US 3224: T.H.B; |
| inv. 1666, US 356: T.H.B; | inv. 2283, US 523: T*HB; | inv. 3107, US 2428: [T].H.B; |
| inv. 2101, US 523: T*.H[.B]; | inv. 2284, US 481: T.H[.B]; | inv. 3108, US 128: T.H.B; |
| inv. 2243, US 816: T*.H.B; | inv. 2286, US 638: T.H.B*; | inv. 3109, US 3235: T.H.B; |
| inv. 2245, US 816: [TH]B; | inv. 2291, US 562: T.H.B; | inv. 3110, US 160: T*H.B; |
| inv. 2246, US 816: TH.B; | inv. 2619, US 562: T*HB; | inv. 3111, US 1747: [T.]H.B; |
| inv. 2247, US 548: T.H.B; | inv. 2620, US 220: THB; | inv. 3112, US 3224: T.H[.B]; |
| inv. 2255, US 631: T*HB; | inv. 2621, US 315: [T.]H.B; | inv. 3113, US 21: T.H[.B]; |
| inv. 2266, US 592: T*HB; | inv. 2622, US 250: T.H.B; | inv. 3114, US 3016: T.H.B; |
| inv. 2267, US 563: T*.H.B; | inv. 2627, US 220: THB; | inv. 3118, US 4030: T*HB; |
| inv. 2269, US 589: T.H.B; | inv. 2636, US 169: [T]HB; | inv. 3119, US 294: T.H.B; |
| inv. 2272, US 262: T.H.B*; | inv. 2637, US 220: THB; | inv. 3227, US 3077: T.H.B; |
| inv. 2274, US 341: [T]HB; | inv. 2638, US 339: T.H.B; | inv. 3403, US 366: [T]HB. |
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, intera sequenza stratigrafica da epoca antica (con l’eccezione della II fase a N del muro in reticolato) sino ad età contemporanea; settore W: livelli antichi (dalla fase pre-horreum al tardo-antico).
FIGURE: Figg. 41-45; 58
MORFOLOGIA:
- gruppo I (invv. 2637, 3403);
- gruppo II (invv. 2245, 2247, 2255, 2266, 2267, 2269, 2274, 2275, 2279, 2280, 2283, 2291, 2619, 2636, 2638, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3118, 3119, 3227).
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (aprile 2024)122
- Italia: Cupra Marittima123; Adria124; Altino; Aquileia; Bergamo; Chiunsano (RO)125; Concordia Sagittaria (VE)126; Cremona; Este; Fiumicino (RM)127; Gavello (RO); Ivrea (TO); Milano; Novara; Oderzo (TV)128; Ordona (FG)129; Ostia (Roma); Modena130; Padova; Parma131
Pegognaga (MN), loc. San Lorenzo132; Reggio Emilia; Roma133; San Bellino (RO); Tortona (AL); Treviso134; Urbs Salvia (MC); Vercelli; Verona; Vicenza. - Austria: Magdalensberg.
- Cipro: Nea Paphos135.
- Grecia: Atene; Corinto.
- Germania: Mainz; Neuss136.
- Paesi Bassi: Kops Plateau (Nijmegen)137.
- Tunisia: Cartagine.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE138
Nella sigla THB è stato comunemente riconosciuto il padre, non altrimenti noto a quanto mi consta, del proconsole e legatus Augusti di prima età imperiale, T. Helvius Basila139, il patronimico del quale, nelle iscrizioni sopravvissute, non esclude l’omonimia col genitore, tenuto in conto che ancora almeno in epoca proto-augustea la trasmissione del prenome di padre in figlio non era automatica.

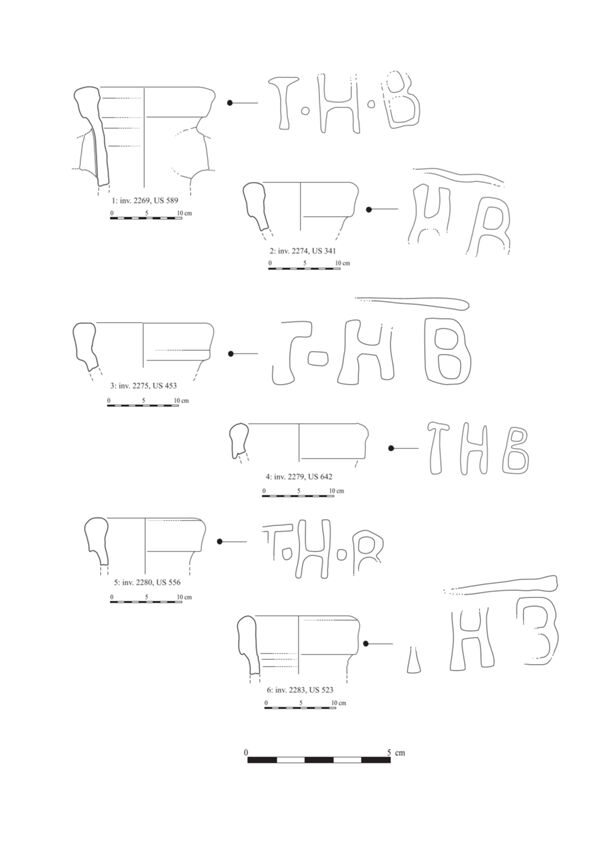
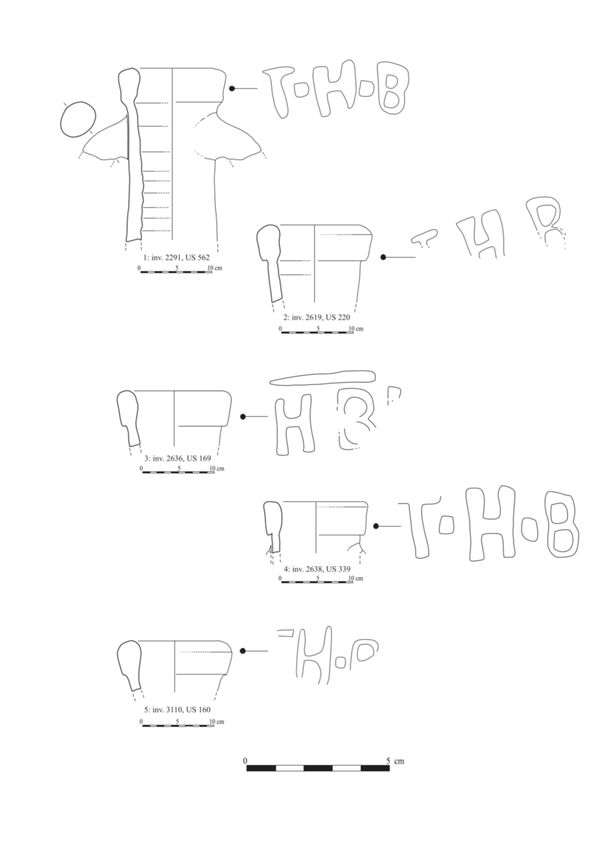
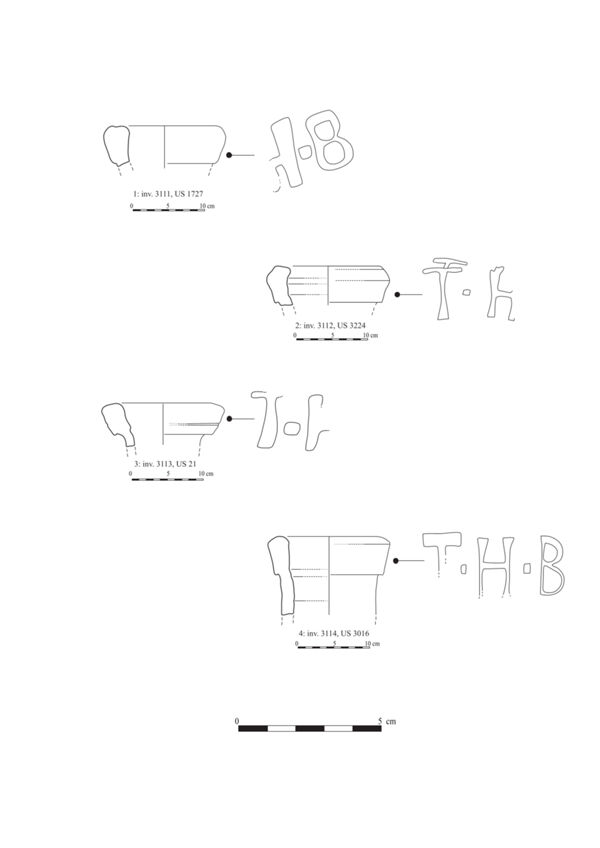
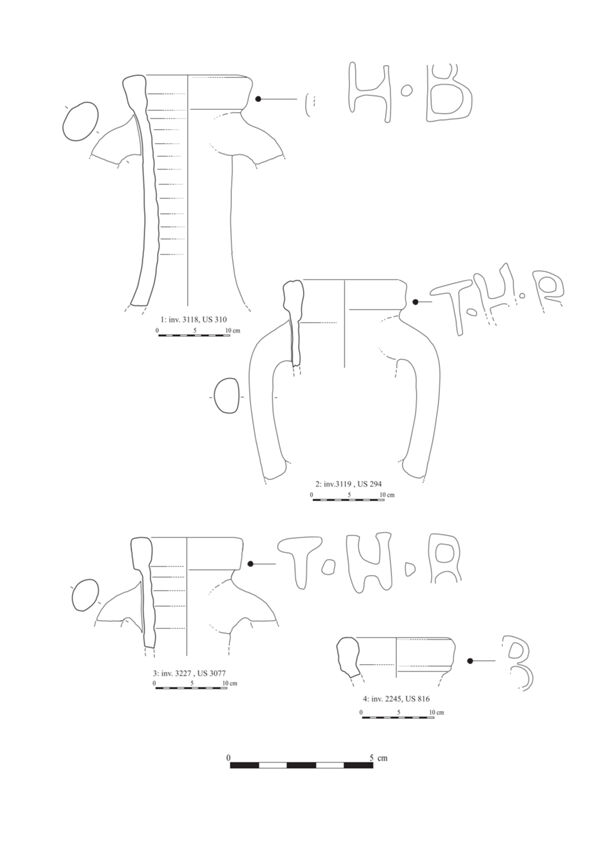
Personaggio
L’origine del T. Helvius Basila proconsole e legato imperiale, a proposito del quale si dispone di qualche notizia, è attribuita, sulla base di un piccolo dossier epigrafico, al Lazio meridionale141. Occorre ricordare che a favore di questa comunità, come commemorato dalla figlia Helvia Procula nell’iscrizione CIL X, 5056 (= ILS, 977)142, il ricco senatore istituì per lascito testamentario la prima fondazione alimentare privata a vantaggio dell’infanzia di cui si abbia notizia, dotandola di un notevole capitale, evidentemente in virtù di una consistente disponibilità patrimoniale143.
Paiono documentati del resto l’origine atinate di alcuni personaggi della corte augustea e il conseguente prestigio della città, circostanza che potrebbe aver dato luogo all’attribuzione dell’epiteto potens ad Atina nella poesia virgiliana (Verg., Aen. 7, 629-631)144.
La collocazione cronologica del T. Helvius Basila proconsole e legato imperiale è problematica: la carica di legatus Caesaris Augusti da questi ricoperta è stata variamente attribuita a un’epoca compresa tra i regni di Augusto/Tiberio e Claudio/Nerone145, sebbene, sulla base di rinvenimenti epigrafici avvenuti in ambito anatolico, la cronologia dell’incarico, espletato in Galazia, paia ormai potersi circoscrivere tra gli ultimi anni del regno di Tiberio e l’inizio di quello di Caligola146. Tale governatorato avrebbe rappresentato l’apice della carriera di Basila, a poca distanza dal quale egli sarebbe morto, non essendo menzionata altra successiva carica nel cursus honorum ascendente rappresentato nella già citata epigrafe posta dalla figlia Procula, la quale a sua volta offre un piccolo seppur non particolarmente significativo tassello cronologico, essendo stata moglie di un personaggio di rango senatorio, C. Dillius Vocula (CIL VI, 1402 = ILS, 983), morto nel 70 d.C., mentre combatteva in Germania147.
Cronologia delle attestazioni
Sulla base di una testimonianza del Magdalensberg, dove il bollo è associato a un titulus pictus con datazione consolare (38 d.C.) e possibile menzione del contenuto dell’anfora, ovvero (vinum) kalab(rum), invecchiato quattro anni, recentemente si è voluto riconoscere nel marchio THB le iniziali dei tria nomina del T. Helvius Basila legato imperiale e non del padre, la cui attività produttiva era invece collocata in epoca augustea148. L’ipotesi è peraltro coerente con la collocazione cronologica del legato imperiale, come precisata nella letteratura specialistica. Tuttavia, in un recente contributo sul significato cronologico delle anfore del Magdalensberg è stato formulato l’invito a considerare secondari rispetto alla datazione dei contenitori da trasporto i tituli picti, per la possibilità che siano stati apposti in occasione di un eventuale riuso del contenitore149.
Il bollo THB compare ad ogni modo al Nuovo Mercato Testaccio anche nei livelli più antichi individuati nella discarica NE ed è attestato in contesti datati, alcuni dei quali si presentano qui a titolo d’esempio:
- ad Altino il marchio compare in un banco d’anfore, cui è frammista ceramica di tradizione paleoveneta e una patera in sigillata aretina databile alla II metà del I sec. a.C., per cui è stata proposta una datazione tra la II metà avanzata del I sec. a.C. e l’età augustea150;
- a Verona è stato individuato nel contesto di un intervento di sistemazione della sponda destra dell’Adige datato tra la fine del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C.151;
- a Vicenza il bollo THB si trova in un terrapieno, in cui il riutilizzo delle anfore si colloca in età claudia152;
- a Parma il marchio è rappresentato da cinque esemplari in un’opera di consolidamento del terreno funzionale alla viabilità, databile ad età tiberiano – claudia153;
- a Milano il bollo compare negli scavi di via Croce Rossa e più precisamente in una sepoltura a cremazione assegnabile al periodo I, fase a (frequentazione a scopi funerari), che ha restituito due tombe, una ad inumazione della prima età augustea e l’altra, quella in interesse, a cremazione con corredo riconducibile ad epoca compresa tra l’età augustea e la prima metà del I sec.154;
- a Ostia è presente nel deposito della Longarina (Longarina 1), il cui materiale, recentemente rivisto, ha consentito di allargare prudenzialmente il range cronologico del deposito, ma non ha sostanzialmente contraddetto la datazione all’età augustea della sistemazione della bonifica ad anfore, ipotizzata da A. Hesnard155;
- a Roma il marchio compare al Palatino, in ambienti annessi al Tempio della Magna Mater, in livelli d’epoca giulio-claudia rimaneggiati (informazione personale Fulvio Coletti);
- al Magdalensberg il bollo compare in livelli della tarda età augustea156.
Il bollo è assente nel muro della Byrsa a Cartagine, dove sono state recuperate tredici iscrizioni con datazione consolare compresa tra il 43 e il 15 a.C.; tale circostanza ne ha fatto presupporre la diffusione a partire almeno dall’ultimo decennio del I sec. a.C. o dai primi anni successivi al cambiamento d’era157.
Si rappresenta che un esemplare di bollo THB compreso in CIL XV, 2905 recava un titulus pictus in rosso sul collo (CIL XV, 4657g) M. Utan(i) Hym(enaei), che ricorre anche su anfore con bollo BARBA (CIL XV, 3408c), nonché come marchio (?) in lettere cave entro cartiglio su un contenitore di forma imprecisata (CIL XV, 3546). Sebbene la formula onomastica dipinta sia nel complesso di dubbia interpretazione, in letteratura essa viene incidentalmente indicata come riferibile a un mercator158 le anfore di Basila e quelle di Barbarus, cui perterrebbe il bollo BARBA, avrebbero pertanto potuto essere veicolate dallo stesso M. Utanius Hymenaeus, fatto che deporrebbe, congiuntamente ad altri indizi, per una contestualità delle produzioni159. Come già rilevato, inoltre, si rinvengono anche altri tituli picti in comune tra le due produzioni, traccia, se non di altro, di un destino comune dei contenitori.
Luogo di produzione
La produzione anforaria di T. Helvius Basila si colloca in area medio-adriatica, in via d’ipotesi a Cupra Marittima, sul litorale a S di Fermo160. In località Montecantino di Cupra è stata infatti individuata una fornace ceramica nell’ambito della quale sarebbero stati rinvenuti alcuni frammenti bollati THB; tale dato, congiuntamente alla frequente attestazione del marchio sul territorio, indizierebbe una produzione in loco dei contenitori con tale bollo. La pubblicazione dei dati e dei reperti è tuttavia lacunosa e non vi è traccia di T. Helvius Basila o di suoi affini nell’epigrafia lapidaria locale161.
Al Piceno rimandano ad ogni modo l’esame macroscopico delle argille del nostro contesto e quello chimico e petrografico. Non è noto alcun legame di T. Helvius Basila con la regione. Su base epigrafica è stata tuttavia ipotizzata l’esistenza di rapporti parentali e matrimoniali della gens Helvia con altre famiglie titolari di proprietà e/o attività manifatturiere in ambito adriatico, come i Rubrii162 e i Visellii163.
Come già si accennava, inoltre, in un titulus pictus su un’anfora bollata THB dal Magdalensberg potrebbe essere menzionato il (vinum) kalab(rum), ovvero prodotto nella Calabria (Salento, Puglia meridionale). Tale titulus è stato messo in rapporto da D. Manacorda164 con il cippo funerario in pietra leccese di uno Zethus, servo di Basila. Rinvenuta a Galatina, in provincia di Lecce165, l’iscrizione potrebbe testimoniare l’esistenza di proprietà degli Helvii Basilae in quest’area in epoca tardo-repubblicana o primo-augustea, quando l’epigrafe pare collocarsi su basi paleografiche e linguistiche166. L’ipotesi che il vino salentino di Basila sia stato imbottigliato nei praedia picena di questi, dove, secondo D. Manacorda, sarebbe giunto su navires à dolia167, sembra al momento priva di riscontri.
Occorre inoltre ribadire che il titulus pictus kalab(rum) potrebbe essere stato apposto in occasione di un riutilizzo del contenitore e che l’espressione stessapotrebbe essere ambigua e riferirsi tanto al contenitore quanto al contenuto dell’anfora o ancora ad entrambi, come già rilevato per analoghi casi rappresentati nella documentazione papiracea dell’Egitto greco-romano168.
Con riguardo alle pur caute ipotesi di una produzione anforaria in ambito meridionale169, manca per il contenitore del Magdalensberg una descrizione dell’impasto170, che avrebbe forse consentito di discriminare tra un’eventuale produzione picena e una salentina. Si sottolinea che le analisi condotte sugli esemplari del Nuovo Mercato indirizzano verso l’area medio-adriatica; le analisi degli impasti dell’anfora bollata THB, rinvenuta negli scavi di via Croce Rossa a Milano, non offrono invece ulteriori spunti di riflessione, trovando generico riscontro con le argille dell’area situata tra il Piceno e la Puglia meridionale171. Recenti analisi chimiche su materiali adriatici bollati sembrerebbero corroborare l’ipotesi di provenienza medio-adriatica per i contenitori con marchio THB172.
Non sorprendono ad ogni modo la vastità degli interessi fondiari e la diversificazione degli investimenti, a garanzia della tenuta economica del patrimonio, già verificate per altre famiglie173. Sebbene non sia possibile stabilire quali fossero ruolo, attività e struttura produttiva di eventuali fondi salentini, l’ipotesi che gli Helvii Basilae avessero delle proprietà anche in area meridionale presenta alcuni elementi di forza. Da un lato occorre notare la rarità del cognomen Basila174; dall’altro è archeologicamente testimoniato il coinvolgimento della gens Helvia nella produzione e nel commercio di anfore e/o olio brindisini, dimostrato da rinvenimenti effettuati nella Hispania Citerior175. Si tratta tuttavia di C. Helvii, forse il medesimo ramo della famiglia implicato alla fine del I sec. a.C. nei traffici con l’Oriente. Si segnala infine che la già citata Helvia Procula doveva avere dei possedimenti in Italia meridionale, in particolare nell’area di Padula (SA), come testimoniato da un’iscrizione a carattere funerario176.
Sintesi
In sintesi, dovendosi ritenere plausibile lo scioglimento della sigla THB accreditato in letteratura, non si può stabilire in via definitiva se in essa sia effettivamente da riconoscere il T. Helvius Basila legato di Tiberio/Caligola o il padre di questi. Per ipotesi potrebbe esservi stata una successione tra i due e la produzione in questione potrebbe aver avuto una certa durata nel tempo.
Volendosi attenere alle testimonianze materiali, in considerazione della datazione di alcuni contesti di rinvenimento del bollo THB, rappresentati per lo più da bonifiche ben studiate o da livelli di discarica come nel caso del Nuovo Mercato Testaccio, difficilmente circoscrivibili da un punto di vista cronologico, le manifatture in questione dovrebbero essere state attive almeno dall’età augustea. L’inquadramento non è in contraddizione con le testimonianze di attività economico-produttive della gens Helvia e di un Basila in area salentina già in epoca tardo-repubblicana.
Qualora si accogliesse l’ipotesi in merito al valore datante del titulus del Magdalensberg, si dovrebbe presumere che l’attività sia proseguita fino all’epoca di Caligola / Claudio.
L’attività manifatturiera di T. Helvius Basila deve localizzarsi in area picena, sebbene la famiglia avesse con buona probabilità altre proprietà nel Meridione d’Italia e fosse titolare di interessi e rapporti, ben rappresentati nell’epigrafia atinate, anche nel Lazio meridionale.
16) SEX.I*[“VL”.SE“VER”]
Sex.Iul(ius) Sever(us)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4413, US 2677: SEX.I*[“VL”.SE“VER”]
posizione: orlo;
caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare; segno d’interpunzione cruciforme;
impasto: 10.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase ?
FIGURE: Fig. 40.5
MORFOLOGIA: gruppo IV
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)177
- Italia: Brescia, Padova, Verona178.
- Austria: Magdalensberg.
- Tunisia: Cartagine.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Sono noti più Iulii Severi179, tra cui un Sextus di rango senatorio180, la cui cronologia (console nel 127 d.C.) non consente un’identificazione con il personaggio che bolla le anfore adriatiche in esame, attestate in contesti compresi tra l’età augustea e il 45 d.C.
Il cognome latino risulta molto diffuso ed è attestato di conseguenza anche tra schiavi e liberti, sebbene non con una media particolarmente significativa181.
Si segnala infine che diversi esponenti della gens Iulia, tra cui, con il prenome Sextus, un Sex. Iul(—) Orp(—), probabilmente Sex. Iul(ius) Orp(haeus), e un Sex. Iulius Aequanius Lautus (cfr. infra, pp. 218-219), bollano anfore di produzione adriatica.
Con riguardo alla provenienza182, si è postulata un’origine medio-adriatica dei contenitori che recano questo bollo, in considerazione delle caratteristiche morfologiche delle anfore e della geografia distributiva di esse; inoltre nella regione la produzione olearia era associata a quella vinaria ed erano fabbricate sia Dressel 6A che 6B per l’invasamento e il trasporto. A Verona, in effetti, il marchio risulta attestato sul secondo tipo di contenitore.
17) D.L.F*[.PRI]
D. L(—) F(—) Pri(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
I due esemplari di questo marchio si presentano sul collo (sp. 1,5 – 1,6 cm) in lettere cave entro doppio cartiglio rettangolare con segni d’interpunzione circolari:
- inv. 2633, US 351: D.L*[.F.PRI], impasto 7;
- inv. 3431, US 3203: D.L.F*[.PRI], impasto 3.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato; settore W, fase horreum imperiale
FIGURE: Fig. 40.6-7
MORFOLOGIA: non desumibile dal reperto del Nuovo Mercato Testaccio.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021).
- Turchia: Efeso183.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il reperto efesino consente l’integrazione del bollo del Nuovo Mercato Testaccio.
Nella sigla può forse intravvedersi una formula ridotta alle sole iniziali dei tria nomina, seguita da un secondo elemento onomastico, un cognomen o un nome unico abbreviato184.
18) ]L*OIEN / ]FID
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4402, US 2534: ]L*OIEN / ]FID.
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum
FIGURE: Fig. 48.8
MORFOLOGIA: non determinabile sulla base dell’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (ottobre 2021) non sono stati individuati confronti puntuali.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il bollo contiene con buona probabilità una formula onomastica; la frammentarietà del reperto e l’andamento della frattura non consentono di valutare la consistenza della lacuna iniziale del marchio. Alla prima riga si potrebbe leggere il gentilizio Loienus, che, sebbene non presente nei repertori onomastici185, è attestato in un’epigrafe urbana datata alla prima metà del I sec.186; seguirebbe un cognomen integrabile a mero titolo esemplificativo in Aufidus187 oppure in Fidelis o Fidus188.
Si segnalano, ad ogni buon conto, anche alcuni bolli anforari su Dressel 6A, attribuiti a un esponente della gens Aufidia, M. Aufidius Scaeva, che compare su una delle monete coniate nel 37-36 a.C., al tempo della guerra contro Sesto Pompeo, dalla zecca militare di Ottaviano nella base navale di Lipara; la gens è altresì coinvolta nella fabbricazione di materiale laterizio sia in ambito alto che medio-adriatico189. A titolo informativo si aggiunge inoltre un bollo F*IDI da Cartagine apposto su contenitore di tipologia imprecisata190. L’integrazione della seconda riga del bollo del Nuovo Mercato con il gentilizio Aufidius191 pare possibile anche se non certa192. Se si segue lo schema di alcuni marchi di Aufidius Scaeva (SC“AE”“VAE”“AVF”IDI), alla prima riga potrebbe trovarsi un cognomen.
19) C*M*CALAI*S*
C. M(—) Calais
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4418, US 1689
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio;
impasto 6.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase medio o tardo-imperiale horreum
FIGURE: Fig. 40.8
MORFOLOGIA: non determinabile sulla base dei reperti del Nuovo Mercato
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il bollo contiene una formula onomastica nella quale il cognomen è rappresentato da un grecanico di connotazione servile, Calais, le cui attestazioni si concentrano nel I secolo196.
20) [L.]N*.F
L. N(—) F(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4366, US 131: [L.]N*.F
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio; segni d’interpunzione quadrangolari;
impasto 10.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, età moderna (fase orti e vigne rinascimentali)
FIGURE: Fig. 40.9
MORFOLOGIA: non determinabile sulla base dell’esemplare del Nuovo Mercato.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
In letteratura202 viene proposto lo scioglimento della sigla nella formula onomastica L. n(umerius) F(elix)203. L’epigrafia anforaria restituisce i bolli su Dressel 6A (e forse Lamboglia 2) di un Numerius, il cui prenome è però Quintus204.
È d’obbligo pertanto segnalare anche il bollo NVMISIAELF/FIRMILLAE – Numisiae L(ucii) f(iliae) Firmillae – attestato sia a Modena, in più esemplari206. Il bollo, di età giulio-claudia, è attribuito, sulla base di spunti prosopografici e toponomastici, a una produzione anforaria emiliana.
Ben nota è l’attività manifatturiera dei Numisii207: ci si riferisce in particolare al celebre manufatto – forse una tegola mammata – conservato nel Museo Archeologico di Cesena su cui compare, incisa prima della cottura, l’espressione L. Numisi / C. Comici / [[ -c. 6-]] / [[c. 4/5]] / figulos / bonos. Di provenienza incerta, ma probabilmente da attribuire all’agro cesenate, un comprensorio dipendente in antico da Ariminum, il reperto si data al II – I sec. a.C. per le caratteristiche paleografiche. Il gentilizio Numisius, di origine etrusca, ben attestato in Italia, risulta testimoniato nella Regio VIII a Modena, Ravenna, Forlì e Cesena; degno di nota è inoltre il rinvenimento a Concordia (VE) dell’iscrizione sepolcrale, riferibile alla prima metà del I sec. d.C., di L. Numisius C. f., che fu aedilis a Forum Cornelii, ossia nell’attuale Imola (BO)208. Da ultimo si segnala la menzione, nella Tabula alimentaria di Veleia, di un fundus Numisianus, ubicato nel distretto Erculanio dell’agro piacentino209.
La formula onomastica di Numisia Firmilla risulta assonante con il bollo L.N.F; sebbene manchi un riscontro prosopografico, si potrebbe vedere nella donna l’erede della produzione anforaria paterna, attribuibile ad un L. Numisius Firmus (?), la cui ascendenza verrebbe sottolineata, al pari di quanto avviene nei bolli di Rubria, figlia di Barbarus (cfr. infra, pp. 197-199)210. La cronologia dei confronti individuati non è incompatibile con questa ipotesi. La suggestione, per ora priva di riscontri, è da approfondire con riguardo a morfologia e impasto dei contenitori.
21) Q.NINNI / SECVNDI211
Q. Ninni Secundi
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4416, US 2676: Q.NINNI / SECVNDI
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave entro doppio cartiglio rettangolare;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase ?
FIGURE: Fig. 40.10
MORFOLOGIA: D6A, gruppo III (?) Cfr. inv. 3097.
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (aprile 2024)212
- Italia: Aquileia (UD)213; Chiunsano (RO)214; Concordia Sagittaria (VE)215; Modena216; Roma217; fiume Saline (Abruzzo)218.
- Croazia: Museo di Nin219.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il gentilizio Ninnius, talora in associazione con il prenome Quintus, è ben attestato in ambito italico, in particolare nella parte settentrionale del Samnium, benché dall’epigrafia lapidaria non sia noto alcun Q. Ninnius Secundus220. Proprio dall’area di confine tra Sannio e Piceno antichi, nei pressi delle figlinae dei Rubrii (vd. supra, pp. 145-153), proviene la tegola bollata da questo personaggio, indizio di una probabile attività manifatturiera in loco221.
Il cognomen latino Secundus è attestato sia tra individui di nascita libera che in ambiente servile e libertino222.
La cronologia della produzione pare sia da ricondurre almeno alla metà del I sec. d.C., vista la compresenza delle forme anforiche Dressel 6A e fondo piatto tra i confronti individuati per questo bollo.
22) L.O.C223
L. O(—) C(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 582, US 484, anf. 9 (irreperibile): L.O.C
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio;
impasto 6.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 46.1
MORFOLOGIA: non riscontrabile sugli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
- Italia: Tortona224.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nella sigla si può scorgere l’abbreviazione di tria nomina, ridotti alle sole iniziali. Si segnala l’attestazione del bollo nella prima fase di discarica individuata presso il settore NE del Nuovo Mercato.
23) A.“PL”.A225
A. Pl(—) A(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 1388, US 359 (irreperibile): A“PL”A
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 46.2
MORFOLOGIA: non riscontrabile nel dettaglio dell’orlo sull’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio; si rileva un corpo con carena pronunciata e non particolarmente slanciato (Lamb. 2/Dressel 6A?), tuttavia già tendente al piriforme. Gli esemplari di confronto, quando ascrivibili a un tipo, sono classificati come Dressel 6A, verso cui fa propendere la tipologia del bollo.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
- Italia: Carlino (UD)226, Modena227, Padova228, Piacenza229, Parma230, Reggio Emilia231.
- Austria: Magdalensberg232.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nel bollo può scorgersi l’abbreviazione di una formula onomastica, costituita da tria nomina. In tal caso, nel nesso PL si debbono riconoscere le lettere iniziali del gentilizio233. Tra i diversi possibili scioglimenti, si segnalano Plotius234, che, frequentemente attestato nella Regio VII, si accompagna talvolta al prenome Aulus, e l’affine Plautius, anch’esso spesso associato ad Aulus, in specie nell’onomastica di personaggi di rango di epoca primo-imperiale235.
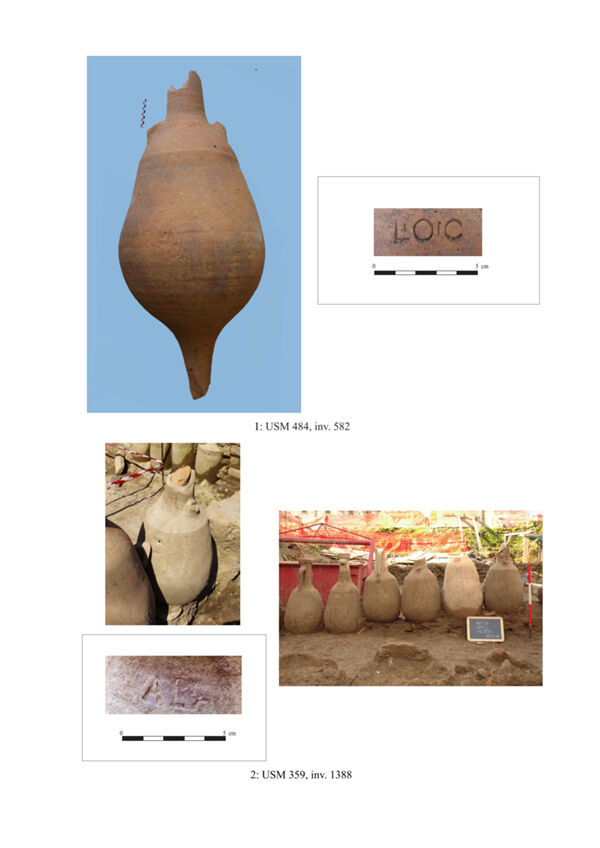
24) P.C.S*.D
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 1477, US 346: P.C.S*.D
posizione: collo;
caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare; segni d’interpunzione di varia foggia;
impasto 13.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 47.1
MORFOLOGIA: non riscontrabile sugli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
- Italia: Roma236.
NOTE
Al momento non è stato possibile formulare alcuna ipotesi di scioglimento per il bollo, contenente forse una formula onomastica con due gentilizi o due cognomi.
25) [A.R].N237
A. R(—) N(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 2618, US 369: [A.R].N
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio rettangolare; segni d’interpunzione quadrangolari;
impasto 4.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 47.2
MORFOLOGIA: non individuabile sulla base dei reperti del Nuovo Mercato Testaccio.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nella sigla si può scorgere, in via d’ipotesi, l’abbreviazione di tria nomina, ridotti alle sole iniziali.
26) A.Q.BE**242
A. Q(—) Be(—)?
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
Tutti i bolli attestati sono impressi in obliquo e talora al contrario sul collo del relativo contenitore e presentano lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare. Il cattivo stato di conservazione, imputabile in parte a un’impressione poco accurata in origine, non consente di valutare pienamente le caratteristiche e le differenze tra i punzoni, che paiono almeno 2 se non 3. Si deve notare che i reperti inv. 1425 e 2256 presentano un signum costituito da due punti disposti in verticale alla fine del testo. Tale signum non è visibile nell’esemplare inv. 2631, US 220, ma ipotizzabile sulla base dello spazio che avanza nel cartiglio. I tre reperti appaiono poi accomunati dalle caratteristiche macroscopiche dell’impasto, afferente in tutti e tre i casi al gruppo 5, differenziandosi in tal modo dalle due restanti attestazioni del bollo (sottolineate nell’elenco), aventi caratteristiche proprie.
I segni d’interpunzione appaiono infatti marcatamente triangolari negli esemplari inv. 4124 (la cui ultima lettera risulta molto compromessa, forse per una cattiva impressione, e viene restituita solo per parallelo con le altre attestazioni) e inv. 4408, US 3232, in cui peraltro parrebbe non attestato, forse per la qualità della punzonatura, il punto tra la A e la Q, mentre ne figura un altro dopo la B. La disposizione dei punti, se non dovuta a difetti di conservazione, differenzierebbe tra loro i due ultimi punzoni, obbligando alla definizione di 3 gruppi.
La presenza di un segno d’interpunzione dopo la B, nel reperto inv. 4408, può far dubitare dello scioglimento in una formula onomastica del tipo A. Q(—) Be(—), benché la E non sia attestata in questo reperto e di difficile lettura nel bollo affine inv. 4124, US 484; si può forse supporre uno sviluppo diverso (diversa integrazione o presenza di signa) per questi ultimi due bolli, pur afferenti alla medesima produzione degli altri (non vi sono dati tecnici, morfologici o epigrafici certi per uno stralcio).
- inv. 1425, US 523: A*Q*BE (signum?), impasto 5;
- inv. 2256, US 593: A.Q*B*E* (signum?), impasto 5;
- inv. 2631, US 220: AQBE**, impasto 5;
- inv. 4124, US 484: A.QB*E*, impasto 3;
- inv. 4408, US 3232: AQ.B.[E], impasto 4.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I – II fase discarica a S del muro in reticolato e relativa obliterazione; settore W, fase pre-horreum.
FIGURE: Fig. 47.3-7
MORFOLOGIA: non determinabile sulla base degli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Non sono stati al momento (ottobre 2021) individuati confronti.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nella sigla si può scorgere, in via d’ipotesi, l’abbreviazione di una formula onomastica, benché l’ipotesi di scioglimento sia gravata dai dubbi sulla lettura di alcuni esemplari.
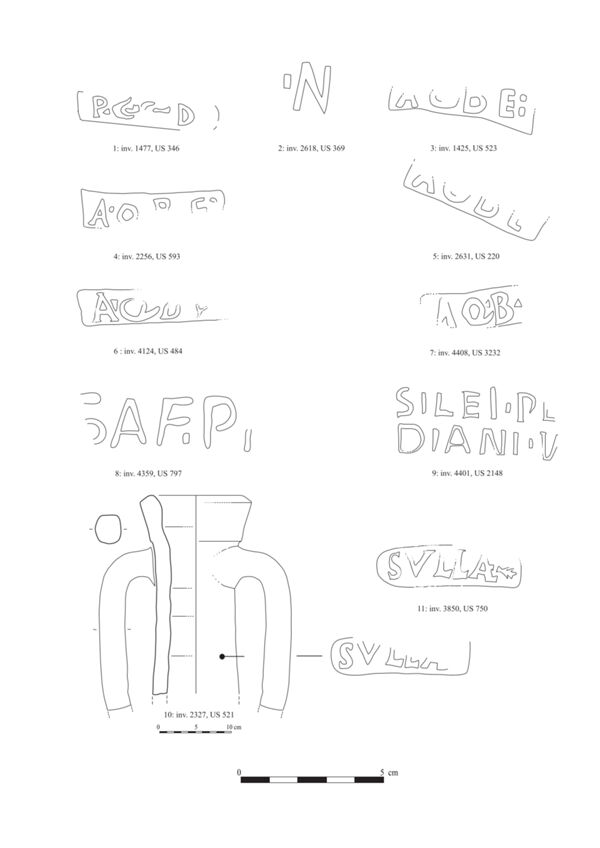
27) RVBRI
Rubri
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 3093, US 1851:RVBRI
posizione: ansa;
caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, livelli costruzione horreum medio imperiale.
FIGURE: Fig. 4; 36.13
MORFOLOGIA: non rilevabile nel caso del Nuovo Mercato
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (agosto 2021)243[242]
Italia
Modena
RVBRI // C“AD”MI. Posizione: anse. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: Mongardi 2013, pp. 462-464; Mongardi 2018, pp. 87-90; p. 176, n. 71; p. 194, n. 106.
Note: il bollo proviene da un contesto di età giulio-claudia; al Nuovo Mercato non sono state rinvenute testimonianze di bolli C”AD”MI al genitivo, mentre è attestato il nominativo C”AD”MVS.
Crotone (controllo autoptico in data 26 agosto 2021 presso Museo Archeologico Nazionale)244.
RVBRI // C“AD”MI. Posizione: anse. Caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare.
Bibliografia: https://www.progettomusas.eu/portfolio/anfora-dressel-6a/ (consultato in data 18.10.2023).
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Si rimanda alla discussione del bollo Barbarus (cfr. supra, pp. 145-153).
28) []CC.AVG*.II** / R*VBRIAE.PF.F. // “HD”
[ ] C. C(aesare) Aug(usto consule) II / Rubriae P(ublii) f(iliae) f(iglinae) // H(—) D(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 3097, US 722: a) []CC.AVG*.II**/R*VBRIAE.PF.F. // b) “HD”
posizione: collo e ansa;
caratteristiche: lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare, bollo destrorso (a) e quadrangolare (b).
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a S del muro in reticolato.
FIGURE: Figg. 4; 13; 36.2
MORFOLOGIA: gruppo III? Cfr. inv. 4416
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (ottobre 2021) non sono stati rilevati confronti per il marchio in esame245.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Per l’aspetto prosopografico si rimanda alla scheda relativa a P. Rubrio Barbaro (vd. supra, pp. 145-153), mentre in questa sede ci si concentra sulla prima riga del bollo che potrebbe contenere una datazione consolare (la prima parte è illeggibile e la seconda comunque mal conservata). Tale datazione, se corretta ne è l’interpretazione, si dovrebbe riferire al 39 d.C., anno del secondo consolato di C. Caesar, ovvero Caligola246; mancherebbe invece l’indicazione del collega nella carica247 o dovremmo immaginarla compendiata nella parte non conservata della riga, anteposta pertanto al nome dell’imperatore, fatto che crea qualche perplessità248. Nella prima parte della prima linea si integrerebbe più facilmente parte della titolatura di Caligola, quale l’abbreviazione imp(eratore); al momento vi si intravveddono, soprattutto in foto (Fig. 13), segni illeggibili. La manualistica indica che, nelle iscrizioni che nominano l’imperatore vivente, la datazione risulta dalla titolatura di questi249[.
Il reperto proviene da un allineamento di I fase del settore NE (USM 722), di cui rappresentava una zeppa; dal punto di vista cronologico la datazione consolare si inserirebbe molto coerentemente nel contesto: la prima fase della discarica, con l’impianto degli allineamenti, si data a partire almeno dall’età tiberiana, mentre gli scarichi sarebbero durati almeno sino a quella neroniana, quando il contesto avrebbe conosciuto una consistente ristrutturazione. Questo secondo impianto, con sempre nuovi scarichi e apporti di materiale, si sarebbe protratto sino ad epoca traianea, per poi essere obliterato in funzione di una nuova costruzione. In tale quadro il frammento anforario con supposto bollo consolare potrebbe essere tanto pertinente al primo allestimento, la cui cronologia dovrebbe pertanto scendere leggermente, quanto piuttosto ad un risarcimento di poco successivo dell’allineamento. Tali interventi dovevano avvenire nell’ambito della manutenzione dei recinti, funzionali a contenere scarichi molto consistenti, i quali portarono, nel giro di pochi anni, ad una necessaria e radicale risistemazione dell’area, con l’allestimento di nuovi allineamenti.
La cronologia del bollo, se corretta fosse l’interpretazione della prima riga, sarebbe peraltro coerente anche con quella della domina, il cui nome compare alla seconda riga (Rubria, figlia di Barbarus su cui cfr. supra, pp. 145-153).
Altra questione è il significato del bollo anforario. Doppi bolli con “marchio di fabbrica” , ovvero bollo usuale, da una parte e datazione consolare (riferibile in genere alla media età augustea) dall’altra sono stati precedentemente segnalati su anfore Dressel 6A250. La letteratura archeologica li considera indicazioni aggiuntive, apposte per interpretazione estensiva di una qualche norma o prassi consolidata riguardante i laterizi ad altri manufatti, quali anfore o dolia, per controllarne la produzione e/o il commercio oppure per certificarne qualità, metrologia o stagionatura251. L’ipotesi alternativa è che questi bolli fossero applicati al fine di segnalare un contenuto particolarmente pregiato, meritevole di invecchiamento, in contenitori appositamente commissionati alla figlina, già predisposti con la data dell’imbottigliamento252.
Da una parte il coinvolgimento di Rubria nella produzione laterizia253 potrebbe costituire un indizio a favore della prima tesi esposta; dall’altra preme sottolineare che il nostro caso si differenzierebbe dagli altri nella misura in cui la supposta datazione consolare non rappresenterebbe un’indicazione aggiuntiva, apposta per il tramite di un secondo bollo sul contenitore da trasporto, ma farebbe parte integrante del marchio, essendo peraltro trascritta alla prima riga in caratteri leggermente più grandi. Il bollo, se corretta ne fosse la lettura, conterrebbe pertanto una precisa indicazione cronologica, di cui ci sfugge il significato, seguita dall’onomastica della domina, Rubria254, la quale potrebbe forse rivendicare, attraverso la filiazione la propria caratura, nonché la tradizione che la famiglia d’origine vantava nell’attività produttiva di cui era erede255.
Le informazioni si moltiplicano, tenendo in conto che il contenitore del Nuovo Mercato ha un secondo bollo sull’ansa con la sigla HD, forse l’abbreviazione di una formula onomastica bimembre, riferibile, come nella tradizione dell’industria laterizia, ma del resto anche di una parte della produzione anforaria adriatica, all’officinator o al conductor della figlina: se l’ipotesi coglie nel segno bisogna evidenziare l’appartenenza di questa figura a una gens diversa dalla Rubria256.
29) SaF.PI*[C]257
Saf(inia) Pic(ens) o Pic(entina)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4359, US 797: SaF.PI*[C]
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave senza cartiglio; segno d’interpunzione rettangolare;
impasto 3.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica.
FIGURE: Fig. 47.8
MORFOLOGIA: non desumibile dall’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio
CONFRONTI E DIFFUSIONE
I confronti individuati ad oggi (aprile 2024) afferiscono a diversi punzoni, senza che ciò sia indizio di una diversa cronologia o dislocazione nella produzione delle anfore258.
- Italia: Altino (VE)259; Aquileia; Brescello (RE); Chiunsano (RO); Cusano Milanino (MI)260; Este (PD)261; Imola (BO); Modena262; Novara; Ostiglia (MN); Padova263; Parma264; Rimini265; Roma266; Suasa (AN)267; Vercelli; Verona; Vicenza; Villanova (BO)268, Zivido (San Giuliano Milanese, MI)269.
- Cipro: Nea Paphos270.
- Croazia: Cavtat.
- Tunisia: Cartagine271.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il bollo riporta l’onomastica di un personaggio femminile appartenente alla gens Safinia272. Tra le tre possibili integrazioni del cognomen, Picena, Picens, Picentina, di carattere etnico come il gentilizio273, sono da preferire le ultime duesulla scorta dell’esempare di Zivido. Con riguardo ai repertori onomastici274 e ai database disponibili on line275, il cognomen Picens, non consolidato in ambito servile e libertino, sembra essere documentato al momento solo per persone di sesso maschile, mentre Picentinus e Picentina ricorrono per ambo i generi e per individui di varia condizione giuridica. Si tratta ad ogni modo di cognomina non molto diffusi e radicati prevalentemente nella penisola italica. Picens figura nell’onomastica di un’altra gens, l’Herennia, coinvolta nella fabbricazione di contenitori da trasporto adriatici. È stato pertanto supposto un collegamento tra le due produzioni276, privo di basi certe, tanto più che la ricerca onomastica fa inclinare, con riguardo a Safinia, per il cognome Picentina.
Sembrano piuttosto interessanti le testimonianze relative a Safinii attivi a Samo277: uno di questi, cittadino romano, era ascritto alla tribù Velina, prevalente nella Regio V, consentendo di istituire un legame tra la gens e il Piceno, sinora postulato sulla base del solo aspetto onomastico. Un ramo dei Safinii è tuttavia attestato in epoca tardo-repubblicana nella Regio X, Venetia et Histria ad Aquileia, anch’essa appartenente alla tribù Velina278.
Ad ambito medio-adriatico paiono però rimandare da una parte l’esame macroscopico dell’impasto del reperto del Nuovo Mercato, dall’altra la geografia distributiva e le caratteristiche tecniche dei marchi279. Recenti indagini chimiche su materiali adriatici bollati sembrerebbero confortare l’ipotesi di provenienza picena per i contenitori con questo marchio280.
Sebbene la rarità del cognomen aumenti la probabilità che esso conservasse ancora in età augustea/primo-imperiale l’originiario significato, proprio ad Aquileia è attestato un L. Safinius Sabellio281, la cui onomastica denuncia una consuetudine all’uso di cognomi etnici riferiti ad area centro-italica che forse ha carattere familiare, ma potrebbe non essere probante dell’origine del portatore.
Sulla base dei contesti di attestazione il bollo parrebbe databile ad età augustea; al Nuovo Mercato Testaccio esso è rappresentato nei livelli più antichi di discarica individuati nel settore NE.
30) [T.]SILEI.PE*[TRV] / [-]DIANI.V[ARI]
T. Silei Petru(—) / [-] Diani V[ari]
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4401, US 2148: [T.]SILEI.PE*[TRV] / [-]DIANI.V[ARI]
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio rettangolare; segni d’interpunzione rettangolari;
impasto 6.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase ?
FIGURE: Fig. 47.9
MORFOLOGIA: non individuabile sulla base dei reperti del Nuovo Mercato Testaccio (spessore collo 2 cm).
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
- Italia: Atri (TE)282.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nel bollo si individuano degli elementi onomastici. Alla prima riga il gentilizio Sileius, raramente attestato283, precede un cognomen per il quale, seguendo il confronto con il reperto di Atri, sulla base del quale il testo del Nuovo Mercato è stato completato, si registrano scarse possibilità di integrazione284. Alla seconda riga si può forse vedere una formula onomastica, di cui si conserva il gentilizio – il rarissimo Dianius, attestato secondo i repertori onomastici285 solo ad Asculum Picenum dall’iscrizione funebre di un cittadino romano ascolano (ascritto alla tribù Fabia)286 – e il cognome Varus287.
31) SVLL“AE”
Sullae
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
I bolli ricorrono sul collo in lettere a leggero rilievo entro cartiglio rettangolare con angoli stondati:
- inv. 2327, US 521: SVLL“A[E”] (parte finale deteriorata; potrebbe essere lo stesso punzone del marchio seguente), impasto 6;
- inv. 3850, US 758: SVLL“AE” (il bollo presenta un signum – palma o fulmine – dopo la E), impasto 14.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I-II fase discarica a S del muro in reticolato.
FIGURE: Fig. 47.10-11
MORFOLOGIA: gruppo III?
CONFRONTI E DIFFUSIONE (ottobre 2021)
Non sono stati individuati confronti puntuali. Si segnalano tuttavia due anfore, dubitativamente attribuibili al tipo Lamboglia 2, a marchio P.S“VL”A** e P.SVLLA, rinvenute rispettivamente a Taranto, località Montedoro, e in Sicilia sul Monte Erice288. Una Dressel 1 bollata C*P.SVLLA è attestata ad Alessandria d’Egitto289, mentre una Dressel 2-4 a marchio P.S“VL”LA è testimoniata ad Atene290.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
In epoca augustea e primo-imperiale il cognomen Sulla era appannaggio, tra gli individui di rango, della gens Cornelia, cui appartenne il celebre dittatore d’epoca repubblicana, L. Cornelius Sulla Felix291. Occorre pertanto sottolineare pregnanza e carattere identificativo del cognomen, portato in particolare dai discendenti del dittatore, i quali peraltro si erano legati, tramite il matrimonio del figlio di questi con la sorella di Gn. Pompeo Magno292, a una famiglia che godeva di ampio seguito e cospicue clientele in ambito piceno293.
Tarula, liberto del dittatore, risulta inoltre coinvolto nella produzione anforaria di ovoidali brindisine e forse Lamboglia 2294, a testimonianza di interessi radicati nella Calabria romana295. Si menziona nuovamente infine l’ipotetica produzione di Lamboglia 2 su cui figura il cognome Sulla, preceduto probabilmente dal prenome P(ublius). Si registra in effetti l’esistenza di almeno due P. (Cornelii) Sullae, rispettivamente nonno e padre del Lucius console del 5 a.C.296, il primo consul designatus nel 66 a.C., il secondo ricordato nelle lettere di Cicerone (Cic., ad Quintum fratrem III, 3,2) nel 54 a.C.; al primo di questi D. Manacorda attribuisce le anfore bollate in questione297. Si evidenzia tuttavia che il cognomen conobbe anche un uso occasionale in ambiente servile e libertino, al di fuori della gens Cornelia298.
32) l.TARI e L.TARI“RVF”I299
L. Tari Rufi
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
I bolli ricorrono sull’orlo in lettere a leggero rilievo entro cartiglio rettangolare:
- inv. 2251, US 545: L.TARI, impasto 2;
- inv. 2270, US 523: L[.T]ARI“R[VF”]I, impasto 2;
- inv. 2282, US 310: L.TARI*[“RVF”]I*, impasto 4;
- inv. 2290, US 523: L.TARI, impasto 1.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato.
FIGURE: Fig. 48.1-4
MORFOLOGIA:
- gruppo III (invv. 2251, 2270, 2290);
- gruppo IV (inv. 2282).
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
I confronti individuati (ottobre 2021) sono costituiti da bolli derivati da diversi punzoni300 e afferenti sia a contenitori Dressel 6A che Lamboglia 2301.
- Italia: Altino (VE)302; Ancona303; Aquileia (UD)304; Carlino (UD)305; Chiunsano (RO)306; Cremona307; Este (PD)308; Fermo309; Ivrea310; Milano311; Modena312; Novara313; Padova314; Pavia315; Pegognaga (MN), loc. San Lorenzo316; Tortoreto (TE)317.
- Albania: Lezhë318.
- Austria: Magdalensberg319.
- Croazia: Pola?320; Raski Kanal321; Sisak322.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il personaggio la cui onomastica ricorre nei bolli è stato identificato323 con L. Tarius Rufus324, ammiraglio (praefectus classis) di Augusto ad Azio e console suffetto nel 16 a.C.; sostenitore del princeps, grazie alla liberalità di questi poté largamente investire, sino alla dissipazione della propria fortuna, nell’acquisto e nella coltivazione di vaste proprietà nel Piceno325. Coerentemente con le informazioni disponibili dalle fonti, al Piceno rimandano l’esame macroscopico degli impasti e le indagini petrografiche condotte su un reperto (inv. 2290) appartenente alla serie bollata da questo personaggio. Recenti analisi chimiche su materiali adriatici rafforzano ulteriormente l’ipotesi di provenienza medio-adriatica per i contenitori attribuibili a L. Tarius Rufus326.
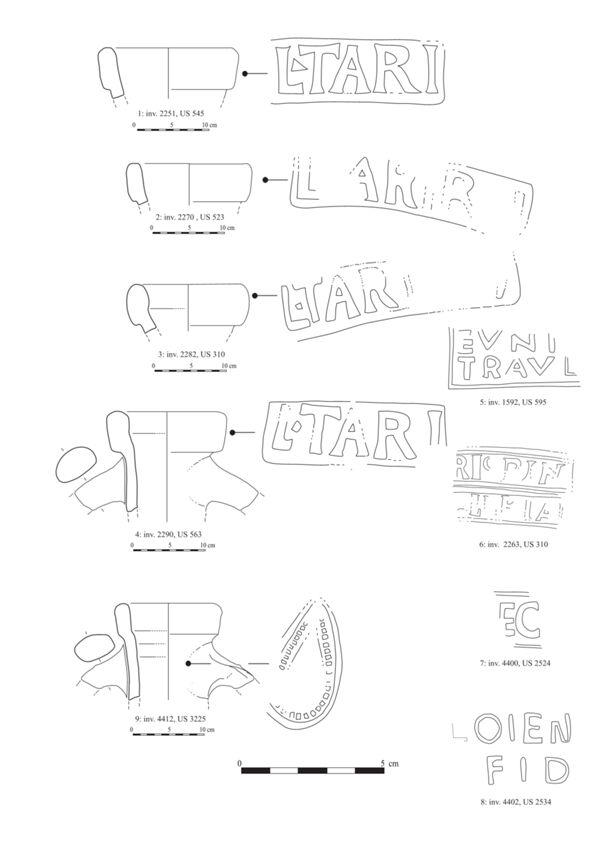
33) EVNI / TRAVL[I]
Euni Trauli
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 1592, US 595: EVNI / TRAVL[I]
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave entro doppio cartiglio rettangolare;
impasto 4.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase N
FIGURE: Fig. 48.5
MORFOLOGIA: non riscontrabile sugli esemplari del Nuovo Mercato Testaccio
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
- Italia: Roma327.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il bollo presenta due elementi onomastici, dapprima il cognomen Eunus, grecanico con connotazione servile328, al genitivo, e poi il raro gentilizio Traulus329, anch’esso probabilmente al genitivo, se si integra secondo l’esempio fornito dalle altre attestazioni urbane. Potrebbe quindi trattarsi della formula onomastica di un’unica persona, di condizione libertina, con posposizione del cognomen al gentilizio, fenomeno presente nell’epigrafia anforaria adriatica330 oppure di due personaggi, menzionati rispettivamente attraverso il cognomen / nome singolo e attraverso il solo nomen, evidentemente con carattere fortemente individuante, secondo lo schema (opus?) servi domini.
Va ricordato che nel territorio tergestino si concentrano le attestazioni di bolli su tegola TRAVL ET CRIS, originariamente attribuiti a Calvia Crispinilla e al presunto marito, il cavaliere Sex. Traulus Montanus331, giustiziato nel 48 d.C.; l’ipotesi è da abbandonare sulla base di considerazioni epigrafiche e onomastiche332. Il medesimo marchio si ritrova su Dressel 6B ed è databile tra la metà e il terzo quarto del I sec. d.C.333.
34) VOLC334
Volc(—)
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 1256, US 386, anfora 7: VOLC
posizione: spalla;
caratteristiche: lettere cave prive di cartiglio; è presente anche un graffito inciso dopo la cottura;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 49
MORFOLOGIA: simile a gruppo III, indistinto (cfr. per la morfologia anche invv. 1253-1254).
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
- Italia: Modena335.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nel bollo si riconosce l’abbreviazione di un elemento onomastico, probabilmente un gentilicium, quale ad esempio Volcacius, attestato epigraficamente nella regio V Picenum336; le analisi archeometriche suggeriscono in effetti una provenienza da tale area.
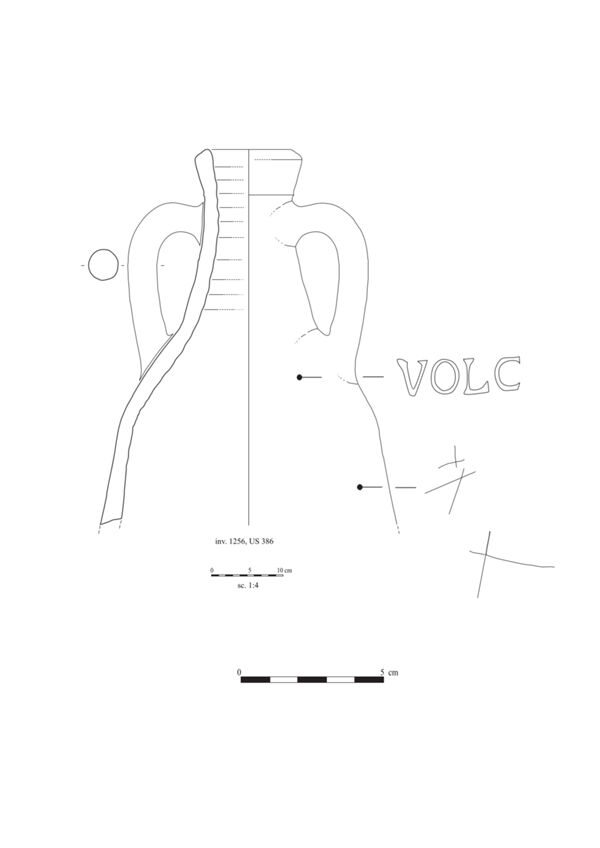
35) ]EC
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4400, US 2524: ]EC
posizione: collo;
caratteristiche: lettere cave entro doppio cartiglio;
impasto 2.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum.
FIGURE: Fig. 48.7
MORFOLOGIA: non desumibile dall’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio (spessore del collo 2,1 cm).
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (ottobre 2021) non sono stati individuati confronti.
36) BollI anepigrafI
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4412, US 3215
posizione: collo;
caratteristiche: cavo, in forma di goccia;
impasto 4.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum
FIGURE: Fig. 48.9
MORFOLOGIA: gruppo II
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Il bollo potrebbe appartenere alla categoria dei marchi, ben attestati su materiale laterizio, realizzati prevalentemente, ma non esclusivamente, a partire da oggetti metallici di vario tipo, come fibbie, chiodi, applique, borchie, pendagli, etc.337. Il punzone utilizzato per il bollo potrebbe pertanto appartenere alla sfera degli oggetti di uso personale o privato.
Non si individuano confronti palmari nell’ambito del materiale laterizio, né tra i bolli anepigrafi ad oggi reperiti su contenitori da trasporto di produzione adriatica, nello stesso scavo del Nuovo Mercato Testaccio338 o in altri contesti339.
Bolli su Dressel 2-4
1) B“AR”B“VL” // C.I“VL”.POLY340
Barbul(a) o Barbula(ae) // C. Iul(ius?) Poly(—)
ATTESTAZIONI NMT
Tutte le attestazioni di questo bollo si registrano su collo e sono in lettere cave senza cartiglio. Per la discussione dei punzoni si rimanda alle pp. 153-159 del presente lavoro. In questa scheda ci si limita a notare che il reperto sporadico inv. 3226 non presenta la prima B, benché collo e orlo siano integri, mentre il marchio inv. 2634 presenta tracce del punzone impiegato per la bollatura.
- inv. 2276, US 437: B*“AR”B“V[L”];
- inv. 2634, US 241: C.I*“VL”.POLY;
- inv. 3100, US 4126 (rubata)341: [C.I] “V*[L”].POLY;
- inv. 3226, sporadica342: [B]“A*R”B“VL” // C.I“VL”.POLY*
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro in reticolato e II fase Nord.
FIGURE: Fig. 50 (cfr. anche figg. 37-39)
MORFOLOGIA: NMT_AAD Orlo 21 (invv. 2276, 3226).
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (settembre 2021)343
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Si rimanda alle pp. 153-159 del presente lavoro.

2) TPALFVRI.SVRAE
T. Palfuri Surae
ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4417, US 3225:TPALFVRI.SVRAE
posizione: spalla;
caratteristiche bollo in lettere cave senza cartiglio, segno d’interpunzione quadrangolare, tracce del punzone utilizzato per eseguire il bollo;
impasto 13?
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum.
FIGURE: Fig. 51.1
MORFOLOGIA: Non si conservano parti morfologiche, l’attribuzione al tipo Dressel 2-4 si basa esclusivamente sui confronti ad oggi individuati; si precisa che lo spessore della parete su cui il bollo figura è di 2,1 cm.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2023):
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Sono noti due Palfurii di rango senatorio349: P. (?) Palfurius, console suffetto del 55 d.C.350 e un Palfurius Sura di cui non si conosce il prenome, espulso dal Senato da Vespasiano per le sue stravaganze, in seguito noto per l’attività di intellettuale e delatore sotto il regno di Domiziano ed infine assassinato per ordine di Nerva351. La cronologia di quest’ultimo personaggio è in linea con i rinvenimenti ostiensi e albanesi.
Il cognome latino non pare avere connotazione servile352, confermando ulteriormente la probabile identificazione con un personaggio di rango senatorio.
Sulla base delle attestazioni, e in particolare dei bolli laterizi e anforari di Trieste, sembra possibile riferire l’attività produttiva dei Palfurii, gens attestata anche nell’ager di Amiternum e nella penisola iberica353, all’arco adriatico settentrionale (nord-orientale) e forse al territorio tergestino.
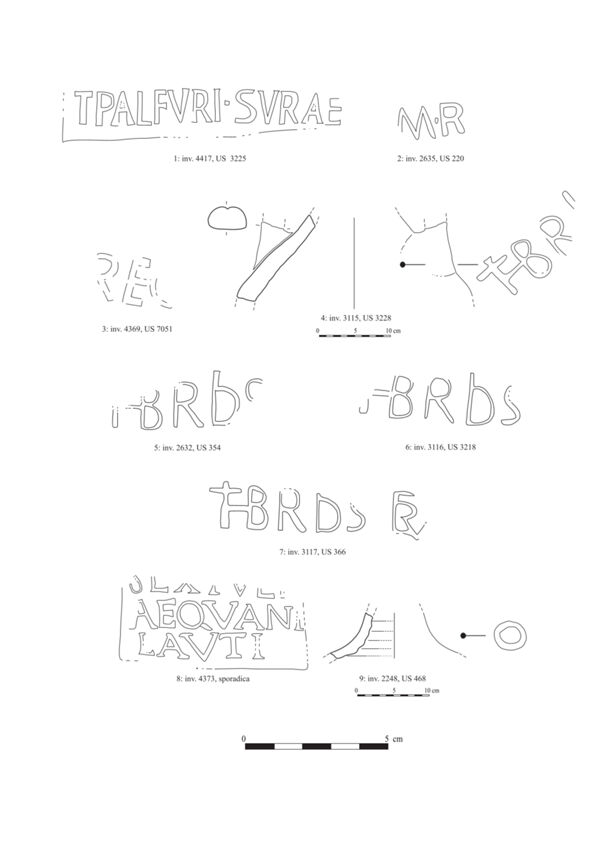
3) M.R354
M. R(—)?
ATTESTAZIONI NMT
- inv. 2635, US 220: M.R
posizione: spalla;
caratteristiche bollo in lettere cave senza cartiglio, segno d’interpunzione rettangolare;
impasto 30?
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, obliterazione discarica a S del muro in reticolato.
FIGURE: Fig. 51.2
MORFOLOGIA: Non si conservano parti morfologiche, si rileva però la presenza di una risega alla base del collo, tratto proprio dei contenitori Dressel 2-4.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (ottobre 2021) non sono stati rilevati confronti.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nel bollo può scorgersi in via d’ipotesi l’abbreviazione di una formula onomastica bimembre.
4) REGVLI355
Reguli
ATTESTAZIONI NMT
Le attestazioni di questo bollo si registrano sul collo e sono in lettere cave senza cartiglio:
- inv. 1517, US non indicata (irreperibile 2015): REGVLI (due bolli di cui uno mal impresso), impasto 2;
- inv. 4369, US 7051: REG*[VLI], impasto 19.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro.
FIGURE: Fig. 51.3
MORFOLOGIA: NMT_AAD Orlo 21 (l’attribuzione del reperto inv. 4361 al tipo riposa sul confronto con il contenitore Dressel 2-4 inv. 1517, irreperibile, poiché si tratta di un frammento di collo che non conserva parti tipologiche).
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
- Francia: golfo di Fos356.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il cognome latino Regulus, raramente attestato in ambito servile,risulta appannaggio della gens Atilia sino alla guerra annibalica e poi dei Livineii in epoca tardo-repubblicana357, mentre in età imperiale il panorama onomastico si arricchisce e si diversifica358, senza che si possa tuttavia identificare il personaggio dei bolli359.
5) “THIB”R“IDI”S ER[360
Thibridis Er(—)
ATTESTAZIONI NMT
Le attestazioni di questo bollo sono in lettere cave senza cartiglio:
- inv. 2632, US 354: “T*HIB”R“IDI”S*[ (spalla), impasto 19;
- inv. 3115, US 3228: “THIB”R“I[D]I”[ (spalla), impasto 19;
- inv. 3116, US 3218: “T*HIB”R“IDI”S[ (collo), impasto 19;
- inv. 3117, US 366: “THIB”R“IDI”S“ER”[ (collo), impasto 19.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica a S del muro; settore W, fase pre-horreum.
FIGURE: Fig. 51.4-7
MORFOLOGIA: solo il frammento inv. 3115, conserva l’attacco di un’ansa a doppio bastoncello tipica del contenitore Dressel 2-4; i reperti sembrano tuttavia omogenei per impasto e spessore delle pareti.
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (ottobre 2021) non sono stati individuati confronti.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il bollo è stato dapprincipio considerato una variante del più noto marchio THB361 sul modello dei contenitori bollati L.C.S.RPHI e L.C.S.REV362 (trascrizione: “THB”R“DI”S“ER”[ ).
In considerazione di alcuni aspetti paleografici363, della netta distinzione tipologica dalle anfore bollate THB364 e dei risultati delle analisi petrografiche, che associano due reperti con questo bollo all’area produttiva di Marina di Città Sant’Angelo, si intende stralciare il marchio dalla serie più nota e proporre un’ipotesi alternativa di lettura: “THIB”R“IDI”S ER[ . Si potrebbe dunque vedere nella prima parte del marchio il genitivo di un cognomen servile, Thybris o Thibris365.
Bolli su anfore a fondo piatto
1) SEXIVLI** / AEQVANI / LAVTI
Sex. Iuli Aequani Lauti vel Sex. Iuliorum Aequani Lauti
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4373, sporadico: SEXIVLI** / AEQVANI / LAVTIposizione: collo;
caratteristiche: lettere cave entro cartiglio rettangolare;
impasto 29.
FASI DI ATTESTAZIONE: frammento sporadico.
FIGURE: Fig. 51.8
MORFOLOGIA: non desumibile dall’esemplare del Nuovo Mercato Testaccio; l’attribuzione al tipo a fondo piatto piuttosto che a Dressel 6A, essendo il bollo attestato su entrambi i contenitori, è dovuta all’aspetto e allo spessore (1,1 cm) del frammento conservato.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2023)
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il bollo è stato attribuito ad una coppia di fratelli, Sex. Iulius Aequanius e Sex. Iulius Lautus371, la cui onomastica sarebbe tuttavia associata in maniera inedita372. Nei repertori onomastici Aequanius figura come gentilizio373, mentre nel bollo comparirebbe in funzione cognominale, uso testimoniato anche in CIL XIV, 1080. L’altro cognomen presente nel marchio è il raro Lautus, che non risulta ad oggi attestato in ambiente servile e libertino374.
È forse preferibile considerare il bollo come riferibile ad un’unica formula onomastica375 (con due nomina, uno dei quali acquisito per via materna o meno probabilmente per adozione, o due cognomina), le cui caratteristiche fanno propendere per l’identificazione del personaggio in questione con un ingenuo, forse un dominus.
Si segnala che diversi esponenti della gens Iulia, tra cui un Sex. Iul(—) Orp(—), probabilmente Sex. Iul(ius) Orp(haeus), e un Sex. Iulius Severus, bollano anfore di produzione adriatica376.
La fabbricazione dei contenitori bollati SEXIVLI / AEQVANI / LAVTI, la cui cronologia pare da ricondurre almeno alla metà del I sec. d.C., vista la compresenza delle due forme anforiche Dressel 6A e a fondo piatto, è attribuita al territorio di Atri (Colle Maralto e Capo d’Atri)377.
2) Bollo anepigrafe o segno alfabetico
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 2248, US 468
posizione: collo;
caratteristiche: cerchio impresso a crudo privo di cartiglio (diam. 1,2 cm);
impasto 29?
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, edificio medio-imperiale.
FIGURE: Fig. 51.9
MORFOLOGIA: l’attribuzione ad anfora adriatica è dovuta all’impasto, mentre quella ad un contenitore a fondo piatto dipende dalle caratteristiche e dallo spessore del frammento conservato (parete 1,2 cm).
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (ottobre 2021) non sono stati individuati confronti puntuali, se si eccettua un segno di forma e dimensioni similari impresso su anfora Dressel 6B di produzione imprecisabile rinvenuta a Vicenza378.
Bolli su brindisine / oviodali adriatiche
1) [L]“AL”B“ID”“AM[AE”]379
L. Albi Damae
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 4403, US 6012: [L]“AL”B“ID”“AM[AE”]
posizione: orlo;
caratteristiche: lettere in leggero rilievo;
impasto 38.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a N del muro in reticolato
Figure: Fig. 52.1
MORFOLOGIA: NMT AAD_Orlo 26 = Apani III = Giancola 6
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Nell’atelier brindisino di La Rosa sono stati recuperati materiali anforari di forma Apani III con bollo ALBIANA e L.“AL”B“ID”“AMAE”383. Il primo marchio aiuta nello scioglimento del secondo in L. Albi Damae, formula onomastica con nesso in forma di H tra la desinenza del gentilizio e l’iniziale del cognome. Si può dunque affermare che, come riscontrato anche a proposito dei bolli brindisini ANINIANA e VEHILIANA, la denominazione di un’officina o di una produzione anforaria potesse derivare dal nome del proprietario, in questo caso un Albius, gentilizio ben attestato in ambiente italico e isolatamente anche a Brindisi. Il cognome grecanico Dama riporta ad ambiente servile e consente di riconoscere nel personaggio che bolla le anfore un individuo di estrazione libertina384.
Bolli riferibili all’officina Albiana sono attestati, oltre che a La Rosa anche in Egitto385 e forse in Francia a Toulouse, con datazione al primo quarto del I sec. a.C.386
Si segnala che il marchio del Nuovo Mercato figura sull’orlo; il fenomeno, non frequente nell’epigrafia anforaria brindisina, trova tuttavia riscontro proprio in un reperto da La Rosa387.
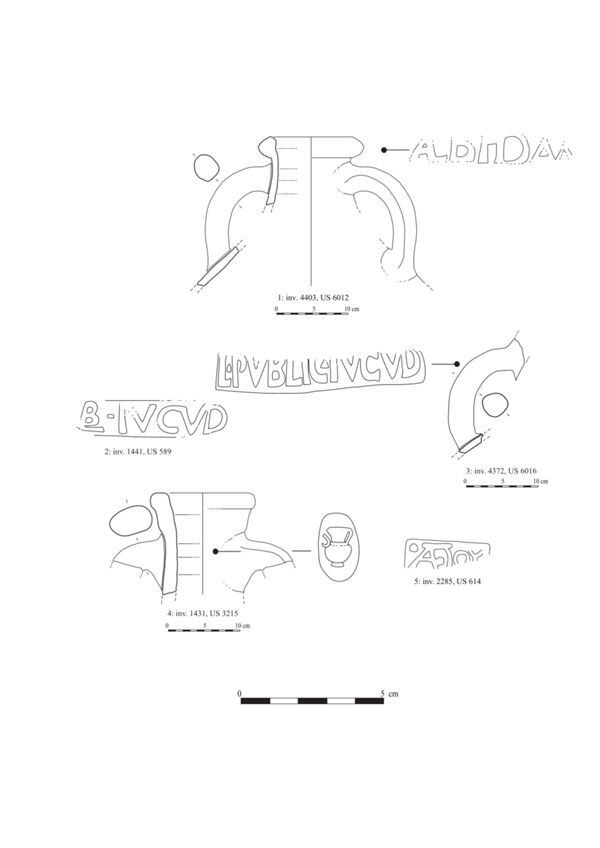
2) L.PVBLIC.IVC“VND”, “L*[PV]B”.IVC“VND”388
L. Publici Iucundi
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
I bolli, derivati da punzoni diversi, figurano in lettere a rilievo entro cartiglio sulle anse dei contenitori:
- inv. 1441, US 589: “L*[PV]B”.IVC“VND”, impasto 38;
- inv. 4372, US 6016: L.PVBLIC.IVC“VND”, impasto 38.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a S del muro in reticolato e II fase a N del medesimo muro
FIGURE: Fig. 52.2-3
MORFOLOGIA: Apani III = Giancola 6?
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il gentilizio Publicius è ben rappresentato nella regio II e in particolare nel Salento; in area brindisina il nomen, anche in associazione al prenomen Lucius, caso raro nell’intera regione,è documentato da più iscrizioni391. In riferimento all’instrumentum, è noto un bollo L.PVBLICI su un’ansa di anfora brindisina da Apani392, dove è tuttavia meglio documentata l’attività di un L. Publilius393; a Giancola inoltre sono attestati da bolli doliari un L. Publicius Felix e un L. Publicius Eros394. Con riguardo all’epigrafia lapidaria, invece, si segnala una dedica funeraria395, presumibilmente di età tardo-repubblicana o augustea, per un L. Publicius liberto del municipium brindisino, purtroppo frammentaria.
Il cognomen latino Iucundus è ben documentato, anche in ambito servile e libertino396.
Pur in assenza di testimonianze esplicite in tal senso, pare dunque plausibile una produzione brindisina dei contenitori bollati da L. Publicius Iucundus397, con la quale è coerente l’aspetto macroscopico dell’impasto. Un indizio di cronologia sembrerebbe venire per l’esemplare di Oppeano dalla paleografia, in particolare dalla P aperta e squadrata, che suggerisce una datazione di pieno I secolo a.C. La medesima lettera presenta nel reperto del Nuovo Mercato un occhiello maggiormente chiuso, sebbene non del tutto.
3) Bollo anepigrafe
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 1431, US 3215
posizione: collo; caratteristiche: anforetta o brocca a rilievo entro cartiglio ovale;
impasto 11.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore W, fase pre-horreum.
FIGURE: Fig. 52.4
MORFOLOGIA: NMT AAD_Orlo 23?398.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Bolli anepigrafi su contenitori da trasporto di produzione adriatica sono attestati, seppure non frequentissimamente. Al Nuovo Mercato Testaccio sono presenti su una Dressel 6A e su un probabile contenitore a fondo piatto (rispettivamente inv. 4412 = supra, p. 210) e inv. 2248 = supra, p. 219).
In particolare si portano qui a confronto i rinvenimenti di bolli anepigrafi rappresentanti anfore su anse a sezione circolare, non attribuite tipologicamente, a Marmorelle (BR)399 e su Dressel 6A a Oderzo (TV)400.
Tali bolli, benché di significato oscuro, paiono non avere un mero carattere decorativo, rientrando in una tradizione mutuata dall’ambiente greco, ove sono meglio attestati in particolare sulle anfore corinzie B401.
4) “ATEI”OY (da escludere)402
Ateioy
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 2285, US 614: “ATEI”OY**
posizione: ansa;
caratteristiche: lettere in rilievo, caratteri greci.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a S del muro in reticolato
FIGURE: Fig. 52.5
MORFOLOGIA: attribuzione ipotetica ad anfora ovoidale brindisina
ANALISI ARCHEOMETRICHE: infra, pp. 237-250.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (ottobre 2021)
- Italia: Oderzo (TV)403.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il frammento, ascritto in un primo momento alle produzioni adriatiche – in via d’ipotesi brindisine – sulla base di una valutazione morfologica ed epigrafica (bollo su ansa a sezione circolare con gentilizio latino in lettere greche, compreso entro cartiglio rettangolare)404, deve esserne escluso per le caratteristiche sia macroscopiche che petrografiche dell’impasto.
Può forse invece essere attribuito ad area orientale, come ipotizzato in letteratura per il reperto opitergino portato a confronto, indiziato, tra l’altro, dall’uso dell’alfabeto greco e confermato dalla petrografia.
Bolli su Dressel 6B
1) [L.CORN]E“AM”ICI405
L. Corne(lii) Amici
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
Il bollo è attestato in due esemplari (forse due punzoni?), in lettere a rilievo entro cartiglio rettangolare sull’orlo del contenitore:
- inv. 1439, US 562: [L.CORN]E“AM”ICI, impasto 36;
- inv. 4371, US 962406: [L.CORNE]“AM”ICI, impasto 36;
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, I fase discarica a N e a S del muro in reticolato.
FIGURE: Fig. 53.1-2
MORFOLOGIA: NMT AAD_Orlo 18407.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
I confronti ad oggi individuati (ottobre 2021) riguardano sia contenitori Dressel 6A che Dressel 6B e presentano lievi varianti nel punzone408:
- Italia: Altino (VE); Brescello (RE); Padova.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il bollo potrebbe essere in relazione con il marchio LCORHER stampigliato su Dressel 6A (Altino, Pisa, Cesena, Urbs Salvia; Magdalensberg) e su Dressel 6B (Bologna, Milano, Verona). È inoltre nota un’attestazione del medesimo bollo su anfora di tipologia imprecisata da Tortona (AL)409. Una delle tre testimonianze da Verona proviene da un contesto databile tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del secolo successivo, coerentemente con l’attestazione patavina del bollo L.COR“NE”“AM”ICI su Dressel 6A in un drenaggio databile tra l’ultimo venticinquennio del I sec. a.C. e il primo trentennio del I d.C.410
I marchi sono stati ricondotti a due liberti della gens Cornelia, Amicus411 ed Her(mes?)412, che bollano sia anfore olearie che vinarie. I Cornelii rappresentano una gens di origine centro-italica, ben attestata in Cisalpina, dove il gentilizio è associato anche al praenomen Lucius, e ben documentata in Istria, a Trieste e ad Aquileia. Nell’agro di quest’ultima città è forse da localizzare inoltre una produzione di tegole attribuibile alla famiglia: la manifattura anforaria pertanto è stata stata collocata ipoteticamente nell’area compresa tra Aquileia e l’Istria.
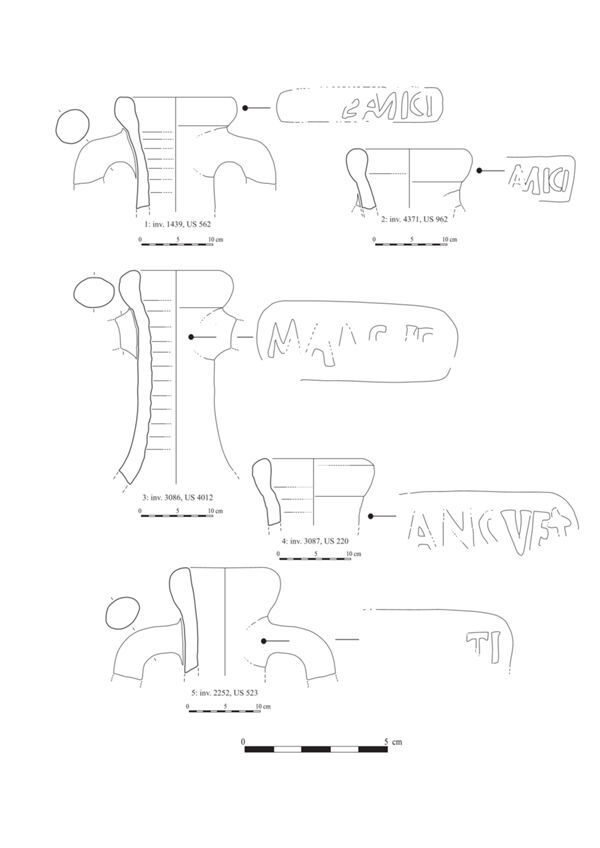
2) MANSVE“TI”413
Mansueti
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
Il bollo è attestato in due esemplari sul collo in lettere a leggero rilievo entro cartiglio con angoli stondati:
- inv. 3086, US 4012: MAN*S*V*E[“TI”], impasto 22;
- inv. 3087, US 220: [M]ANSVE“TI”, impasto 22.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, obliterazione discarica a S del muro in reticolato.
FIGURE: Fig. 53.3-4
MORFOLOGIA: NMT AAD_Orlo 18.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Confronti individuati (novembre 2021):
- Italia: Altino (VE)414.
NOTE ONOMASTICHE E PROSOPOGRAFICHE
Il cognomen latino Mansuetus, di ampia attestazione, è testimoniato sia tra ingenui che in ambito servile e libertino, sebbene preferibilmente tra i primi415.
Non sono stati individuati indizi per un’identificazione del personaggio416.
3) ]TI
]ti
ELENCO ATTESTAZIONI NMT
- inv. 2252, US 523: ]TI;
posizione: orlo;
caratteristiche: lettere al leggero rilievo entro cartiglio rettangolare con angoli stondati;
impasto 24.
FASI DI ATTESTAZIONE: settore NE, II fase discarica discarica a S del muro in reticolato.
FIGURE: Fig. 53.5
MORFOLOGIA: NMT AAD_Orlo 18.
CONFRONTI E DIFFUSIONE
Ad oggi (novembre 2021) il completamento del bollo e la conseguente individuazione dei confronti sono incerti.
Notes
- Tale scelta è stata effettuata al fine di ampliare le possibilità di confronto tra epigrafia e morfologia dei contenitori da trasporto e accrescere i dati sulle serie bollate. I reperti provenienti dal settore NE sono tuttavia facilmente distinguibili in quanto hanno un numero di US compreso entro il 999 o superiore al 6000.
- http://ceipac.ub.edu/
- Manacorda 2012c, pp. 293-295.
- Si precisa che il corredo epigrafico delle anfore, strettamente legato alle tradizioni dei singoli ambienti produttivi, varia di significato a seconda degli ambiti geografici e artigianali in cui la pratica della bollatura venne adottata. Come rappresentato da C. Panella (Panella 2010, p. 35, nt. 2), nelle anfore prodotte nella penisola italica, il bollo contiene solitamente uno o più nomi, eventualmente legati da vincoli di societas o di dipendenza, e pare direttamente collegato al processo di fabbricazione dei contenitori, talvolta integrato nel contesto di un’azienda agricola, come nel caso di Giancola nel brindisino. L’ipotesi che la bollatura potesse fornire garanzie di carattere qualitativo, fiscale e commerciale al destinatario della merce trasportata parrebbe invece compromessa dalla constatazione della mancanza di sistematicità nella pratica della bollatura.
- Per i cognomina latini in Er-, tutti rari, Kajanto 1982, Indices, p. 390; per quelli greci Solin 2003, Indices, pp. 1658-1659 (tra i più attestati Eros, su cui Solin 2003, pp. 352-361).
- Si segnala che l’ultima lettera, leggibile con difficoltà, potrebbe essere anche una Y.
- Buora et al. 2008, p. 12. Da rilevare, oltre alla difformità dei due bolli, è la differenza morfologica tra l’orlo rinvenuto a Roma e quello aquileiese (nel primo caso si conserva solo il frammento su cui il marchio figura; nel secondo il contenitore intero), mentre similare è la sezione dell’ansa.
- Per le integrazioni come gentilizio Schulze 1991, Indices, p. 599; fra le possibilità figura in particolare Antonius (Schulze 1991, p. 124).
- Per le possibili integrazioni come cognomen latino Kajanto 1982, Indices, pp. 380-381; per i grecanici Solin 2003, Indices, pp. 1631-1633, tra cui sono ben rappresentati Anteros (Solin 2003, pp. 18-21) e Antiochus (Solin 2003, pp. 209-214). Quest’ultimo cognomen è testimoniato nell’epigrafia anforaria adriatica su Lamboglia 2, Lamboglia 2/Dressel 6A e ovoidi ed è probabilmente da collegare a più officinatores (a titolo d’esempio Nonnis 2012, pp. 92-93). Cfr. per altre possibili integrazioni, sulla base di attestazioni note di bolli adriatici, Starac 2020, pp. 46-48.
- CEIPAC 39864-39867.
- Staffa 2003, pp. 125-126, fig. 7,1-2.
- Mongardi 2013, pp. 462-464; vd. sotto.
- Per la diffusione si confrontino anche i paragrafi riservati ai marchi CADMVS e RVBRI (cfr. infra, pp. 162-163, 196), mentre il bollo []CC.AVG*.II**/R*VBRIAE.PF.F. // “HD” (vd. infra, pp. 197-199), legato – come si vedrà – a quello in esame, rappresenta allo stato delle nostre conoscenze un unicum.
- Nel sito, oltre ad alcuni marchi relativi a servi di un (Publicio) Malleolo, sono stati recuperati i seguenti bolli su anse di Dressel 6A relativi alla produzione di Barbarus: C*“AD”MVS (l’associazione può essere fatta sulla base di NMT_inv. 1213) e PRIMIBAR (2 esemplari) da sciogliersi probabilmente in Primi Bar(bari scil. servi).
- Patterson 1982, p. 153; Zaccaria 1989, p. 475.
- Sul personaggio Cerrone 2013, pp. 100 nr. 2 e 148-150 (gentile concessione dell’Autrice); PIR2, R, 125; Ricci 2006, pp. 113-114.
- Fonti epigrafiche su P. Rubrius Barbarus: CIL X, 5169 (dedica da Casinum, odierna Cassino, FR); CIL III, 6588 = IGR I, 1072 (obelisco da Alessandria d’Egitto); IGR I, 1294 (epistilio del tempio di Augusto, da Philae); CIL XIV, 3833 (titulus di carattere incerto da Tivoli).
- Mongardi 2013, p. 463, nt. 12, con bibliografia precedente.
- Kroll 1928, c. 230.
- Per il radicamento dei Rubrii nel Lazio vd. tuttavia Wiseman 1971, pp. 256-257.
- Staffa 2003, pp. 119-129; Staffa 2008, pp, 143-148. Ancorché sia altamente probabile, non è certo che le fornaci ricadessero nell’ager dell’antica Hadria; pare comunque plausibile che esse fossero a servizio di quel territorio, insieme al vicino approdo Ad salinas.
- D’Alessandro 2013, p. 358-359. Cadmus è un grecanico di connotazione servile (Solin 1996, p. 336; Solin 2003, pp. 536-537).
- Modena: Mongardi 2013, pp. 462-463; Mongardi 2018, pp. 87-90. Crotone: https://www.progettomusas.eu/portfolio/anfora-dressel-6a/ (consultato in data 18.10.2023).
- Scardozzi 2015, pp. 217-218 (con esplicito riferimento a P. Rubrius Barbarus); Braito 2020, pp. 254-256. Sui laterizi vd. oltre.
- PIR2, R, 129.
- CIL VI, 9245.
- CIL III, 6588 = IGR I, 1072.
- Sul cognome Kajanto 1982, pp. 18, 81, 312; Solin 1996, p. 128 (per le attestazioni in ambiente servile).
- A titolo di esempio vd. infra, pp. 153-159, relative a Barbul(a) o Barbula(ae) // C. Iul(ius?) Poly(—). Si precisa che se il carattere di nomen o di cognomen di Barbula potrebbe essere incerto, ad ogni modo i bolli individuano anche questo personaggio a mezzo di un solo elemento onomastico.
- Cfr. il bollo Numisia L(uci) f(ilia) Firmilla (Mongardi 2013, pp. 460-461; Mongardi 2018, pp. 98-99, 191-193, n. 102).
- Stanco 2001, pp. 182-183 (con lettura ancora incerta); Filippi & Stanco 2005, pp. 145-148. Sulla cronologia del personaggio cfr. infra, pp. 197-199, con ulteriori informazioni. Il marchio, conservato nei depositi di Lucus Feroniae (in provincia di Roma, in Comune di Capena), proveniene da una necropoli suburbana attualmente in proprietà Steto.
- Cfr. CIL XV, 667-688, per una menzione di Rubria come domina di queste figlinae, in rapporto ad un altro officinator C. Calvisius Primus.
- Braito 2020, p. 49 (43 attestazioni).
- Cfr. CIL XV, 438: M. Anthioci de (figlinis) Q(uintianis) Rubriae o de (figlinis) Q(uintae) Rubriae.
- PIR2, Q, 11 = Q, 12?; D’Alessandro 2013, p. 359.
- Vd. infra, pp. 204-206.
- Vd. infra, pp. 171-183.
- Ricci 2006, p. 114.
- Ricci 2006, pp. 115-116.
- CEIPAC 39868-39871; CEIPAC 39909-339911.
- Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 80-81; Cipriano & Mazzocchin 2016, p. 220.
- Si registrano anche due tituli picti in rosso incompleti e di lettura incerta (Fig. 38): Is.[—]; St[—].
- Mal impresso.
- Confronti e bibliografia precedente, a partire dal CIL, sono puntualmente raccolti in Cipriano & Mazzocchin 2016, pp. 220-221, 237-239, cui si fa riferimento salvo che ove diversamente indicato. È noto anche il doppio bollo BAR // SEX.IVL.ORP (Zaccaria 1989, p. 474), riferibile ad un personaggio che presenta lo stesso gentiliziodi Poly(—), ma non lo stesso prenome. Lo scioglimento di BAR in Bar(bula), tuttavia, è in quel caso possibile, ma solo ipotetico. La serie BAR//SEX.IVL.ORP è pertanto distinta rispetto a quella in esame.
- Fosso S. Biagio (sponda destra e sinistra): CIL IX, 6080 4-5; Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 73-75, nn. 1-4. Nel territorio compreso tra il torrente Ete e il fiume Aso, presso Torre di Palme, in località fosso S. Biagio, sulla sponda sinistra, furono rinvenuti resti di ambienti e di una fornace, frammenti di laterizi e molte anfore, attribuite alla tipologia di transizione Lamboglia 2/Dressel 6A. Sulla sponda destra fu individuato uno scarico di anfore Dressel 6A con bollo Barbul(—) // C. Iul(i) Poly(—) che induce a ritenere che nell’area vi fosse l’atelier di questa produzione.
Contrada Castagna: Menchelli & Ciuccarelli 2009, p. 3 Fig. 5. Si veda anche Brecciaroli Taborelli 1984, p. 76, n. 8 (Museo Civico Archeologico). - Mongardi 2018, pp. 74-76, p. 175, n. 66, p. 189, n. 95 (2 esemplari da viale Reiter, I sec.).
- Mazzocchin & Tuzzato 2007, p. 129-130, Fig. 7,1; datazione del contesto (via Acquette): tra l’età augustea e la prima metà del I sec.
- Toniolo 1996, pp. 250-252, nn. 10-11, Fig. 31. 10-11 (2 esemplari).
- CIL XV, 3410, a-b: due esemplari, di cui uno attribuito esplicitamente a Dressel 6A. Ai Mercati di Traiano è stata individuata, in occasione di un controllo autoptico, un’anfora Dressel 2-4, ovvero il contenitore MT 445, con marchio B“AR”B[“VL”]//C.I“VL”.POLY (cfr. infra, pp. 252-259). Deve tenersi invece distinto, salvo diverso riscontro, il contenitore CIL XV, 3474 (C. I“VL”.PAR) ascritto a questa serie in Cipriano & Mazzocchin 2016, p. 239, n. 45.
- Mazzocchin 2013, p. 102, n. 7a; datazione del contesto (Campo Marzio): età tiberiano-claudia.
- Per le considerazioni prosopografiche si segue Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 83-85; contra Mongardi 2018, p. 75, nt. 242.
- Kajanto 1982, p. 224. Barbula risulta anche occasionalmente attestato come gentilizio (Schulze 1991, pp. 349-377, 417; OPEL I, p. 269, con riferimento a CIL V, 7621).
- PIR2, B 52. Cfr. Ferriès 2007, p. 317.
- Broughton 1952, pp. 365, 423; Broughton 1986, p. 8.
- Si veda anche la grafia della P con occhiello aperto.
- Pl., Nat. Hist. 14,8,67.
- Schulze 1991, Indices, p 611; Solin-Salomies 1994, pp. 98-99.
- Solin 1996, Indices, p. 715; Solin 2003, Indices, pp. 1698-1699. A titolo d’esempio, ben attestato è Polybius (Solin 2003, pp. 261-262). Dal punto di vista prosopografico è noto un C. Iulius Polybius, liberto di Augusto (PIR2, I, 475), mentre un Polybius (servus) August(i) tabularius è menzionato a Teramo in un’iscrizione funeraria della metà del I secolo d.C. (CIL IX, 5064). È attestato un altro C. Iulius Polybius, candidato all’edilità e al duovirato a Pompei in età flavia (Cipriano & Mazzocchin 2016, p. 221).
- Mongardi 2018, p. 75.
- Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 84-85.
- I bolli si prestano a diverse letture che vedono di volta in volta nei due nomi le figure interscambiabili di dominus e officinator; in alternativa nel marchio BARBVL si potrebbe celare il riferimento a dei fundi/praedia o ad una figlina (Cipriano & Mazzocchin 2016, p. 222 per tutte le possibili proposte). L’ipotesi è stata estesa, mettendo ipoteticamente in rapporto le due produzioni, anche al bollo BAR, associato a Sex. Iul(ius) Orp(—).
- Maritan et al. 2019, p. 207.
- Si segnala ad ogni buon conto anche un operculum fittile a matrice da Finale Emilia, loc. Villa Rovere, Cà Rossa, con analoga sigla a rilievo (Mongardi 2018, p. 225, n. 10).
- Sulle numerose possibilità di integrazione come cognome servile Solin 1996, Indices, pp. 722-723; per la corposa lista dei grecanici che iniziano per The(—) Solin 2003, Indices, pp. 1710-1712, tra cui emergono i composti di theo-, a titolo d’esempio i ben attestati Theodorus (Solin 2003, pp. 78-80) e Theophilus (Solin 2003, pp. 85-86). Due sole sono invece le possibilità di integrazione come cognome latino, con i rari etnici Thermitanus (Kajanto 1982, p. 194) e Thevestinus (Kajanto 1982, pp. 50, 207.)
- CEIPAC 39872.
- RTAR III, n. 4309. Il bollo è attribuito ad un contenitore non identificato; l’aspetto del marchio è molto simile a quello del reperto del Nuovo Mercato Testaccio.
- Il bollo, attestato su un frammento di parete, è stato attribuito in prima istanza al contenitore Dressel 6A (Brecciaroli Taborelli 1995, p. 88), mentre successivamente è stato assegnato a un’anfora Lamboglia 2 (Gabucci & Quiri 2008, p. 65, tav. XXIII, 8). Il contesto di rinvenimento si data tra l’età augustea e il I sec. d.C. Nel caso del Nuovo Mercato Testaccio, il frammento, in assenza di dati tipologici, è stato attribuito a una Dressel 6A, poiché lo spessore della parete su cui il marchio è apposto (2 – 2,5 cm) indizia un contenitore piuttosto massiccio; d’altronde l’impostazione stessa del bollo pare più consona alle Dressel 6A.
- CEIPAC 39867, 39873.
- I due bolli sono qui trattati separatamente (per le motivazioni vd. supra, pp. 145-153).
- Cfr. pp. 145-153, 196-199.
- L’anfora appartiene alle vecchie collezioni civiche confluite nel 1968 nel Museo Archeologico Nazionale allora istituito. Purtroppo non ci sono dettagli sulla provenienza, in quanto tali raccolte si formarono nel corso dei due secoli precedenti per iniziativa di nobili locali (informazione personale Gregorio Aversa, Direzione Regionale Musei della Calabria).
- Probabilmente da collocarsi tra il I sec. a.C. e l’età tiberiana (Bezeczky 2006, p. 306), se non da contenere entro il I sec. a.C., considerata l’associazione con materiali precedenti l’epoca augustea (Bezeczky 2013, p. 22).
- CEIPAC 39874 – 39878.
- CIL IX, 6080, 8.
- Mongardi 2018, pp. 78, 176, n. 70 a-b, 2 esemplari dal Parco Novi Sad, bonifica SW, US 1910 (età giulio-claudia) e da viale Reiter (I sec.).
- Cipriano & Ferrarini 2001, p. 97, n. 2. Il bollo è attestato in un contesto databile tra l’età claudia e il principio dell’epoca flavia.
- CIL XV, 3423.
- CIL V, 8112, 23.
- RTAR II, n. 884.
- Le proposte di scioglimento si trovano in Cipriano & Ferrarini, 2001, 97, n. 2 e tengono conto delle gentes attestate in Cisalpina e lungo l’arco adriatico. Altri possibili scioglimenti in Schulze 1991, Indices, p. 603.
- Kajanto 1982, pp. 64, 65, 134, 228; Solin 1996, p. 53.
- Cipriano & Mazzocchin 2018, p. 268.
- Cipriano & Ferrarini 2001, p. 98, n. 3. Il bollo è attestato in un drenaggio databile tra l’età claudia e il principio di quella flavia.
- Kajanto 1982, p. 237.
- PIR2,C, 201. Cfr. Tac., Ann. 12, 40.
- Cipriano & Mazzocchin 2018, pp. 265-268.
- CEIPAC 39879.
- Per confronti, esclusioni e bibliografia di riferimento, salvo che ove diversamente indicato e ove necessitino integrazioni, ci si riferisce a Mongardi 2018, pp. 78-79. Sono rappresentati differenti punzoni con varie abbreviazioni; la formula del Nuovo Mercato Testaccio trova confronto a Roma e al Magdalensberg. Dubbia è nella riflessione di M. Mongardi la possibilità di vedere un riferimento a C. Caristanius Fronto anche nei bolli a lettere cave libere C.C.F e C.C.F.P, attestati nel modenese su due anfore provenienti entrambe dalla bonifica SW delloscavo del Parco Novi Sad in un contesto databile entro l’epoca giulio-claudia (Mongardi 2018, p. 175, nn. 67-68); il primomarchio trova confronto ad Aquileia e forse a Novara e a Reculver, in Britannia, mentre il secondo è documentato anche a Milano e probabilmente a Padova. Per l’ascrizione a questa produzione almeno del bollo C.C.F, facilmente interpretabile come abbreviazione di tria nomina, potrebbe costituire un confronto la serie di L. Tarius Rufus cui è attribuito, seppur dubitativamente, anche il marchio L.T.R (vd. infra, pp. 204-206).
- Dalla bonifica di prima età imperiale in via Selmi: Mongardi 2018, p. 177 n. 72. Forse sono da includere anche Mongardi 2018, p. 175, nn. 67-68.
- RTAR III, n. 2032, cui occorre aggiungere le 2 attestazioni reperite in un drenaggio databile ad età giulio-claudia e pubblicate in Cipriano & Mazzocchin 2011, pp. 340-341.
- In Wypijewski & Pietruszka 2013, p. 199 si propone una rilettura del bollo RTAR III, n. 4227, appartenente a contenitore non identificato (si tratta di un frammento di collo, segnato da una risega).
- Il bollo CIL XV, 3427, rinvenuto dietro le Terme di Diocleziano, presentava difficoltà di lettura nella parte finale e aveva sul collo un titulus pictus in rosso (CIL XV, 4672), letto PL“AN”.
- Maier & Maidl 1992, p. 81. Il bollo è attestato in 3 esemplari corrispondenti a 2 varianti.
- Carreras & Berni 2014, pp. 187-189 (età augustea?). In CEIPAC 32198 il bollo è riferito in maniera solo dubitativa a Dressel 6A.
- CIL VIII, 22637, 26.
- Per il cognomen latino Fronto Kajanto 1982, pp. 17, 26, 118, 236.
- Carre 1985, pp. 212-213.
- PIR2,C, 423.
- PIR2,C, 424.
- CIL XI, 3254.
- Camilli & Taglietti 1994, pp. 314-322.
- Per il gentilizio Schulze 1991, pp. 147, 237, 396, con elenco di testimonianze epigrafiche di ambito occidentale.
- Wypijewski & Pietruszka 2013, pp. 191-202.
- PIR2, C, 425.
- Christol et al. 2001, pp. 1-20.
- Zaccaria 1989, p. 480; Christol et al. 2001, pp. 4-6.
- Cipriano & Ferrarini 2001, p. 98, n. 3. A tale bollo è attribuita una cronologia più recente. Vd. supra, p. 165.
- Per confronti e bibliografia ci si riferisce principalmente a Cipriano & Mazzocchin 2018, p. 267, ove si rappresenta come a Padova e Modena sia peraltro attestato anche il marchio TCS: sebbene non costituisca un confronto puntuale, è forse riferibile alla stessa serie del marchio “TI”CLS (cfr. Mongardi 2018, p. 77). Integrazioni bibliografiche e precisazioni si trovano nelle note seguenti.
- Mongardi 2018, p. 177 n. 75, buca NW Parco Novi Sad, US 3132 (età giulio-claudia – età traianea).
- A Padova il bollo è attestato in un drenaggio databile tra l’età giulio-claudia e quella flavia (Mazzocchin et al. 2006, p. 26, Fig. 10, 29).
- Cipriano & Ferrarini 2001, p. 99, n. 4. Il bollo è attestato in un contesto databile tra l’età claudia e il principio di quella flavia.
- Il marchio è presente su un contenitore con collo a imbuto.
- Mazzocchin et al. 2006, p. 26; Cipriano & Mazzocchin 2018, pp. 265-269.
- Maritan et al. 2019, p. 207.
- Cipriano 2016, pp. 151-153. A questo testo si rifanno per lo più le note onomastiche e prosopografiche che seguono.
- PIR2, Q, 38.
- Kajanto 1982, pp. 157, 223 e Solin 1996, p. 58.
- La notazione si basa sulla documentazione presente nei database epigrafici on line, in particolare EDCS ed EDR (consultati in data 23.04.2024).
- CEIPAC 39885 – 39906.
- D’Alessandro 2011, p. 610, con tentativo di sistematizzazione dei punzoni individuati.
- Per i confronti si veda la lista stilata in Buchi 1973, p. 573 e i più recenti: Cipriano-Ferrarini 2001, p. 104; D’Alessandro 2011, p. 613; Mazzocchin 2013, p. 100; Mongardi 2018, pp. 81-83. Precisazioni e integrazioni bibliografiche si trovano nelle note seguenti.
- Fortini 1993, pp. 91-92; Fortini 1998, pp. 47-48. Sull’ipotesi di una produzione in loco si tornerà più oltre nel testo.
- RTAR III, n. 3431.
- Toniolo 2016, pp. 105-109.
- Belotti 2004, p. 17, n.3; p. 41, n. 33; p. 47, n. 50; Cipriano 2016, pp. 147-148.
- Il bollo THB è presente su alcune Dressel 6A reimpiegate in una diga ad anfore, intercettata nell’ager Portuensis (Morelli et al. 2011, pp. 266-271). L’apprestamento si data tra l’età augustea e la metà del I sec. d.C.
- A Oderzo la presenza del bollo è considerata residuale in un drenaggio databile tra il 45 e l’80 d.C. (Cipriano & Ferrarini 2001, p. 105).
- RTAR II, n. 852.
- Mongardi 2018, pp. 181-183 n. 89.
- Corti & Simeoni 2021, pp. 63-66, 80-81 nn. 1-5. Si segnala l’attestazione di quattro esemplari su cinque di modulo più piccolo (altezza max. 95 cm) rispetto alla Dressel 6A classica e con impasto più ricco di inclusioni.
- Toniolo 1996, pp. 248-250, nn. 7-9, Fig. 30.7-9 (3 esemplari).
- Oltre ai ritrovamenti già noti (CIL XV, 2905, cfr. infra, pp. 252-259; Lissi Caronna 1968, pp. 10-15), si menziona un’anfora rinvenuta sul Palatino presso il tempio della Magna Mater (informazione personale Fulvio Coletti). Un esemplare compreso nel CIL recava inoltre un titulus pictus in rosso sul collo (CIL XV, 4657g), con l’onomastica di un personaggio M. Utan(i) Hym(enaei) che torna anche su anfore con bollo BARBA (CIL XV, 3408c), nonché come bollo (?) in lettere cave entro cartiglio su un contenitore di forma non precisata (CIL XV, 3546). Inoltre, il titulus pictus CIL XV, 4660 presente in varie redazioni su anfore recanti il bollo THB (sempre in CIL XV, 2905), è attestato anche su contenitori a marchio BARBARI (CIL XV, 3408a) e PONTIC“VL” (CIL XV, 3508).
- Luciani 2012, pp. 77, n. 108.
- Nove esemplarti da siti terrestri e marittimi (Bajtler 2021, pp. 20, 27, 29, 34-35 n. 12; cfr. RTAR n. 2938).
- González Cesteros & Berni Millet 2018, pp. 65, 77 n. 5.
- Berni Millet 2017, p. 191, n. 7 (contestuale nel riempimento superiore di una fossa prevalentemente augustea, con alcuni materiali claudio-neroniani).
- Le presenti note costituiscono un aggiornamento e una revisione dei precedenti D’Alessandro 2011, pp. 607-616; D’Alessandro 2016, pp 23-34.
- PIR2, H, 67; Zaccaria 1989, p. 481; Pesavento Mattioli & Zanini 1993, p. 57.
- Per l’origine della gens in area centro-italica Ros Mateos 2007, pp. 1247-1254, Molle 2011 (2012), pp. 7-14, Nonnis 2012, p. 224 (con bibliografia precedente); testimonianze indirette di tale origine sono discusse in Mennella 1993-1994, pp. 133-147 e in Mennella & Barbieri 1997, pp. 586-587.[/efn_note e in particolare ai dintorni di Atina140Salomies 1996, pp. 43-44; Andermahr 1998, pp. 289-290.
- Solin 1981, p. 98. Controllo autoptico dell’iscrizione in data 8 luglio 2016 presso il Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino.
- Magioncalda 1994, pp. 1-7; D’Alessandro 2016, pp 23-34.
- Molle 2008, pp. 151-159.
- Zaccaria 1989, p. 481, nt. 84, con bibliografia precedente.
- Mitchell 1986, pp. 19-25.
- Magioncalda 1994, pp. 1-2, con bibliografia di riferimento.
- Manacorda 2001, pp. 397-399.
- Schindler Kaudelka 2009, p. 319.
- Toniolo 1991, pp. 75-76, 186-187, 220, nt. 103; Tirelli & Toniolo 1998, pp. 93-94.
- Pesavento Mattioli 1998, pp. 311-313, 319.
- Mazzocchin 2013, pp. 37-45, 100.
- Corti & Simeoni 2021, pp. 63-66, 80-81 nn. 1- 5.
- Bruno & Bocchio 1991, pp. 266-267, tavv. CXV, f. 58 e CXXVI, f. 13; Caporusso 1991, pp. 51-63.
- Vd. infra, pp. 259-267; cfr. Hesnard 1980, p. 141-155; Rivello 2002, pp. 421-449.
- Schindler Kaudelka 2009, pp. 320-321: su Lamboglia 2/Dressel 6A in strato di livellamento del settore SH.
- Tchernia 1986, pp. 134, 150, con bibliografia precedente.
- Mongardi 2018, pp. 88 nt. 362, 139-140. Come già rilevato si rinvengono anche altri tituli picti in comune tra le due produzioni.
- Vd. supra, pp. 145-153. Sulla possibilità di apposizione di tituli in occasione del riuso dei contenitori si è già detto.
- Fortini 1993, pp. 91-92; Fortini 1998, pp. 47-48.
- Ci si basa sulla documentazione presente nei database epigrafici on line, in particolare EDCS ed EDR (consultati in data 23.04.2024).
- Ricci 2006, pp. 113-115. I legami parentali sarebbero stati istituiti al principio dell’età imperiale, probabilmente attraverso il matrimonio di una Rubria (forse la figlia di P. Rubrio Barbaro) con un Helvius.
- Manacorda 2012d., pp. 462-469; Nonnis 2012, p. 225. In particolare sarebbe un’Helvia la madre del C. Visellius Varro, cugino di Cicerone, col quale si deve forse identificare il dominus della prima fase produttiva di Giancola (BR).
- Manacorda 2001, pp. 397-399.
- Si ringrazia il Museo Civico “P. Cavoti” di Galatina (LE), che custodisce l’iscrizione (inv. 91), per aver cortesemente messo a mia disposizione dati tecnici e foto del reperto, di cui non è nota l’esatta provenienza.
- Susini 1962, p. 96.
- Manacorda 2012, p. 538.
- Rathbone 1983, pp. 81-98.
- Auriemma 2004, p. 356, nt. 26 (ripreso da Manacorda 2012, p. 538); Auriemma 2004a, pp.160-161. Rita Auriemma segnala la notevole incidenza, tra i materiali dei musei salentini, delle anfore Dressel 6A, per le quali, considerata la derivazione morfologica e l’identità di argilla con il contenitore Lamboglia 2, sicuramente fabbricato anche nella Puglia meridionale, ipotizza una produzione locale.
- Cfr. l’edizione del titulus in Piccottini 1997, pp. 203-206.
- Bruno & Bocchio 1991, p. 261.
- Maritan et al. 2019, p. 207.
- Cfr., a titolo d’esempio, il caso degli Statilii e di Calvia Crispinilla, titolari di proprietà sia nell’Italia meridionale che nell’Adriatico settentrionale, dove risultano implicati nella produzione anforaria (Manacorda 2012, pp. 539-540); cfr. ancora i Rubrii che hanno investito in attività produttive tanto sulla costa adriatica, quanto lungo la valle del Tevere.
- Esso non è repertoriato tra i cognomina latini in Kajanto 1982, mentre tra i grecanici viene citata soltanto un’occorrenza (CIL VI, 11951), peraltro come nome femminile in un’iscrizione di II-III sec. di incerta lettura (Solin 2003, p. 1085). Il cognome figura in OPEL I, p. 273, con riferimento a CIL V, 7296, probabilmente ancora come parte di una formula onomastica femminile.
- Ros Mateos 2007, pp. 1247-1254; Nonnis 2012, pp. 224-225.
- IIt III, 1, nr. 229; Andermahr 1998, pp. 289-290.
- Su questa produzione Belotti 2008, pp. 295-301 e Cipriano & Mazzocchin 2016, pp. 226-227, 241 (con bibliografia precedente), cui sono stati attinti i confronti e le note prosopografiche.
- In questo caso, il bollo è apposto su un’anfora Dressel 6B, a differenza degli altri esemplari che figurano su Dressel 6A (ignoto, però, è il tipo dell’attestazione cartaginese CIL VIII, 22637, 55).
- PIR2, I, 570-578 (vari praenomina).
- PIR2, I,576.
- Kajanto 1982, pp. 11, 20, 22, 30, 68, 69, 256; Solin 1996, p. 68.
- Per tali considerazioni in particolare Cipriano & Mazzocchin 2016, pp. 226-227.
- Bezeczky 2013, p. 121, n. 647 (contesto: Terrace House 2; materiale sporadico).
- Per le possibili integrazioni, nell’ambito rispettivamente dell’onomastica greca e di quella latina, Solin 2003, Indices, p. 1700 e Kajanto 1965, Indices, p. 406. Nel primo caso è ben attestato Priamus (Solin 2003, p. 560), nel secondo Primus (Kajanto 1982, pp. 29-30, 73-77, 134, 276, 291).
- Non si individuano nomina o cognomina Loienus / Loienius o –loien(us o –ius) in Schulze 1933, Solin & Salomies 1994, Solin 1996, Kajanto 1982.
- Cantarelli 1915, p. 310 = Fornari 1916, p. 102, n. 75 = EDR000452 (consultato in data 31.08.2023).
- Solin & Salomies 1994, p. 447.
- Solin 1996, p. 64. Altre possibili integrazioni in Kajanto 1982, Indices, p. 391.
- Sull’attività manifatturiera della gens Aufidia Tiussi 1997, cc. 21-70, in particolare cc. 43-44; Nonnis 2012, p. 120.
- CIL VIII, 22637, 43.
- Per il gentilizio Schulze 1991, pp. 203, 269, 427, 481.
- Altre possibili integrazioni come gentilizio in Solin & Salomies 1994, p. 229.
- RTAR III, n. 4299.
- RTAR II, n. 867.
- CIL XV, 3483 (attribuito a un’anfora Dressel 6 similis).
- Solin 1996, p. 336; Solin 2003, p. 537.
- Spagnolo et al. 2008, p. 95. Il bollo è assegnato ad età tardo-repubblicana.
- RTAR III, n. 2017, 2021.
- CIL XV, 3490, due esemplari dal Castro Pretorio, di cui uno con segni di interpunzione tondi e titulus pictus (CIL XV, 4658), da considerare irreperibile, l’altro (= MT 82, Fig. 62.2) con segni d’interpunzione tra loro diversi (cfr. Dressel 1879, p. 75, n. 34 e p. 189, n. 4).
- Pavoni & Belotti 2005, p. 186, n. 3.
- Maier-Maidl 1992, p. 99 (il marchio è attribuito a Lamboglia 2). Il bollo LNF, seppure con caratteristiche diverse, è attestato al Magdalensberg anche su Dressel 6B (Maier-Maidl 1992, pp. 61-62).
- Callender 1965, p. 162, n. 900.
- La formula, priva di riscontri nella PIR2, ricorre a quanto mi consta in forma completa soltanto in CIL II, 4162, cfr. p. 972 (Le Roux 1972, p. 135, n. 30), seconda metà II sec. d.C. e in CIL VI, 975 (p. 3070, 3777, 4312, 4340) = CIL VI, 31218, a. 136 d.C.
- Da ultimo Nonnis 2012, p. 292; Antolini & Marengo 2014, pp. 668, 687.
- Mongardi 2013, pp. 460-461; Mongardi 2018, pp. 98-99, 191-193, n. 102. Vd anche Braito 2020, p. 238.[/efn_note, che a Rimini205Stoppioni 2021, p. 288.
- Nonnis 2012, pp. 166, 293.
- CIL V, 1893.
- CIL XI, 1147, VII, 23.
- La filiazione e il cognomen consentivano l’esatta identificazione della donna che bollava le anfore, permettendo inoltre di riscontrarne lo status di ingenua (Braito 2020, pp. 47, 49). Tale indicazione non è tuttavia esclusiva di personaggi femminili (Cipriano & Mazzocchin 2000, cc. 175-176).
- CEIPAC 39914.
- Da ultimo un quadro generale si trova in Mongardi 2018, pp. 77. Si segnala inoltre il marchio Ninni su Dressel 6A con impasto medio-adriatico da Parma, pubblicato in Corti & Simeoni 2021, pp. 66-67, 82 n. 12. Indicazioni bibliografiche puntuali sono contenute nelle note seguenti.
- I marchi sono apposti sia su anfore Dressel 6A (un esemplare) che su contenitori a fondo piatto (5 esemplari), anche con onomastica abbreviata: Carre 1985, p. 234.
- Toniolo 2016, pp. 105-109 (Dressel 6A).
- Belotti 2004, p. 38 n. 29 (la tipologia dell’anfora è imprecisata).
- Mongardi 2018, p. 191 n. 101 (quattro esemplari di Dressel 6A da un contesto compreso tra età giulio claudia ed età traianea).
- CIL XV, 3494 (Dressel 6A).
- CIL IX, 6078, 204. Il marchio risulta apposto su una tegola e l’area di rinvenimento potrebbe coincidere con quella di produzione delle anfore (Carre 1985, p. 239).
- Auriemma & Degrassi 2015, pp. 170 Fig. 4, 173.
- Carre 1985, p. 239 (con bibliografia precedente); Schulze 1991, p. 424.
- Zaccaria 1989, pp. 477-478.
- Kajanto 1982, pp. 30bis, 74, 75, 76, 77, 292; Solin 1996, p. 149.
- CEIPAC 39915.
- RTAR II, n. 870.
- CEIPAC 39916.
- RTAR II, n. 871.
- Mongardi 2018, p. 80, 194 n. 104. Il bollo è attestato in un contesto riferibile ad età giulio-claudia.
- RTAR III, n. 3279.
- CIL XI, 6995, 72a. Come nei casi seguenti di Parma e Reggio Emilia, nel Corpus Inscriptionum Latinarum non è segnalata la tipologia dell’anfora su cui il marchio è apposto, ma le caratteristiche tecniche e paleografiche del bollo inducono ad inserire le testimonianze emiliane tra i confronti per il bollo attestato a Roma.
- CIL XI, 6995, 72c.
- CIL XI, 6995, 72b.
- Maier-Maidl 1992, p. 88.
- Schulze 1991, Indices, p. 619.
- Schulze 1991, pp. 211-212.
- Cfr. PIR2, P, 455-458.
- CIL XV, 3420, in associazione al titulus pictus CIL XV, 4866 (in greco).
- CEIPAC 39924.
- RTAR III, n. 2067.
- CIL XV, 3512 (1-2); i marchi sono attribuiti ad una Dressel 6 similis.
- RTAR II, n. 872.
- RTAR I, n. 228.
- CEIPAC 39919 – 39922.
- Cfr. in questo volume pp. 145-153, 162-164, 198-200.
- Come già rappresentato, l’anfora appartiene alle vecchie raccolte civiche, formatesi su iniziativa della nobiltà locale e confluite nel 1968 nel Museo Archeologico Nazionale; non si dispone pertanto notizie precise sulla provenienza (informazione presonale Gregorio Aversa, Direzione Regionale Musei della Calabria).
- Per la diffusione si confrontino anche i paragrafi riservati agli altri marchi della serie ((vd. supra, pp. 145-153, 162-164, 197; Tav. V, Fig. 2).
- Calabi Limentani 1991, p. 476; cfr. sulla problematica titolatura di Caligola D’Alessandro in corso di stampa a.
- Si vedano per confronto le testimonianze relative a datazione consolare con un solo nome su contenitori anforici in Pesavento Mattioli 2016, p. 94.
- Sull’ordine dei nomi e sulle anomalie nella datazione consolare Salomies 1993, pp. 108-110.
- Calabi Limentani 1991, p. 170.
- Pesavento Mattioli 1987, pp. 152-166; Manacorda 2012b, pp. 195-209; Pesavento Mattioli 2016, pp. 91-99, con censimento di tutte le testimonianze. Sinora si è trattato comunque di personaggi maschili.
- Manacorda 1993, pp. 37-54.
- Pesavento Mattioli 2016, p. 97.
- Filippi & Stanco 2005, pp. 145-148; Braito 2020, pp. 254-256. La produzione, localizzabile nell’agro di Narnia o tra Interamna e Carsulae, si colloca in età tiberiana o claudia, coerentemente con quanto testimoniato dal bollo in esame.
- Seguendo la logica del bollo consolare come forma di certificazione o controllo dell’industria laterizia, estesa per scrupolo o eccesso di zelo a quella anforaria, si potrebbe affermare che Rubria rappresentasse quanto meno la produttrice dei contenitori da trasporto, proponendo di aggiungere un tassello, relativo però tuttavia a questo specifico caso, all’annosa questione del significato della bollatura delle anfore (su cui in sintesi Pesavento 1987, pp. 155-156; Manacorda 1993, pp. 37-54). Secondariamente sarebbero da indagare le caratteristiche dell’attività manifatturiera nell’area di riferimento, per comprendere se la donna abbia prodotto anche le derrate da invasare.
- Si veda, per confronto, il bollo di Numisia L(uci) f(ilia) Firmilla, su cui cfr. supra, pp. 187-188; per il possibile significato della filiazione in tali bolliBraito 2020, pp. 47, 49. Più in generale, lo scioglimento della seconda riga del bollo in esame nella presente scheda è suggerito nel suo complesso dall’uso dei casi e dai confronti; si veda tra l’altro l’indice RTAR III, s. v. figlinae, officinae, portus et nom des lieux, nonché Braito 2020, pp. 26-27. Tuttavia si rappresenta anche la possibilità di un formulario Rubriae P(ublii) f(iliae), con un f(iliae) addizionale,volto a sottolineare ed esaltare la relazione familiare, con riscontri nell’epigrafia lapidaria (Salomies 1993a, pp. 95-101). Si tratta di una soluzione affascinante, ma meno praticabile poiché mancherebbe la menzione esplicita e autonoma del pater, presente o presupposta nei testi di confronto, e non vi sarebbero ulteriori esempi di quest’uso della formula su instrumentum.
- A titolo d’esempio si citano i bolli del padre di Rubria, Barbarus e quelli di B“AR”B“VL”//C.I“VL”.POLY (cfr. supra, pp. 153-159), quest’ultimo anche per la possibile associazione di personaggi con gentilizi diversi.
- CEIPAC 39926.
- Per i confronti citati Mazzocchin 2013, p. 103, n. 9, nt. 291; Mongardi 2018, pp. 86-87; Braito 2020, pp. 267-268 (con bibliografia precedente). Precisazioni e ulteriore letteratura sono contenute nelle note seguenti. Il marchio è attestato sia in lettere cave prive di cartiglio, peraltro abbreviato, come al Nuovo Mercato (cfr. Aquileia; Brescello, RE; Cartagine; Cavtat; Chiunsano, RO; Cusano Milanino; Imola, BO; Modena; Roma; Padova; Vercelli; Verona; Villanova, BO) che in lettere a rilievo comprese entro cartiglio rettangolare. La formula onomastica conosce differenti forme di abbreviazione e di legatura, al pari di quanto avviene per i bolli di L. Tarius Rufus (vd. infra, pp. 204-206).
- RTAR n. 3385.
- ATS, Archivio Topografico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano, Cusano Milanino (6 giugno 1956, 26 aprile 1976, 3 maggio 1976): ritrovamento di collo d’anfora con bollo SAF.PIC, inv. 7799. È possibile che la trascrizione del marchio entro cartiglio inv. 7798, ]FINI“AE”PRE**, rinvenuto assieme al precedente, debba essere corretta in ]FINI”AE”PICE**. In tal caso nello stesso deposito archeologico si troverebbero due diverse forme del bollo. Entrambi i reperti risultano purtroppo irreperibili (ottobre 2021). Si ringraziano i colleghi Tommaso Quirino e Francesca Roncoroni per la documentazione fornita.
- RTAR II, n. 874.
- Mongardi 2018, pp. 194-195, nn. 107 (= CIL XI, 6695, 82b) – 108 (bonifica datata ad età giulio-claudia).
- In città sono stati rinvenuti più esemplari; in via Acquette il bollo (lettere incavate) è stato recuperato in un contesto databile tra l’età augustea e la prima metà del I d.C. (Mazzocchin & Tuzzato 2007, pp. 130 e 131, Fig. 7, 3). Si vedano anche RTAR III, nn. 2007, 2030, 2073.
- Corti & Simeoni 2021, pp. 63, 84 nn. 14-16 (tre esemplari).
- Stoppioni 2021, p. 287 (segnalato come testimonianza dubbia).
- CIL XV, 3519 (dall’Esquilino, tra via Principe Umberto e via Gioberti): SAF.P(IC) a lettere cave; Ferrandes 2008, pp. 250-251 (due esemplari del bollo, in forma abbreviata, con lettere incavate senza cartiglio e segno distintivo ben marcato tra gli elementi onomastici provengono dal terrazzamento artificiale di via Sacchi, databile alla tarda età augustea); Nocera 2012, pp. 77, 80, Fig. 7e (SAFINIAE.PICE in rilievo entro cartiglio rettangolare).
- Gamberini 2011, pp. 252-253, nn. 68, 73; controllo autoptico (n. 73), agosto 2015 presso il Museo Civico Archeologico “A. Casagrande” di Castelleone di Suasa (AN).
- CIL XI, 6695, 82a (non è indicata la tipologia del contenitore).
- https://sangiulianonline.it/wp-content/uploads/2021/09/doc06222520210916102829_001.jpg (consultato in data 16.10.2023; bollo irreperibile già a febbraio 2022: informazione Francesca Roncoroni, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano): S“AF”I“NI”“AE”“PI”CE“NT”I.
- Bajtler 2021, pp. 20, 27 (2 esemplari dalla Casa di Dioniso).
- CIL VIII, 22637, 92-93.
- Per le note onomastiche cfr. Marengo 2003, pp. 76-77; Mazzocchin 2013, p. 103.
- Per il gentilizioSchulze 1991, pp. 223, 481, 522; per le possibili integrazioni del cognome Kajanto 1982, p. 185 e Solin 1996, p. 36.
- Kajanto 1965, p. 185; Solin & Salomies 1988, p. 378; Solin 1996, p. 36. Si vedano anche i più rari Picentius e Picentinius.
- In particolare EDCS ed EDR (consultati in data 29.06.2022).
- Zaccaria 1989, p. 478.
- SEG 34, 1984, n. 866.
- Per la diffusione della gens in epoca repubblicana e tardo-repubblicana cfr. Nonnis 2012, p. 367. Si segnala una produzione di ceramica fine attribuibile ai Safinii, localizzata ad Alba Fucens. Occorre inoltre sottolineare la presenza a Suasa, nella Regio VI, Umbria et Ager Gallicus della stele della liberta Safinia Prima, databile a età tiberiana (AE 1992, 567). Altre attestazioni provengono da Atella, Capua e Narona.
- Mongardi 2018, pp. 86-87.
- Maritan et al. 2019, p. 207. Le analisi petrografiche, mineralogiche e geochimiche sui reperti di Suasa hanno invece evidenziato che due bolli di questa produzione hanno caratteristiche differenti, l’uno appartiene al gruppo delle adriatiche, mentre l’altro è affine ad un gruppo di contenitori costituito quasi esclusivamente da Dressel 30; l’ipotesi di una provenienza nord-africana del campione è stata tuttavia ridimensionata (Gamberini 2014, p. 535; Esquilini 2014, p. 589), rispetto alla pubblicazione preliminare (Gamberini 2011, pp. 252-253 ), valorizzando i dati archeologici ed epigrafici rispetto a quelli archeometrici.
- CIL I2, 2212.
- CIL IX, 6080, 20 (bollo su ansa di contenitore imprecisato, rinvenuto assieme a CIL IX, 6080, 8 – T.CAE/FVSCI – in contrada Colle Marino: l’apografo sembra restituire un marchio derivato dal medesimo punzone del nostro); da tale bollo deriva l’ipotesi di integrazione del reperto del Nuovo Mercato.
- Solin & Salomies 1994, p. 171. Vd. CIL I2, 2706 (Minturnae) e CIL IX, 6136 (Brundisium), prenome Publius.
- Petrullus, -i da Petro (Kajanto 1982, pp. 128, 310) o Petrus, -i (Solin 2003, pp. 277-281), attestato però quasi esclusivamente in epoca tarda. Cfr. per entrambi OPEL III, p. 136, dove non si registrano altre possibilità di integrazione.
- Schulze 1991, p. 483; Solin – Salomies 1994, p. 63. Sembra più plausibile riconoscere in Diani un gentilizio piuttosto che un cognome. Il cognomen Dianus (Kajanto 1982, p. 215), infatti, anch’esso scarsamente attestato, si accompagnerebbe, in questo caso, ad un altro cognomen.
- CIL IX, 5212: P. Diani P(ublii) f(ilii) / Fab(ia tribu) Nigri / ossa.
- Kajanto 1982, p. 242; Solin 1996, p. 57.
- Desy 1989, p. 26, n. 51 (= Callender 1965, p. 143, n. 751) e p. 46, n. 220. Nel primo caso il bollo è preceduto da un segno non interpretabile (lettera o simbolo), nel secondo da una palmetta. Per D. Manacorda (Manacorda 1989, p. 451, nt. 32) si tratta di anfore Dressel 1. Sia Desy che Manacorda hanno effettuato il controllo autoptico del marchio conservato a Taranto.
- Cankardeş Şenol 2013, p. 390, n. 4.
- Manacorda 1989, p. 451, nt. 32 (Museo dell’Agorà).
- Spolio di PIR2, S. Per il cognomen di origine etrusca, Kajanto 1982, p. 106 e Solin-Salomies 1994, p. 409 (cognomen senatorio).
- Syme 1986, pp. 255-269. I membri di questa aristocrazia, dapprincipio emarginati, erano invece tornati in auge nella piena età augustea.
- Delplace 1993, pp. 35-43.
- Palazzo 2013, pp. 157-160 (Forma Apani III, I metà I sec. a.C.).
- Manacorda 1994, pp. 15-16.
- PIR2, C, 1460.
- Manacorda 1989, p. 451, nt. 32.
- Dieci attestazioni complessive tra I e II sec. d.C. (Solin 1996, p. 21).
- CEIPAC 39927-39929.
- A pari di quanto avviene per la produzione di Safinia Picens / Picentina (vd. supra, pp. 199-201), i bolli che riportano l’onomastica del personaggio in questione si presentano sia in forma estesa che abbreviata, talora addirittura come monogramma “LTAR” su Lamboglia 2. I marchi in lettere cave libere L.T.R. su Dressel 6A sono riferiti, seppur dubitativamente, al medesimo individuo, i cui tria nomina sarebbero ridotti alle sole iniziali. Per la discussione dei punzoni Mongardi 2018, p. 90; dubbi sull’individuazione di un unico personaggio in Starac 2020, pp. 161-162. Un fenomeno analogo si potrebbe registrare anche nell’epigrafia anforica relativa alla produzione di C. Caristanius Fronto (cfr. supra, pp. 166-168).
- I casi in cui il bollo ricorra su contenitori Lamboglia 2 sono segnalati in nota.
- RTAR III, n. 3346 (L.T.R).
- Forti & Paci 2008, p. 321 n. 16 (Lamboglia 2).
- RTAR III, n. 2555 (Lamboglia 2); Cipriano & Carre 1989, p. 99.
- RTAR II, n. 880.
- Toniolo 2016, p. 109, Fig. 4,19.
- Nicodemo et al. 2008, p. 290 (Lamboglia 2).
- RTAR II, n. 878-879.
- CIL IX, 6080, 22.
- Gabucci & Quiri 2008, p. 67.
- RTAR III, n. 2890 (Lamboglia 2).
- Mongardi 2018, pp. 96, n. 111 (due esemplari da un contesto databile ad età giulio-claudia).
- Spagnolo et al. 2008, p. 95.
- RTAR III, nn. 1998 (Lamboglia 2), 2028 (L.T.R), 2029, 2082, 3301, 3302.
- Bruno 1995, pp. 66-69 (Lamboglia 2).
- Toniolo 1996, pp. 247-248, n. 6, Fig. 30.6 (L.T.R).
- CIL IX, 6080, 32.
- Lahi 2009, p. 114 (due esemplari di Lamboglia 2).
- Mailer Maidl 1992, pp. 90-92, n. 4.2.1.10 (una testimonianza è rappresentata dal marchio abbreviato L.T.R).
- Starac 2020, p. 87 n. 1273, 161-162. Il monogramma “TAR” è stato sciolto in Tarius. Considerata la cronologia del deposito di Pola (45 -25 a.C.) il bollo è stato riferito in via d’ipotesi al padre di L. Tarius Rufus console del 16 a.C., cui sono attribuiti anche alcuni tituli picti la cui lettura resta tuttavia molto incerta.
- RTAR III, n. 3457 (Lamboglia 2).
- CIL III, 12010, 30.
- Patterson 1982, p. 153; Tchernia 1986, p. 131.
- PIR2, T, 19. Con riguardo all’onomastica, per il gentilizio vd. Schulze 1991, pp. 89, 425; per il cognomen latino Rufus,vd.Kajanto 1982, pp. 19, 26, 27, 30, 64, 65, 121, 134, 229.
- Pl., Nat. Hist., XVIII, 37.
- Maritan et al. 2019, p. 207.
- CIL XV, 3453 (due esemplari).
- Solin 1996, p. 416; Solin 2003, pp. 803-804.
- Schulze 1991, pp. 289-290, 297-298.
- Cfr. i bolli SC“AE”“VAE”“AVF”IDI (Tiussi 1997, cc. 21-70).
- PIR2, T, 301.
- Mazzocchin & Pastore 1996-1997, pp. 170-171; Tassaux 2001, pp. 516-517.
- Attestazioni da Aquileia, Oderzo (TV), Padova, Russi (RA), Poetovio, Siscia; in associazione a FEL ad Aquileia e in uno dei due esemplari da Oderzo(da ultimo Gaddi & Maggi 2017, p. 301).
- CEIPAC 39930.
- Mongardi 2013, pp. 461-462; Mongardi 2018, pp. 92-93, 197-198 n. 117. Il bollo conosce a Modena cinque attestazioni nell’ambito del Parco Novi Sad, buca NW, una delle quali proveniente dall’US 3266, databile alla fine del I sec. a.C. Su uno dei contenitori modenesi (n. 117a4), il bollo compare ripetuto due volte ma realizzato utilizzando matrici differenti: infatti, accanto a un marchio con caratteristiche comuni agli altri esemplari, ne è stato impresso uno identico ma con lettere di modulo nettamente inferiore. L’apposizione del bollo di dimensioni minori, probabilmente frutto di un errore casuale o di una prova dall’esito negativo, ha indotto a supporre che nella medesima figlina venissero fabbricati altri manufatti su cui era più idoneo apporre marchi più piccoli, quali ad esempio laterizi.
- Mongardi 2013, pp. 461-462 (cfr. CIL IX, 5363; 5364; 5365; 5801). Altre possibili integrazioni in Schulze 1991, Indices, p. 630. È possibile anche il completamento come cognome latino (Volcianus in Kajanto 1982, pp. 159, 190).
- A titolo d’esempio Broise 2000, pp. 113-120; Tuomisto 2005, pp. 249-290; Gonzales Muro 2013, pp. 555-571.
- Il cantiere del Nuovo Mercato Testaccio ha restituito i bolli anepigrafi su anfore adriatiche invv. 1431 (ovoide? = infra, pp. 223-224) e 2248 (fondo piatto = infra, p. 219).
- Per il fatto di essere apposti su contenitori Dressel 6A si citano i marchi anepigrafi di Oderzo (Cipriano & Ferrarini 2001, p. 212, n. 125) e di Vicenza (Mazzocchin 2013, p. 107, n. 15).
- CEIPAC 39912.
- L’anfora è stata sottratta dai depositi del Nuovo Mercato in data imprecisata, comunque anteriore al 2015; se ne conservano solo il collo bollato e un’ansa, che erano già staccati dal corpo del contenitore al momento del furto.
- Il reperto presenta anche un titulus pictus dipinto in rosso in verticale alla base del collo, dall’alto in basso.
- Si riportano qui solo i confronti relativi ad anfore Dressel 2-4, rimandando alla scheda relativa ad anfore Dressel 6A (vd. supra, pp. 153-160) col medesimo marchio per un quadro complessivo delle attestazioni e per indicazioni sul possibile luogo di produzione.
- Anfora conservata ai Mercati di Traiano (MT 445).
- Cipriano & Carre 1989, p. 91, nt. 100.
- Panella 1970, pp. 127-131; D’Alessio et al. 2023, pp. 176, 192, n. 87 (Terme del Nuotatore, livelli di età flavia).
- Oltre al bollo anforario M.PALFVRI/SVRAE (CIL V, 8112, 64 su contenitore da trasporto di tipologia imprecisata), il territorio tergestino ha restituito un bollo laterizio con marchio di T.PALFVRI/SVRAE, indizio di una probabile produzione nell’area (Zaccaria & Župančič 1993, pp. 166-167).
- Buora 2005, pp. 101-102. L’anfora (Dressel 2-4?), riutilizzata in una sepoltura databile tra la fine del I e il principio del II sec. d.C., presenta un doppio bollo T. PALFVRI SVRAE / T. PALFVRI LAR: per lo scioglimento del secondo cognome in letteratura è stato proposto Largus (cfr. Kajanto 1982, p. 256; altre possibilità in Kajanto 1982, Indices, p. 396 e Solin 2003, Indices, p. 1678, queste ultime più inconsuete e meno probabili).
- Le note prosopografiche che seguono sono ispirate a Tassaux 2005, pp. 144-145; Zaccaria & Župančič 1993, pp. 166-167.
- PIR2, P, 67.
- PIR2, P, 68.
- Kajanto 1982, pp. 63, 226. Le attestazioni di Sura in ambito servile e libertino sono rappresentate da un cognome femminile di origine illirica (Solin 1996, pp. 614).
- Rispettivamente CIL IX, 4383 (T. Palfurii) e CIL II, 934 (M. Palfurii).
- CEIPAC 39923.
- CEIPAC 39925.
- Amar & Liou 1984, p. 162, n. 91 (due esemplari di provenienza incerta, attribuiti dubitativamente a una produzione della Gallia meridionale o dell’Italia settentrionale).
- Kajanto 1982, p. 316; Solin 1996, p. 132 (una sola attestazione come nome servile).
- A titolo d’esempio PIR2, A, 397, 1001-1005, 1178; PIR2, L, 235, 290-291; PIR2, R, 42-47, 100.
- Non si individuano legami espliciti con l’Adriatico, se si eccettuano i rapporti con il versante orientale della penisola italica di Q. Articuleius Regulus (PIR2, A, 1178), pretore, proconsole e legatus Augusti pro praetore in Lusitania (post 2 a.C.), patrono di Canosa in Puglia (CIL IX, 331).
- CEIPAC 39907-39908.
- D’Alessandro 2011, p. 614.
- Su tali marchi Mazzocchin 2009, p. 201.
- Vd. il peculiare aspetto della T meglio conservata nei reperti invv. 3115 e 3117. Data la complessità del marchio e le difficoltà di lettura non si è tuttavia proceduto a integrare la trascrizione di tutti i reperti.
- L’appartenenza ad un contenitore distinto dall’anfora Dressel 6A, ipotizzata per lo spessore ridotto (1-1,5 cm) dei frammenti rinvenuti dapprincipio (invv. 2632, 3166, 3117), è stata confermata dal successivo recupero nei magazzini di Palazzo Altemps del reperto inv. 3115, che conservava l’attacco inferiore di un’ansa a doppio bastoncello.
- Solin 1996, p. 386; Solin 2003, p. 701.
- RTAR II, n. 1285 (fondo piatto).
- Belotti 2004, p. 36, nn. 26-27 (anfore non identificate).
- RTAR III, n. 4301 (Dressel 6A).
- Mongardi 2018, pp. 188-189 n. 94 (Dressel 6A da contesto databile tra l’età giulio-claudia e l’età traianea).
- Disantarosa 2023, pp. 109-110, Fig. 2.10.
- Belotti 2004, p. 36; Mongardi 2018, pp. 76-77.
- Cfr. a titolo d’esempio i bolli LLPOMPVSIORVM, censiti in RTAR III, nn. 2020 e 2090.
- Schulze 1991, pp. 355, 531; Solin & Salomies 1994, p. 7; OPEL I, p. 44.
- Kajanto 1982, p. 231. È stato anche effettuato un controllo in EDR (ottobre 2023).
- Cipriano & Mazzocchin 2016, pp. 223-224, 240 nn. 58-63.
- Su tutta la questione Cipriano & Mazzocchin 2016, pp. 217-246; Belotti 2008, pp. 298-299. Cfr. supra, pp. 183-184.
- Staffa 2003, p. 132.
- Mazzocchin 2013, p. 147, n. 33. Il cantiere del Nuovo Mercato Testaccio ha restituito i bolli anepigrafi su anfore adriatiche invv. 1431 (ovoide? = infra, pp. 223-224) e 4412 (Dressel 6A = supra, p. 210), alle cui schede si rimanda per ulteriore bibliografia su questo tipo di marchi.
- Si fornisce una trascrizione interpretativa (si vedano di seguito le note onomastiche e prosopografiche per la spiegazione), in luogo di [L]”AL”BHD”AM[AE”].
- RTAR II, nn. 703-704. In questa località, sede di un atelier, si individua il centro produttivo dei contenitori bollati L. Albi Damae o Albiana (Palazzo 1990, pp. 151-154; Palazzo 1993, p. 230).
- Cankardeş Şenol 2013, p. 393, n. 27, Fig. 27.
- Nonnis 2012, p. 77 (con bibliografia di riferimento).
- Per le note che seguono Palazzo 1993, p. 230; Nonnis 2012, p. 77.
- Solin 2003, pp. 1371-1372.
- Lyding Will 1979, pp. 348-349 Fig. 8.
- Benquet 2019, p. 287 n. 1, p. 288 fig. 13.7. La lettura è tuttavia da precisare.
- RRTAR II, n. 770: marchio ]RIAN, la cui lettura può essere in via d’ipotesi rivista in [AL]B*IAN.
- CEIPAC 39917 – 39918.
- Gabucci & Quiri 2008, p. 64, tav. XXIII, 4.
- Biondani 2011, pp. 258-259. Nella medesima pubblicazione sono segnalati (con bibliografia precedente): – un’anfora di tipologia imprecisata con marchio [—P]VBLIC.IVC da Montemilone (PZ);
– alcuni bolli attribuibili a L. (?) Publicii rinvenuti in Italia (Brindisi e Perugia), in Francia (golfo di Fos) e in Egitto (Alessandria). - Silvestrini 1998, p. 97; Manacorda 2012f, p. 186.
- Manacorda 2012f, p. 186. Il marchio costituisce un unicum nel sito.
- Palazzo 2013, pp. 65-66.
- Manacorda 2012f, pp. 184-185, nn. 2-4-6.
- CIL IX, 51.
- Kajanto 1982, pp. 72, 73bis, 283; Solin 1996, pp. 104-105.
- Nonnis 2012, p. 347.
- Si segnala tuttavia la similarità con orli attribuiti a Dressel 6A (Mongardi 2013, p. 460).
- Palazzo 2012, pp. 458-460; Manacorda 2012e, pp. 485-486 (con ulteriori confronti editi e inediti).
- Cipriano & Ferrarini 2001, p. 212, n. 125.
- Manacorda 2012d, p. 486.
- CEIPAC 39863.
- Cipriano & Ferrarini 2001, p. 209, n. 121.
- Per il gentilizio Schulze 1991, p. 347, 426; OPEL I, p. 193.
- CEIPAC 39880 – 39881.
- La trascrizione di questo secondo bollo contiene un’integrazione ipotetica (per le varianti vd. i confronti).
- Sulla morfologia del frammento inv. 4371, US 962 attribuibile alla forma NMT AAD_Orlo 18 = Dressel 6B, si rileva che l’orlo potrebbe essere pertinente, mentre l’attacco dell’ansa pare molto ricadente; naturalmente tale valutazione potrebbe essere viziata dall’estrema frammentarietà dell’attacco stesso (cortesi osservazioni Y. Marion).
- Mongardi 2018, p. 119 per confronti, esclusioni e bibliografia. Il bollo risulta attestato nella variante LCOR“AM”ICI ad Altino (RTAR III, nn. 3331) su Dressel 6A e a Brescello su contenitore imprecisato e nella forma L.COR“NE”“AM”ICI a Padova su Dressel 6B e ad Altino su Dressel 6A (lettura incerta, cfr. RTAR III, nn. 3397).
- RTAR II, n. 847 = RTAR II, n. 900. Alla medesima produzione è stato attribuito anche il marchio LCH, attestato su Dressel 6B da Modena, la cui lettura è stata tuttavia corretta sulla base di confronti in LGH. Le note prosopografiche sono desunte da Cipriano & Mazzocchin 2011, p. 337 e Mongardi 2018, p. 119.
- Cipriano & Mazzocchin 2011, pp. 337-338, Fig. 4.2.
- Il cognomen latino Amicus, attestato soprattutto tra ingenui, è tuttavia secondariamente testimoniato anche tra personaggi di condizione servile e libertina (Kajanto 1982, p. 305; cfr. Solin 1996, p. 123).
- Il grecanico è ben rappresentato in ambito servile (Solin 1996, pp. 291-295; Solin 2003, pp. 368-380, 1475).
- CEIPAC 39913.
- RTAR III, n. 3364.
- Kajanto 1982, p. 263.
- Si confrontino ad ogni modo PIR2, C, 1402; PIR2,, I, 400 e PIR2,, T, 266.