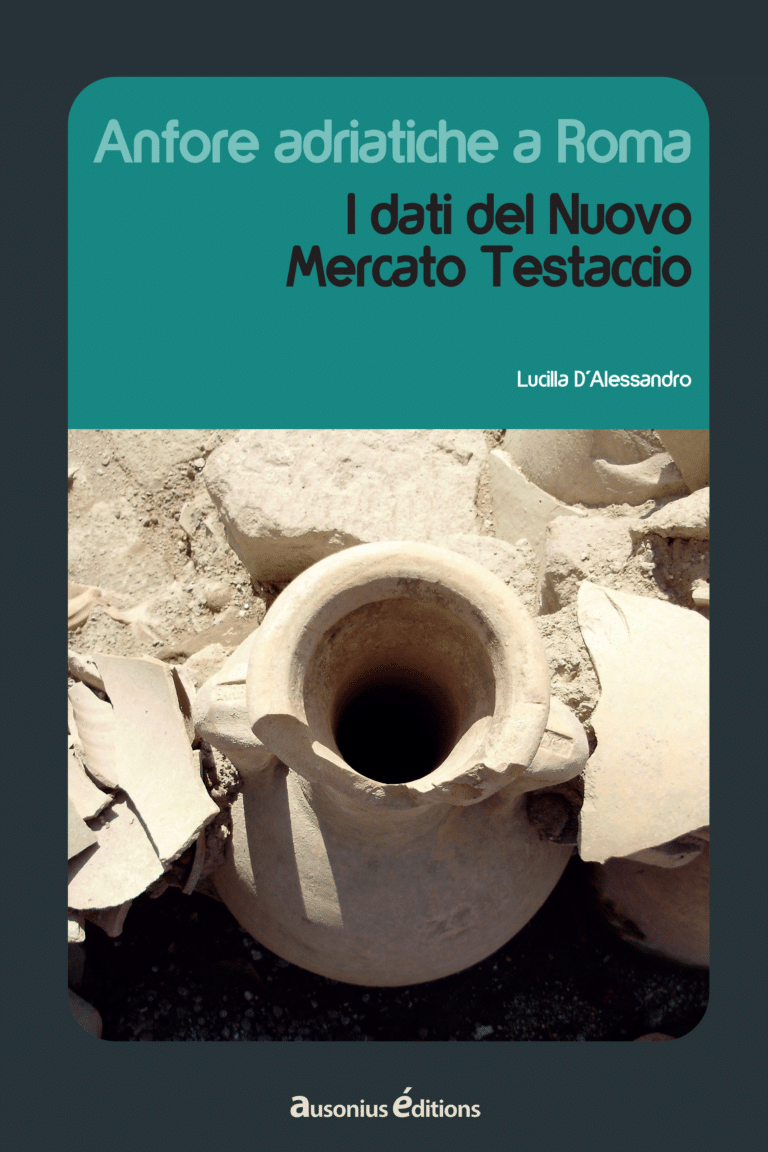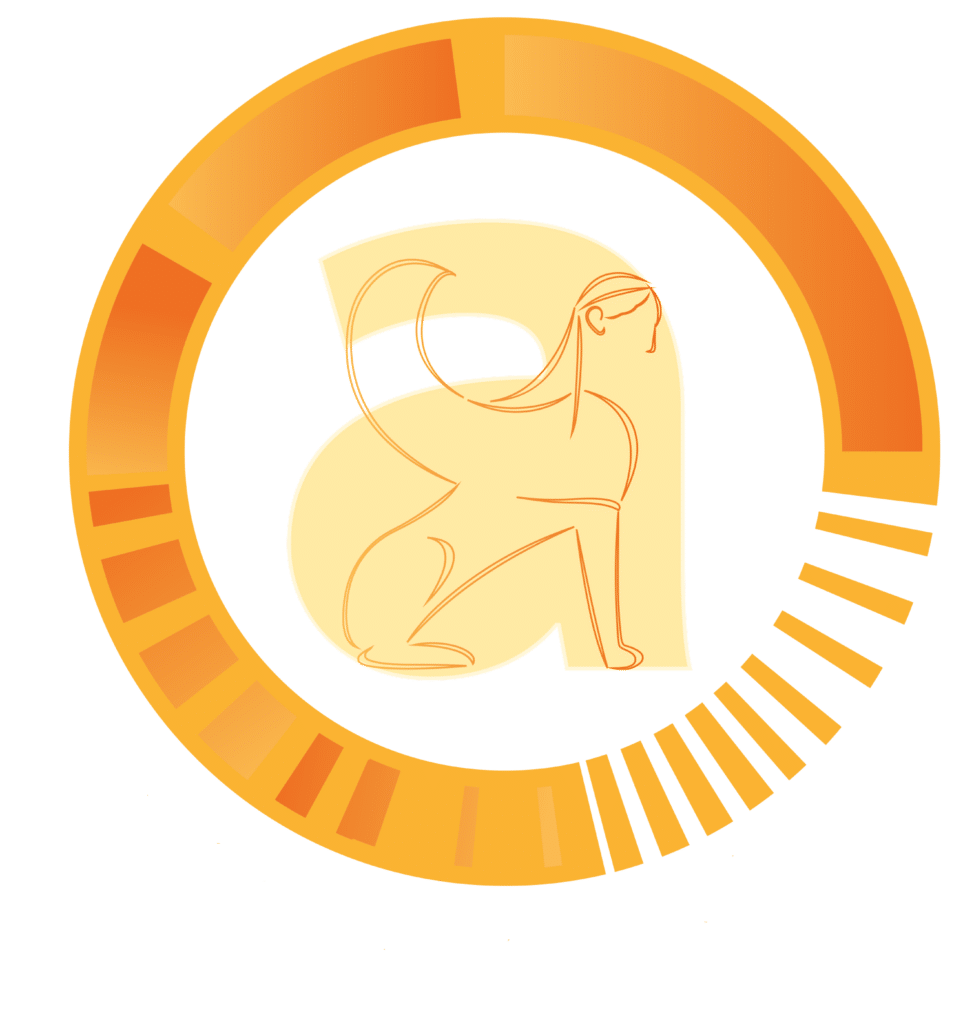La ricerca archeometrica
Ricerca archeometrica e anfore adriatiche
La ricerca archeometrica sulle anfore adriatiche, iniziata negli anni Ottanta del Novecento con i materiali di Fosso S. Biagio (Fermo)1, vanta già una serie nutrita di campagne di analisi di vario tipo relative a contesti di rinvenimento diversi sia per tipologia (centri di produzione, siti di consumo, relitti, etc.) che per cronologia e dislocazione geografica: senza pretesa di esaustività si citano per l’Italia Aquileia2, la Lombardia3, l’area centro-settentrionale e nord-orientale in particolare4, Rimini5, la fornace di Cattolica (RN)6, Suasa (AN)7, l’agro di Fermo8, le manifatture brindisine9; si segnalano inoltre a titolo di esempio le ricerche in Dalmazia10, nelle fornaci istriane11 e a Efeso in Turchia12. Un dato d’interesse, già evidenziato in questo lavoro, è emerso dall’indagine sui materiali di Cattolica, ascrivibili a una fornace di greco-italiche adriatiche: le analisi al microscopio ottico hanno infatti messo in luce come la cd. chamotte sia in realtà il risultato di una miscela non omogenea di argille. Le indagini nel loro complesso hanno tuttavia evidenziato la difficoltà a caratterizzare gli impasti, individuando elementi discriminanti, e a circoscrivere le aree di produzione13, a causa della scarsa variabilità geologica e della genericità petrografica delle rocce e delle argille affioranti lungo il versante adriatico14, nonché di una sporadica definizione archeometrica delle produzioni (scarti e resti produttivi da fornaci identificate)15. Tale criticità è stata riscontrata anche nell’esame a occhio nudo dei reperti del Nuovo Mercato. Risultati rilevanti, peraltro in linea con questo studio sia per metodo che per esiti, emergono, come si vedrà nel prosieguo, dalle analisi chimiche condotte da un gruppo di lavoro che fa capo all’Università di Padova su un cospicuo numero di manufatti bollati rinvenuti in contesti di drenaggio dell’Italia nord-orientale16.
Protocollo e campioni: primo lotto
Ai fini di una caratterizzazione delle anfore adriatiche rinvenute al Nuovo Mercato, si è scelto dunque di inaugurare una rigorosa campagna di indagini archeometriche e sono state in un primo momento scelte, tra i contenitori rappresentati, tre serie bollate ben note, in merito alle quali risultavano essere state formulate in letteratura delle ipotesi di provenienza, con la speranza di agganciare il dato archeologico ed epigrafico a quello petrografico e chimico, in assenza di un sufficiente livello di definizione a livello macroscopico degli impasti:
- serie I, produzione dei Rubrii (vd. supra, pp. 145-153, 162-163, 196-199);
- serie II, B“AR”B”VL” // C.I“VL”.POLY (vd. supra, pp. 153-159, 211);
- serie III, THB (vd. supra, pp. 171-183).
Alla terza serie si sono inoltre aggregati alcuni reperti bollati che rappresentano ad oggi degli unica, ma che si era inizialmente supposto di poter associare alle testimonianze già attestate (cfr. supra, pp. 215-217). Si tratta dei marchi “THIB”R“IDI”S“ER”[, dapprincipio considerati una variante del più noto THB sul modello dei contenitori bollati L.C.S.RPHI e L.C.S.REV e pertanto trascritti “THB”R“DI”S“ER”[17.
Sono stati infine aggiunti a questo lotto di materiali due campioni diversi, prelevati da un contenitore a fondo piatto attribuito in via d’ipotesi a produzione adriatica (inv. 3473) e da una Dressel 6A frammentaria bollata da L. Tarius Rufus (inv. 2290; cfr. supra, pp. 204-206), che avrebbero potuto consentire di riscontrare eventuali differenze, a livello chimico-fisico e petrografico, con le tre serie principali, fornendo degli elementi di controprova.
I reperti prescelti sono stati campionati combinando diversi tipi di informazione, in modo tale che fossero:
- analizzati tutti i tipi di impasto osservati macroscopicamente per ciascuna serie;
- esaminati gli oggetti che offrissero la possibilità di effettuare delle considerazioni tipologiche (esemplari integri, esemplari che conservassero parti morfologicamente significative, soprattutto orli);
- rappresentate tutte le principali varianti di bolli attestate all’interno di una stessa serie o famiglia di anfore.
Il lavoro di esame macroscopico degli impasti del I lotto da destinare al campionamento è stato svolto con l’ausilio di Claudio Capelli (Università degli Studi di Genova) nel corso dell’inverno 2013-2014. Si noti che impasti ritenuti diversi su base macroscopica sono poi stati inseriti, in sede di analisi, negli stessi gruppi petrografici e viceversa.
I campioni sono stati consegnati con l’indicazione del solo numero di inventario e non distinti per serie. Il primo lotto di reperti campionati (n. 28) è stato sottoposto ad analisi petrografiche in microscopia ottica, ovvero allo stereomicroscopio e in sezione sottile al microscopio polarizzatore (Claudio Capelli) e ad analisi chimiche, in particolare delle terre rare (Filippo Saiano e Riccardo Scalenghe)18.
Sulla base dei risultati, si è deciso un supplemento di indagine, volto in particolare ad approfondire la problematica della serie I, che aveva evidenziato delle criticità. La serie è infatti l’unica di cui è stato concretamente individuato in area medio-adriatica il sito produttivo, ma che al contempo ha rivelato alle analisi petrografiche la presenza, considerata in prima istanza anomala, di elementi effusivi alcalino-potassici. Tali elementi si ritenevano piuttosto correlati alla detrizione del massiccio del Vulture in area meridionale19.
Protocollo e campioni: secondo lotto
Il secondo lotto di materiali analizzati ne ha quindi compresi alcuni recuperati a Marina di Città Sant’Angelo (PE), da cui si riteneva provenissero i reperti della serie I del Nuovo Mercato, essendovi stato rinvenuto un butto di fornace che aveva restituito i medesimi bolli su anfora20. Tale butto era ascrivibile a uno degli impianti produttivi gravitanti attorno all’approdo Ad Salinas, dovei contenitori recuperati (dalle greco-italiche tarde alle anfore a fondo piatto) sembrano per ora riferibili esclusivamente al trasporto del vino21.
Gentilmente concessi dall’allora Soprintendenza Archeologia per l’Abruzzo, a seguito di un accordo di collaborazione con il Centre Camille Jullian e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (oggi SSABAP), i materiali (Figg. 59; 5) sono stati scelti nel corso di un sopralluogo effettuato nel luglio 2014 con Marie Brigitte Carre, tenendo in conto gli elementi di seguito elencati:
- tipologie anforarie rappresentate negli atelier succitati, ovvero
- CSA 1) greco-italiche con piccolo bordo triangolare;
- CSA 2) Lamboglia 2 con orlo triangolare e anse ovali;
- CSA 3) Lamboglia 2/Dressel 6A con orlo a fascia poco differenziata dal collo e anse tonde;
- CSA 4) Dressel 6A con orlo a fascia, simile al Gruppo III del Nuovo Mercato Testaccio (cfr. supra, p. 127);
- CSA 5) fondo piatto (fondi con piede ad anello e orli con anse a nastro e attacco a sciarpa);
- attestazione di tappi, realizzati a tornio e a stampo;
- presenza di scarti di cottura;
- bolli attestati, ovvero produzioni dei
- Rubrii, cd. serie III del Nuovo Mercato Testaccio (a rilievo entro cartiglio rettangolare);
- servi di L. Malleolus, che convenzionalmente denomineremo serie IV (a rilievo entro cartiglio rettangolare);
- presenza di materiale laterizio.
Sulla base dei soli reperti controllati autopticamente22, non è stato possibile mettere in relazione i bolli recuperati con la morfologia generale dei contenitori e con quella degli orli in particolare, poiché i marchi rintracciati in magazzino risultavano apposti su reperti frammentari (anse). Tuttavia, sulla base dei confronti reperiti in letteratura23 e dei contenitori del Nuovo Mercato Testaccio sembra possibile ipotizzare che i bolli della serie di L. Malleolus si colleghino alle anfore del tipo Lamboglia 2/Dressel 6A (CSA 3) e quelli di Barbarus alle Dressel 6A (CSA 4, simili al Gruppo III del nostro contesto). Con riguardo alle prime, si noti che anfore con tali bolli, attribuite al tipo Lamboglia 2, sono già presenti nel relitto Planier 3 alla metà I sec. a.C. ca.24, mentre quelle della fornace di Marina di Città Sant’Angelo sono pubblicate come Dressel 6A25, trattandosi forse di esemplari di transizione26.
Per quanto concerne la seconda serie, non sono editi disegni di orli provenienti da Marina di Città Sant’Angelo cui si connetta il bollo BARBARI, ma le Dressel 6A pubblicate presentano orli a fascia verticale, per lo più assimilabili al Gruppo III del Nuovo Mercato Testaccio27. Anche il bollo PRIMIBAR, probabilmente della stessa serie, compare su un contenitore con orlo ad alta fascia e risalto superiore del labbro28.

Ai campioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici d’Abruzzo ne sono stati aggiunti altri del Nuovo Mercato Testaccio, che si è ritenuto opportuno caratterizzare per le ragioni di seguito individuate:
- inv. 4416, a marchio Q.NINNI/SECVNDI, per l’affinità morfologica con la serie dei Rubrii (NMT_AAD Orlo 15= Gruppo III, cfr. CSA 4) e per l’ipotesi di provenienza da area produttiva limitrofa alle figlinae succitate (vd. supra, pp. 188-189);
- inv. 1256, con bollo VOLC (vd. supra, p 208); per l’affinità morfologica con la serie dei Rubrii (NMT_AAD Orlo 15= Gruppo III, cfr. CSA 4);
- inv. 4403, con bollo [L]“AL”B“ID”“AM[AE”] (vd. supra, pp. 220-221), per l’attribuzione a tipologia e produzione radicalmente diversa (ovoidale brindisina);
- inv. 2285, bollo “ATEI”OY** (vd. supra, p. 224), per le caratteristiche problematiche del contenitore, attribuito in via meramente ipotetica a produzione brindisina.
I quindici reperti del secondo lotto sono stati sottoposti alle sole analisi petrografiche da parte di Claudio Capelli. Anche in questo caso i reperti sono stati consegnati con l’indicazione del numero di inventario, senza notazione alcuna su tipologia, epigrafia o provenienza.
La lista dei campioni scelti, con le caratteristiche dei contenitori, l’indicazione dell’impasto individuato su base macroscopica, le ipotesi formulate e le problematiche aperte, è contenuta nella Tabella “Elenco e caratteristiche dei campioni”.
| Inventario | Bollo | Tipo anfora | Descrizione | Impasto | Serie | Fig. |
| NMT 1213 US 275 | BARBARI // C“AD”MVS | Dressel 6A | Anfora mutila (orlo NMT gr. III) in situ | 4 | I | 35.2 |
| NMT 1404 US 760 | BARBARI | Dressel 6A | Anfora mutila in situ | 5 | I | 35.3 |
| NMT 3089 US 2710 | C“AD”MVS | Dressel 6A | Ansa | 4 | I | 36.11 |
| NMT 3093 US 1851 | RVBRI | Dressel 6A | Ansa | 4 | I | 36.13 |
| NMT 3097 US 722 | []CC.AVG*.II** / R*VBRIAE.PF.F. // “HD” | Dressel 6A | Collo con anse e orlo (NMT gr. III) | 4 | I | 36.2 |
| NMT 3098 US 2535 | BARBARI | Dressel 6A | Orlo (NMT gr. III) con attacco d’ansa | 5 | I | 36.1 |
| NMT 2276 US 437 | B*“AR”B“V[L]” | Dressel 2-4 | Orlo con attacco delle anse | 30 | II | 50.1 |
| NMT 2626 US 245 | B“AR”B“V*L*” // C.“IVL”.POLY* | Dressel 6A | Collo con attacco d’ ansa | 13 | II | 39.3 |
| NMT 3100 US 4126 | [C.I]“V*[L”].POLY | Dressel 2-4 | Anfora integra (rubata), restano il collo e un frammento d’ansa | 12 | II | 50.2 |
| NMT 3101 US 452 | [B]“AR”B“VL” // C.I“VL”.POL[Y] | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse | 13 | II | 38.3 |
| NMT 3102 US 3215 | [B]“A*R”B“VL*” | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse e orlo (NMT gr. I, orlo 25) | 13 | II | 37.1 |
| NMT 3103 US 957 | B*“AR”B“V[L”] | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse e orlo (NMT gr. I, orlo 25) | 1 | II | 37.2 |
| NMT 3104 US 452 | a: [B“A]R”B[“VL”]//C.I“V[L]”PO[LY] b: [B]“AR”B“V[L”] | Dressel 6A | Collo con attacco d’ansa e orlo (NMT gr. I, orlo 25) | 13 | II | 37.3 |
| NMT 3224 US 2486 | [B]“A*R”B“V[L”] | Dressel 6A | Collo con attacco d’ansa e orlo (NMT gr. I, orlo 25) | 13 | II | 38.1 |
| NMT 1407 US 760 | T.H[.B] | Dressel 6A | Anfora mutila in situ | 2 | II | 58.1 |
| NMT 2255 US 631 | T*HB | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse e orlo (NMT_gr. II) | 2 | III | 41.4 |
| NMT 2267 US 563 | T*.H.B | Dressel 6A | Orlo (NMT_gr. II) con attacco d’ansa estremamente frammentario | 4 | III | 41.6 |
| NMT 2284 US 481 | T.H[.B] | Dressel 6A | Parete | 14 | III | 58.2 |
| NMT 2291 US 562 | T.H.B | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse e orlo (NMT_ gr. II) | 14 | III | 43.1 |
| NMT 2627 US 220 | THB | Dressel 6A | Parete | 4 | III | 58.3 |
| NMT 2637 US 220 | THB | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. I) | 4 | III | 41.1 |
| NMT 2652 US 797 | TH[B]** | Dressel 6A | Spalla con attacco d’ansa | 14 | III | 58.4 |
| NMT 3119 US 294 | T.H.B | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. II) con ansa | 2 | III | 45.2 |
| NMT 3403 US 366 | [T]HB | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. I) | 6 | III | 41.2 |
| NMT 2632 US 354 | “T*HIB”R“IDI”S*[ | Dressel 2-4 | Parete | 19 | III? | 51.5 |
| NMT 3115 US 3228 | “THIB”RI“I[D]I”[ | Dressel 2-4 | Spalla con attacco d’ansa | 19 | III? | 51.4 |
| NMT 1256 US 386 | VOLC | Dressel 6A | Anfora mutila della parte inferiore (orlo NMT, gr. III) | 2 | 49 | |
| NMT 2285 US 614 | “ATEI”OY** | Ov. brind.? | Ansa | __ | 52.5 | |
| NMT 2290 US 523 | L.TARI | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. II) con attacco d’ansa | 1 | 48.4 | |
| NMT 3473 US 563 | Fondo piatto | Anfora mutila, metà inferiore (fondo 3) | 35 | 29.1 | ||
| NMT 4416 US 2676 | Q.NINNI/SECVNDI | Dressel 6A | Collo con orlo (NMT, gr. III) e attacchi delle anse | 2 | 40.10 | |
| NMT 4403 US 6012 | [L]“AL”B“ID”“AM[AE”] | Ov. br. | Orlo 26 con anse | 38 | 52.1 | |
| CSA – AG – A229 | Greco-ital. tarda | Orlo (CSA 1) con attacco d’ansa estremamente frammemtario | 59.1 | |||
| CSA – 197549 | Lamboglia 2 | Orlo (CSA 2) con due attacchi d’ansa | 59.1 | |||
| CSA – 197526 | BOISCVS/M“AL”LEOLILSH | Lamb. 2/Dressel 6A? | Ansa (associabile ad orlo CSA 3?) | IV | 59.2 | |
| CSA – 197527 | ARTHEM[/M“AL”EOLIL*SH* | Lamb. 2/Dressel 6A? | Ansa (associabile ad orlo CSA 3?) | IV | 59.2 | |
| CSA – 197490 | Lamb. 2/ Dressel 6A? | Orlo (CSA 3) con attacco d’ansa, probabile scarto | 59.2 | |||
| CSA – US 25 | B*ARBA[R]I* | Dressel 6A | Ansa (associabile a orlo CSA 4 = NMT, gr. III?) | I | 59.3 | |
| CSA – US 28, fr. 7 | Dressel 6A | Orlo (CSA 4 = NMT, gr. III) | 59.3 | |||
| CSA – US 28, fr. 9 | Fondo piatto | Frammento di orlo con attacco di ansa a nastro (CSA 5?) | 59.4; 5.1 | |||
| CSA – US 54, fr. 1 | Fondo piatto | Fondo con piede ad anello ad anello (CSA 5), mal cotto | 59.4; 5.2 | |||
| CSA – US 25 | TECLADES | Tegola | 59.5 | |||
| CSA – 197572 | Tappo | Probabilmente fatto al tornio con presa centrale | 59.5 |
Risultati delle indagini petrografiche
I risultati delle indagini archeometriche, in particolare di quelle petrografiche che hanno riguardato la totalità dei campioni (vd. Appendice 2 a firma di Claudio Capelli, con Roberto Cabella e Michele Piazza)30, sono presentati nella Tabella Risultati petrografia e discussi qui sotto, confrontandoli, ove possibile, con le risultanze delle analisi chimiche. La numerazione dei gruppi non è sequenziale, ma è il frutto della rilavorazione dei dati archeometrici sulla base di quelli tipologici ed epigrafici.
Lo studio in sezione sottile non ha rivelato differenze particolari tra gli impasti, per lo più caratterizzati da una matrice principalmente carbonatica e da inclusioni fini e generiche. Tuttavia, guardando ad alcune caratteristiche secondarie e tenendo conto dei dati epigrafici e tipologici, è stato possibile individuare sette gruppi e sei campioni isolati (anch’essi indicati per comodità quali “gruppi”), spesso correlabili ad atelier, centri o regioni di produzione differenti (anche se per lo più non localizzabili precisamente)31.
Il gruppo 1 è ben caratterizzato dal punto di vista petrografico e, limitatamente al primo lotto di campioni consegnati, anche sotto il profilo mineralogico e chimico32. Elemento caratterizzante dal punto di vista petrografico è la presenza, sebbene accessoria, di inclusi derivati da rocce effusive alcalino-potassiche, rappresentati in genere negli impasti di produzioni anforiche dell’Adriatico meridionale, in quanto derivati dall’alterazione e dal trasporto nelle argille costiere del materiale del complesso vulcanico del Vulture. Un’analisi più approfondita della bibliografia geologica, tuttavia, ha rivelato in alcune sequenze stratigrafiche appenniniche della ragione pescarese livelli ricchi in elementi vulcanici correlabili ai complessi effusivi dell’Italia tirrenica33.
Il gruppo raccoglie un nucleo di materiali chiaramente definiti:
- tutte le anfore Dressel 6A della serie I (figlinae dei Rubrii) dal Nuovo Mercato;
- alcuni reperti dall’area produttiva di Marina di Città Sant’Angelo (PE), sia iscritti che anepigrafi.
L’archeometria ha in tal caso confermato l’ipotesi di provenienza che era stata formulata per i materiali del Nuovo Mercato e concorso alla definizione di un gruppo ben caratterizzato anche dal punto di vista della morfologia e dei bolli.
Nel gruppo 1 sono presenti inoltre due campioni di Dressel 2-4 bollate (invv. 2632, 3115) che, come si è visto, erano stati inizialmente inseriti in via d’ipotesi nella serie III, con i frammenti bollati THB, ma sono probabilmente da stralciare, poiché sia l’aspetto archeometrico che quello tipologico li distinguono nettamente dai contenitori con tale marchio. Il dato conferma l’opportunità di una nuova proposta di lettura per il bollo: Thibridis Er[. Benché le analisi abbiano riguardato due dei quattro reperti che presentano il medesimo marchio, le caratteristiche macroscopiche dei frammenti e degli impasti fanno propendere per l’omogeneità della serie, che in questa sede si intende separare nettamente dalla III; la si indica pertanto come V, rimarcandone invece il rapporto con le serie I (bolli dei Rubrii) e IV (bolli di L. Malleolus), messo in luce dalla petrografia.
Il gruppo 2 è rappresentato prevalentemente da reperti dell’area produttiva di Marina di Città Sant’Angelo (PE), cui si associa un’anfora Dressel 6A rinvenuta al Nuovo Mercato Testaccio, recante il bollo Q.NINNI / SECVNDI (inv. 4416), per la quale si era in precedenza rilevata una similarità morfologica alla serie dei Rubrii (NMT_AAD Orlo 15= Gruppo III, cfr. CSA 4), prodotta come si è visto a Marina di Città Sant’Angelo. Per i contenitori con tale marchio, inoltre, la letteratura archeologica aveva già formulato l’ipotesi di provenienza da una zona prossima alle fornaci in esame. Sebbene più generico del precedente da punto di vista petrografico, anche questo gruppo sembra dunque individuare la produzione picena meridionale localizzabile intorno al Saline.
I gruppi 3 e 4, parzialmente confrontabili, contengono le anfore Dressel 6A bollate THB, ovvero la serie III del Nuovo Mercato. Attribuiti su base petrografica ad area adriatica indeterminata, forse centrale, verso cui indirizzano anche le analisi chimiche34, i reperti indagati non contraddicono l’ipotesi di un’origine da Cupra Marittima e infirmano le pur prudenti congetture di una provenienza meridionale, formulate in letteratura per alcuni contenitori della serie.
Non è stato possibile rintracciare alcuna ulteriore correlazione tra gruppo petrografico, configurazione morfologica dell’anfora – a livello di dettaglio dell’orlo – e bollo, ovvero collegare le differenze petrografiche a specificità tecniche o epigrafiche, mentre d’altra parte è possibile che tali differenze dipendano da diverse condizioni di cottura subite da impasti in origine ancor più simili.
Il gruppo 5 associa due reperti apparentemente eterogenei, ovvero l’orlo di un contenitore a fondo piatto prodotto a Marina di Città Sant’Angelo (AAD – US 28, fr. 9) e un’anfora Dressel 6A con bollo VOLC (inv. 1256). Tale contenitore tuttavia è morfologicamente simile, anche se non propriamente identico, alle anfore dei Rubrii e di Q. Ninnius Secundus (Dressel 6A: NMT_AAD Orlo 15= Gruppo III, cfr. CSA 4), comprese nei gruppi petrografici 1 e 2, dove figurano tutti gli altri contenitori di Marina di Città Sant’Angelo. Anche il raggruppamento in esame, pertanto, presenta tratti di coerenza interna non solo su base petrografica, ma altresì archeologica, sebbene i dati morfologici ed epigrafici necessitino ancora di ponderazione. Esso inoltre si avvicina dal punto di vista archeometrico ai gruppi 3 e 4 da cui differisce soprattutto per le dimensioni inferiori delle inclusioni.
Nei gruppi 6, 7 e 8 sono rappresentate le anfore a marchio B“AR”B“VL” // C.I“VL”.POLY (serie II del Nuovo Mercato Testaccio, contenitori risultati omogenei anche dal punto di vista del dato mineralogico e chimico35. Tipologicamente si tratta sia di Dressel 6A (riconducibili – ove possibile – ad un’unica forma NMT_AAD Orlo 25), che di Dressel 2-4. Questi ultimi contenitori sono stati campionati nel numero di 2: l’inv. 2276 è associato alle Dressel 6A nel gruppo 6, mentre l’inv. 3100 è isolato e costituisce da solo il gruppo 8. La serie è stata oggetto di una puntuale ipotesi di provenienza dal Piceno, in particolare dall’agro di Fermo, al momento non contraddetta dalla ricerca archeometrica36.
Sono isolati i reperti che costituiscono i seguenti gruppi:
- gruppo 9, costituito dall’anfora bollata L.TARI (inv. 2290), che, distaccandosi dalle altre dal punto di vista petrografico, è comunque attribuibile ad area adriatica e ascrivibile, sebbene con un pattern distinguibile, anche sulla base delle analisi chimiche al Piceno, coerentemente con le ipotesi archeologiche sulla provenienza37;
- gruppo 10, rappresentato da una tegola bollata rinvenuta a Marina di Città Sant’Angelo, il cui impasto carbonatico, fine e con scarse inclusioni generiche (<0.1 mm), risulta isolato da quello delle anfore, ma confrontabile con altri manufatti medio-adriatici, e la cui produzione resta pertanto al momento ipotetica nell’ambito degli impianti Ad Salinas;
- gruppo 11, costituito da un contenitore ovoidale brindisino (inv. 4403) di forma Apani III = Giancola 6, attribuibile alla produzione di La Rosa per corredo epigrafico;
- gruppo 12, rappresentato da un’anfora a fondo piatto indeterminata (inv. 3473) che, compatibile dal punto di vista petrografico sia con una produzione adriatica settentrionale che con una produzione gallica38, presenta le stesse incertezze su base morfologica, mentre le analisi chimiche, sebbene con un pattern distinguibile, associano il reperto ad altri delle serie I, di produzione medio-adriatica, e III.
È da escludere infine dal novero delle adriatiche l’anfora inv. 2285 (gruppo 13) a marchio “ATEI”OY**, per la quale era stata formulata l’ipotesi di provenienza dalla zona adriatico-meridionale (brindisina) sia su base epigrafica che morfologica, registrando tuttavia una totale anomalia dell’impasto, riscontrata anche dalle analisi petrografiche. Tali peculiarità inducono all’attribuzione del reperto ad un’area produttiva non adriatica, probabilmente orientale, come indiziato tra l’altro dall’uso dell’alfabeto greco.
Riflessioni metodologiche e conclusioni
L’archeometria, fondata su un rigoroso protocollo, pare dunque aver concorso sinora alla chiara individuazione di alcune problematiche e di possibili scenari di soluzione. Per molto tempo l’assenza di campioni provenienti da fornaci di anfore adriatiche ha impedito il riferimento a gruppi di materiali di origine certa; inoltre i dati finora pubblicati in diversi lavori mancano per lo più di un confronto e di una valutazione dei risultati nel loro insieme. Va ribadito che un serio programma di analisi petrografiche e/o chimiche non può prescindere dalla creazione di consistenti gruppi di riferimento la cui omogeneità sia determinata o dalla provenienza dalla stessa fornace o dall’uniformità epigrafica, come dimostra anche l’esperienza dell’Università di Padova, i cui risultati, oltre che il metodo, sono in piena consonanza con quelli della presente ricerca39; indispensabile è poi la stretta collaborazione tra archeologi e archeometri, per evitare di partire da presupposti errati su tipologie e provenienze.
In questo caso la collaborazione instaurata con Claudio Capelli ha consentito di:
- confermare alcune puntuali ipotesi di provenienza di reperti bollati (serie I) o, in altri casi (serie II e III), non contraddire l’ipotesi di una provenienza picena;
- supportare una nuova lettura per la serie “THIB”R“IDI”S[, identificata come autonoma produzione bollata di Dressel 2-4 (serie V) rispetto ai reperti a marchio THB (serie III);
- condurre osservazioni morfologiche che potrebbero consentire l’individuazione di una produzione picena meridionale, sulla scorta della caratterizzazione petrografica ed epigrafica.
Con riferimento all’ultimo punto, ad esempio, per le Dressel 6A è stato possibile identificare un dettaglio morfologico, ovvero l’orlo a fascia con caratterizzazione del bordo (Gruppo III del Nuovo Mercato = CSA 4), ricorrente in tali produzioni (cfr. Gruppi petro 1-2-5). Tale dettaglio, più o meno evidente, è comunque indicativo di un gesto tecnico ed è stato verificato, per quanto concerne i contenitori bollati da P. Rubrius Barbarus, anche nelle collezioni del Mercati di Traiano. Accanto a tali aspetti di tradizione, si segnala la consuetudine della bollatura a rilievo entro cartiglio rettangolare che, sulla base delle testimonianze materiali sinora raccolte, sembra propria, ancorché non esclusiva, della familia Barbari per tutte le fasi di attività sino a Rubria.
Un’ipotesi di lavoro può vertere per il futuro sulla caratterizzazione di altre produzioni (evidenziazione delle caratteristiche composizionali, tecniche, tipologiche ed epigrafiche distintive), sempre chiaramente individuabili geograficamente o epigraficamente, oltre che sulla ricerca dei prodotti delle fabbriche di Marina di Città Sant’Angelo nei siti di consumo al fine di valutarne la distribuzione e l’impatto commerciale.
| Inventario | Bollo | Tipo anfora | Morfologia | Serie | Gruppo petro | Fig. |
| NMT 1213 US 275 | BARBARI // C“AD”MVS | Dressel 6A | Anfora mutila (orlo NMT, gr. III) in situ | I | 1 | 35.2 |
| NMT 1404 US 760 | BARBARI | Dressel 6A | Anfora mutila in situ | I | 1 | 35.3 |
| NMT 3089 US 2710 | C“AD”MVS | Dressel 6A | Ansa | I | 1 | 36.11 |
| NMT 3093 US 1851 | RVBRI | Dressel 6A | Ansa | I | 1 | 36.13 |
| NMT 3097 US 722 | []CC.AVG*.II** / R*VBRIAE.PF.F. // “HD” | Dressel 6A | Collo con anse e orlo (NMT, gr. III) | I | 1 | 36.2 |
| NMT 3098 US 2535 | BARBARI | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. III) con attacco d’ansa | I | 1 | 36.1 |
| NMT 2632 US 354 | “T*HIB”R“IDI”S*[ | Dressel 2-4 | Parete | V? | 1 | 51.5 |
| NMT 3115 US 3228 | “THIB”R“I[D]I”[ | Dressel 2-4 | Spalla con attacco d’ansa | V? | 1 | 51.4 |
| CSA – AG – A2 | Greco-ital. tarda | Orlo (CSA 1) con attacco d’ansa estremamente frammemtario | 1 | 59.1 | ||
| CSA – 197549 | Lamboglia 2 | Orlo (CSA 2) con attacchi delle anse | 1 | 59.1 | ||
| CSA – 197527 | ARTHEM[ / M“AL”EOLIL*SH* | Lamb. 2/Dressel 6A? | Ansa (associabile ad orlo CSA 3?) | IV | 1 | 59.2 |
| CSA – US 25 | B*ARBA[R]I* | Dressel 6A | Ansa (associabile a orlo CSA 4 = NMT, gr. III?) | I | 1 | 59.3 |
| CSA – US 28, fr. 7 | Dressel 6A | Orlo (CSA 4 = NMT, gr. III) | 1 | 59.3 | ||
| CSA – 197572 | Tappo | Probabilmente fatto al tornio, con presa centrale | 1 | 59.5 | ||
| CSA – 197490 | Lamb. 2/Dressel 6A? | Orlo (CSA 3) con attacco d’ansa, probabile scarto | 2 | 59.2 | ||
| CSA – US 54, fr. 1 | Fondo piatto | Fondo con piede ad anello (CSA 5), mal cotto | 2 | 59.4; 5.2 | ||
| CSA – 197526 | BOISCVS/M“AL”LEOLILSH | Lamb. 2/Dressel 6A? | Ansa (associabile ad orlo CSA 3?) | IV | 2 | 59.2 |
| NMT 4416 US 2676 | Q.NINNI/SECVNDI | Dressel 6A | Collo con orlo (NMT, gr. III) e attacchi delle anse | 2 | 40.10 | |
| NMT 2267 US 563 | T*.H.B | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. II) con attacco d’ansa estremamente frammentario | III | 3 | 41.6 |
| NMT 2284 US 481 | T.H[.B] | Dressel 6A | Parete | III | 3 | 58.2 |
| NMT 2291 US 562 | T.H.B | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse e orlo (NMT, gr. II) | III | 3 | 43.1 |
| NMT 2627 US 220 | THB | Dressel 6A | Parete | III | 3 | 58.3 |
| NMT 3403 US 366 | [T]HB | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. I) | III | 3 | 41.2 |
| NMT 1407 US 760 | T.H[.B] | Dressel 6A | Anfora mutila in situ | II | 4 | 58.1 |
| NMT 2255 US 631 | T*HB | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse e orlo (NMT, gr. II) | III | 4 | 41.4 |
| NMT 2637 US 220 | THB | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. I) | III | 4 | 41.1 |
| NMT 2652 US 797 | TH[B]** | Dressel 6A | Spalla con attacco d’ansa | III | 4 | 58.4 |
| NMT 3119 US 294 | T.H.B | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. II) con ansa | III | 4 | 45.2 |
| CSA – US 28, fr. 9 | Fondo piatto | Frammento di orlo con attacco di ansa a nastro (CSA 5) | 5 | 59.4; 5.2 | ||
| NMT 1256 US 386 | VOLC | Dressel 6A | Anfora mutila della parte inferiore (orlo NMT, gr. III)) | 5 | 49 | |
| NMT 2276 US 437 | B*“AR”B“V[L]” | Dressel 2-4 | Orlo con attacco delle anse | II | 6 | 50.1 |
| NMT 2626 US 245 | B“AR”B“V*L*” // C.“IVL”.POLY* | Dressel 6A | Collo con attacco d’ ansa | II | 6 | 39.3 |
| NMT 3101 US 452 | [B]“AR”B“VL” // C.I“VL”.POL[Y] | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse | II | 6 | 38.3 |
| NMT 3102 US 3215 | [B]“A*R”B“VL*” | Dressel 6A | Collo con attacco delle anse e orlo ((NMT, gr. I, orlo 25) | II | 6 | 37.1 |
| NMT 3104 US 452 | a: [B“A]R”B[“VL”] // C.I“V[L]”PO[LY] b: [B]“AR”B“V[L”] | Dressel 6A | Collo con attacco d’ansa e orlo (NMT, gr. I, orlo 25) | II | 6 | 37.3 |
| NMT 3103 US 957 | B*“AR”B“V[L”] | Dressel 6A | Collo con attacco dele anse e orlo (NMT, gr. I, orlo 25) | II | 7 | 37.2 |
| NMT 3224 US 2486 | [B]“A*R”B“V[L”] | Dressel 6A | Collo con attacco d’ansa e orlo (NMT, gr. I, orlo 25) | II | 7 | 38.1 |
| NMT 3100 US 4126 | [C.I]“V*[L”].POLY | Dressel 2-4 | Anfora integra (rubata), restano il collo e un frammento d’ansa | II | 8 | 50.2 |
| NMT 2290 US 523 | L.TARI | Dressel 6A | Orlo (NMT, gr. II) con attacco d’ansa | 9 | 48.4 | |
| CSA – US 25 | TECLADES | Tegola | 10 | 59.5 | ||
| NMT 4403 US 6012 | [L]“AL”B“ID”“AM[AE”] | Ov. br. | NMT, orlo 26 con anse | 11 | 52.1 | |
| NMT 3473 US 563 | – | Fondo piatto | Anfora mutila, metà inferiore (F. 3) | 12 | 29.1 | |
| NMT 2285 US 614 | “ATEI”OY** | Orientale | Ansa | 13 | 52.5 |
Notes
- Appendice di B. D’Ambrosio e S. Sfrecola a Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 91-93.
- Ventura & Capelli 2017, pp. 127-143.
- Bruno 1995, pp. 83-118 (con la collaborazione di S. Sfrecola).
- Mazzoli et al. 2009, pp. 239-255; Maritan et al. 2019, pp. 203-210; Cipriano et al. 2020, pp. 103-120.
- Esquilini 2011, pp. 224-230.
- Esquilini 2008, pp. 183-188.
- Esquilini 2014, pp. 587-594 (analisi petrografiche, mineralogiche e chimiche).
- Menchelli et al. 2008, pp. 379-392.
- Patterson 2012, pp. 386-388 (Giancola e Marmorelle).
- Sondi & Slovenec 2003, pp. 251-263; cfr. Mise & Quinn 2022, 225. In quest’ultimo contributo si parte da una trama indiziaria relativa alla produzione anforaria di greco-italiche e Lamboglia 2 presso Issa nell’Adriatico orientale e si tende a confermarla sulla base dei dati delle analisi chimiche e petrografiche su campioni di provenienza eterogenea.
- Machut et al. 2020, pp. 39-56; Szakmány et al. 2020, pp. 79-102.
- Bezeczky 2013, pp. 115–123; González Cesteros & Sauer 2020, pp. 110-111, 126 A37. Le analisi petrografiche evidenziano sia la presenza di Lamboglia 2 brindisine, affini a materiali di La Rosa, che di Dressel 6A prodotte tra Veneto ed Emilia Romagna.
- Esquilini 2014, p. 589.
- Cabella et al. 2008, pp. 374-375.
- Proprio la genericità degli impasti ha dato luogo a fraintendimenti e mistificazioni, volte ad accreditare un’origine del tipo Lamboglia 2 in Dalmazia, richiamando, tra l’altro, alcune ricerche archeometriche relative a recuperi effettuati lungo la costa croata. I risultati di tali analisi – di per sé quanto meno non risolutivi, come sottolineato in letteratura (Carre et al. 2014, pp. 425-426), per il presupposto da cui partono (origine apula delle Lamboglia 2) e per la scelta dei materiali (reperti di archeologia subacquea) – proprio facendo appello alla somiglianza degli impasti, sono stati estesi all’intero tipo da un numero limitato di campioni (Lindhagen 2009, pp. 86-88), per i quali, eliminata l’ipotesi della provenienza dall’Italia meridionale, l’archeometria si limitava a non escludere un’origine dalmata, in assenza di dati di conforto provenienti da eventuali fornaci di anfore sul territorio. Si vedano anche le motivazioni di ordine storico contrarie alla tesi di Lindhagen, presentate in Mongardi 2018, pp. 58-59.
- Maritan et al. 2019, pp. 203-210; Cipriano et al. 2020, pp. 103-120.
- D’Alessandro 2011, p. 614.
- Saiano et al. 2019, pp. 760-767. Le analisi hanno avuto in prima istanza lo scopo di restringere o escludere ipotesi di lavoro sulla provenienza dei campioni analizzati. Le indagini sono state poi pubblicate senza il conforto di una lettura archeologica dei dati.
- Menchelli et al. 2008, pp. 386-387; cfr. il contributo di B. D’Ambrosio e S. Sfrecola, in appendice a Brecciaroli Taborelli 1984, pp. 92-93.
- Marina di Città Sant’Angelo, via Salara (Staffa 2003, pp. 119-129; Staffa 2008, pp. 143-148).
- D’Alessandro et al. in corso di stampa.
- Circa 25 oggetti, corrispondenti a una cassetta di reperti notevoli preliminarmente selezionati dai collaboratori della Soprintendenza su un nucleo di 800 cassette ca. Si precisa che alcuni materiali già pubblicati in Staffa 2003, pp. 119-129 non sono stati individuati e visionati nel corso del sopralluogo, probabilmente perché sistemati in altri depositi sul territorio.
- Branger 2011-2012, pp. 41-51, 181-192, figg. 27-28 (Planier 3); Staffa 2003, pp. 119-129 (atelier).
- Panella 1998, pp. 548-549; cfr. Branger 2011-2012; per la problematica relativa ai bolli dei Publicii vd. supra, pp. 22-23.
- Staffa 2003, p. 127, fig. 8.
- Carre et al. 2014, p. 422, nt. 19.
- Staffa 2003, p. 120, fig. 3.
- Staffa 2003, p. 127, fig. 8.
- Il contenitore campionato proviene da Marina di Città Sant’Angelo, via Lungo Fino, proprietà Società Avantgarde, dove è stato rinvenuto un butto di anfore greco-italiche tarde, prossimo a livelli di terreno nerastro, contenenti numerosi inclusi di carbone e caratterizzati anche dalla presenza di terra rossa con scarti di lavorazione, con ogni evidenza collegabili alla presenza nella zona di una fornace non individuata (Staffa 2008, pp. 148-150).
- Si coglie qui l’occasione per ringraziare Claudio Capelli per la cortesia, la disponibilità al confronto e la professionalità sempre dimostrate.
- La descrizione puntuale dei gruppi si trova nell’Appendice 2.
- Saiano et al. 2019, pp. 762-764.
- Dati e bibliografia in Appendice 2.
- Saiano et al. 2019, p. 762. Cfr. Maritan et al. 2019, p. 207 per analisi condotte su reperti da altri siti.
- Saiano et al. 2019, p. 762.
- Cfr. Maritan et al. 2019, p. 207 per le analisi condotte su campioni da altri contesti.
- Saiano et al. 2019, p. 762. Cfr. anche Maritan et al. 2019, p. 207 per le indagini su materiali da altri siti.
- Si noti che, mentre sono da escludere sia l’Adriatico meridionale che centrale per la provenienza dell’anfora, la petrografia suggerisce una compatibilità con un’origine dalla Sicilia nord-orientale, dall’Egeo, dalla Provenza e dall’Adriatico settentrionale. In considerazione dell’aspetto macroscopico e delle caratteristiche morfologiche del contenitore si sono limitate agli due ultimi casi le ipotesi di provenienza.
- Maritan et al. 2019, pp. 203-210.