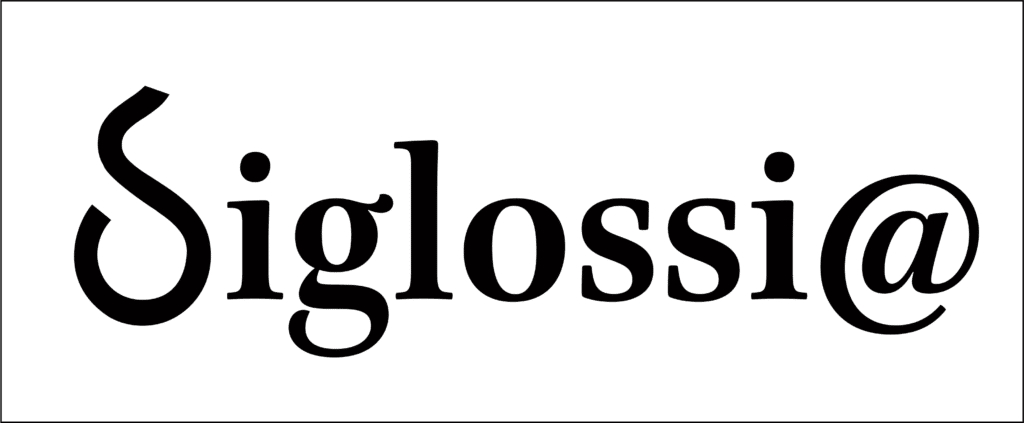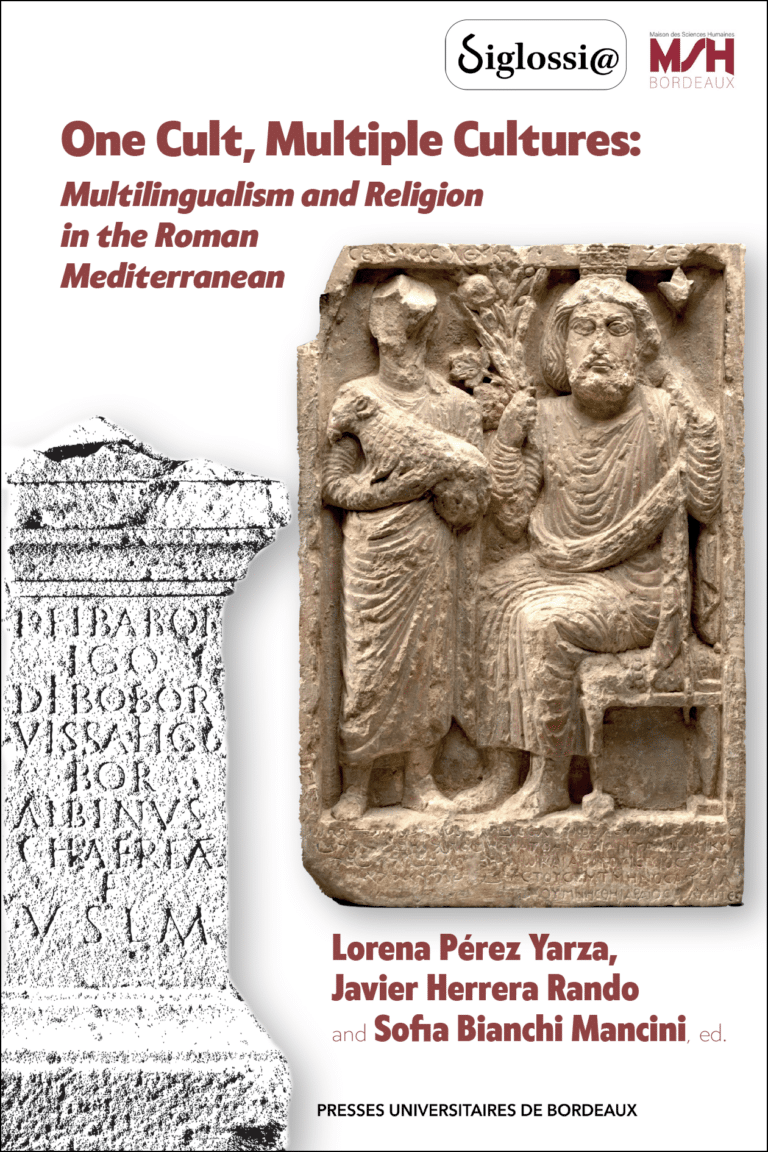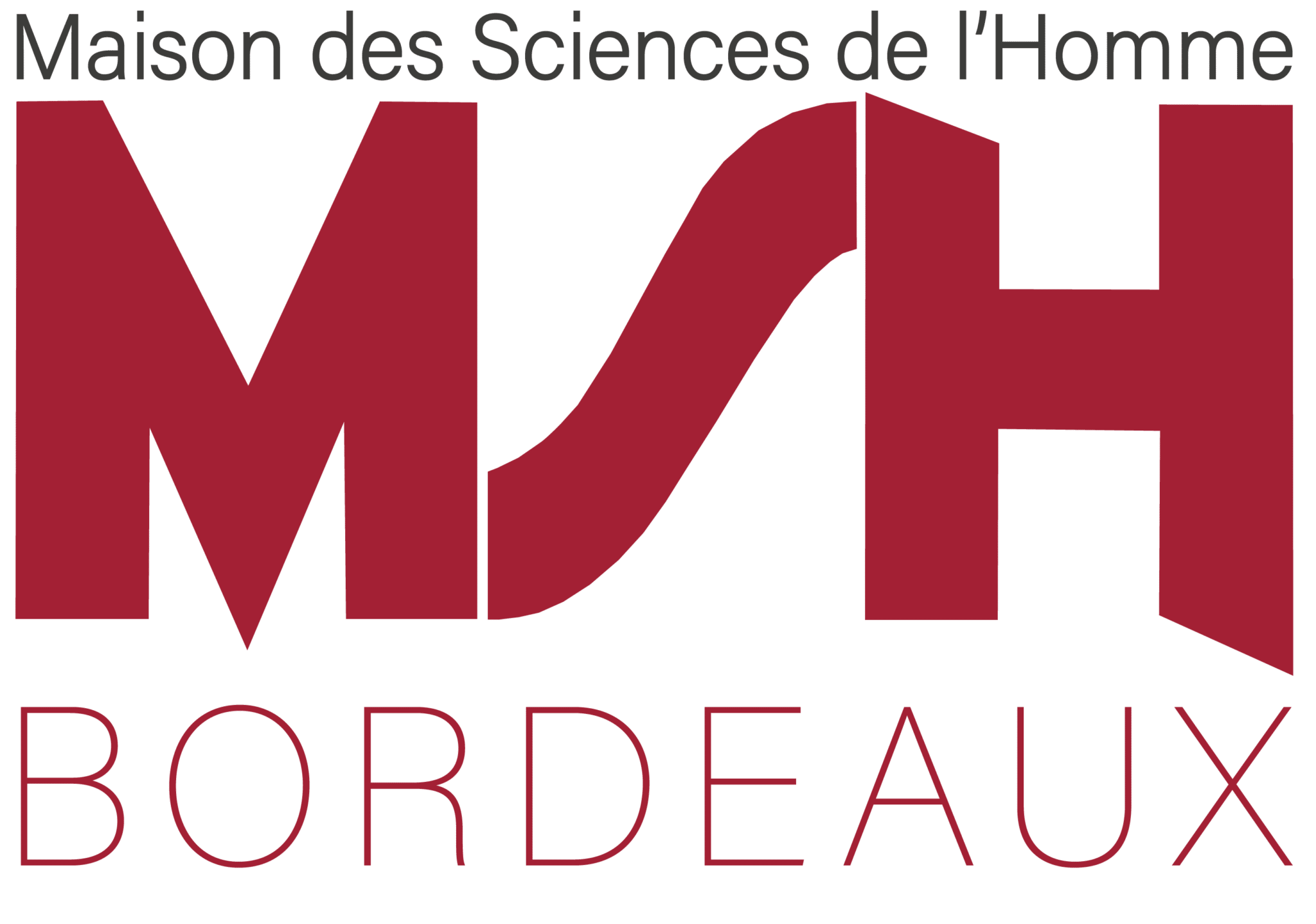Introduzione: il “mondo possibile” della traduzione dei nomi divini
La frase che stiamo considerando è un testo, e per capire un testo – e a maggior ragione per tradurlo – bisogna fare una ipotesi sul mondo possibile che esso rappresenta. Questo significa che, in mancanza di tracce adeguate, una traduzione deve appoggiarsi su congetture, e solo dopo avere elaborato una congettura che appaia plausibile il traduttore può procedere a volgere il testo da una lingua all’altra. Vale a dire che, dato l’intero spettro del contenuto messo a disposizione da una voce di dizionario (più una ragionevole informazione enciclopedica), il traduttore deve scegliere l’accezione o il senso più probabile e ragionevole e rilevante in quel contesto e in quel mondo possibile.1
Secondo U. Eco (in Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione), ogni traduzione apre a “mondi possibili”, poiché da parte del traduttore esiste uno sforzo di comprensione, esercizio di conoscenze e congetture circa l’altra lingua che aprono la pista, a ipotesi sulla cultura, o sul pensiero, dell’altro. Insomma, la traduzione è un’attività sperimentale e congetturale per U. Eco. Questa nozione di mondo possibile si avvicina alla descrizione che della traduzione dà M. Bettini in Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica (2012). Si serve della definizione di belief ascriptions, presa in prestito da T. Jones, e con essa intende: “l’attribuzione di pensieri, intenzioni, sentimenti e così via, a un interlocutore che parla una lingua straniera o a un testo scritto in un’altra lingua”2. Stando alle riflessioni moderne sull’atto traduttivo, già nel mondo antico tradurre un testo scritto significa congetturare circa i saperi dell’altro, in campo religioso, diremmo circa le pratiche e le teologie in relazione a uno o più culti3.
Il concetto di belief ascription/mondo possibile si applica bene anche ai testi epigrafici bilingui del mondo antico, di cui tratteremo nel presente articolo. In contesti multiculturali e polilinguistici, come quello vicino orientale, da cui prende le mosse il presente articolo, il testo bilingue nasce dalla commistione culturale, dal bisogno/volontà da parte degli agenti umani di esprimere gli stessi o più concetti in lingue diverse per esigenze di natura diverse. Talvolta, infatti, i testi bilingui non rilevano necessariamente da culture diverse, ma da contesti in cui l’uso di più di una lingua si è affermato e consolidato nel tempo, tanto che i confini tra le culture sottese a ciascuna lingua si perdono. Insomma, ciò che è linguisticamente diverso può non esserlo culturalmente, o almeno non del tutto. La storia del Vicino Oriente antico, per esempio, dalla conquista di Alessandro alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, ci racconta di esperienze di appropriazione, di commistione, di confronto tra culture.
Il caso di Dura-Europos, città di fondazione greca ai confini tra Impero Romano e Impero partico, è illuminante sotto questo aspetto. Quella di epoca romana, infatti, è una Dura-Europos dalle molteplici influenze, tenute insieme dal filo dell’identità locale, l’identità “europea”, così definita nelle fonti epigrafiche dal nome della fondazione di età ellenistica della città, Europos. Per esempio, un testo bilingue greco-aramaico, realizzato da un parlante aramaico, ci dice che nella versione greca si ricerchino, da parte dell’agente, concetti “greci”? Per rispondere a questa domanda ci serviremo dunque dei testi bilingui e li studieremo appoggiandoci su due aspetti, i nomi divini, da un lato, e i supporti visivi e materiali, dall’altro, che ci accompagneranno lungo il percorso, poiché aggiungono qualcosa di volta in volta allo studio del fenomeno del bilinguismo e, più in generale, alle pratiche religiose politeiste del mondo antico. Le parole scelte, la composizione delle frasi, la discrepanza tra due (o più) versioni di un testo, la scelta del supporto materiale, la rappresentazione grafica, sono particolarmente sensibili ai contesti culturali, all’interno dei quali si trasformano e, talvolta, si integrano. Lo studio dei nomi divini, in particolare, permette di approfondire le conoscenze che le società antiche stesse condividevano quando concepivano, modificavano, o perpetuavano “passivamente” il nome di una divinità nel corso del tempo4. La maniera in cui un dio è qualificato, se Salvatore, Misericordioso, Signore, o in altro modo, è per noi una chiave d’accesso alla comprensione che coloro che si servivano di ciascun nome avevano di quel “sistema di nozioni” che è un dio, secondo la definizione di L. Gernet e A. Boulanger5. Tale chiave d’accesso sottostà però a una serie di coordinate, di ordine spazio-temporale, ma anche ambientale, politico-amministrativo, linguistico, etc. Insomma, i nomi sono soggetti a variabili che mutano al variare delle condizioni in cui vengono espressi e attivati.
Il presente articolo si propone, tramite lo studio di casi selezionati, di osservare come gli agenti umani rendano i nomi divini nei testi bilingui seguendo strategie molteplici. Infatti, con l’aiuto dell’immagine e/o del supporto materiale, i nomi ci rivelano fino a che punto un testo bilingue possa recepire e assorbire la complessità dei contatti culturali e delle vicende storiche che coinvolgono una comunità. Inoltre, ogni diversa strategia denominativa e traduttiva/traspositiva corrisponde a una logica e a una visione del mondo diverse.
Con l’intenzione di seguire qualche mondo possibile, partiremo dalla città di Dura-Europos, dove le innumerevoli influenze culturali hanno dato vita a un numero nutrito di iscrizioni greco-semitiche, specialmente in contesto religioso. Qui, al testo si associano le immagini, almeno in due casi su tre, anch’esse costruite sul vocabolario del bilinguismo. Infatti, a elementi tipicamente “greci”, si associano invece stili e patterns palmireni, hatreni, o anche romani. Continueremo poi con il caso di Dushara in Nabatea, passando dunque da una città e i suoi culti, al culto di un solo dio in una regione più vasta, affinché si renda evidente come anche la distribuzione spaziale sappia influenzare la resa onomastica. Dushara riceve infatti un trattamento onomastico differente in greco e in nabateo; addirittura, in alcuni casi il suo nome è così sinergicamente collegato al supporto materiale sui cui il testo è inciso da prendere come epiteto il nome del supporto stesso. In seguito, il caso di due iscrizioni, una da Palmira, l’altra da Arado, permetterà di approfondire la centralità del contesto e, dunque, degli agenti che ne sono all’origine, per poter interpretare e ponderare con attenzione l’uso dello strumento del bilinguismo stesso e della resa in più lingue dei nomi divini.
Descrivere gli dèi: bilinguismo a Dura-Europos
Il confronto tra lingue diverse tramite un’iscrizione bilingue fa emergere le peculiarità di ciascuna di esse nel descrivere una persona, un oggetto, oppure un dio, e rende evidente che ognuna possegga logiche di espressione che le sono proprie6. Dura-Europos, prima fortezza seleucide, fondata all’epoca di Seleuco I Nicatore (358-281 a.C.), poi città partica e, solo per brevi tratti, romana, vive una particolare commistione di influenze culturali diverse, tanto da potersi ritenere un caso di studio privilegiato per i fenomeni di appropriazione culturale. Ciononostante, la lingua epigrafica di gran lunga più attestata è il greco che lingua accompagna la storia di Dura-Europos dalla fondazione della fortezza all’inclusione nei vari imperi e lungo tutto lo sviluppo di una cultura tanto peculiare quanto mista di elementi che provengono dal Mediterraneo, come dal profondo Eufrate. Qui si sviluppa uno stile artistico unico, che resiste ancora oggi e si concretizza in architetture, bassorilievi, affreschi murali tra i più preziosi dell’Antichità. Esso si associa a un senso d’identità degli abitanti della città del tutto rimarchevole. La categoria degli Eurôpaioi, come tendono a definirsi i suoi abitanti nel corso dell’Antichità, è strumento tanto amministrativo quanto culturale, poiché serve all’autodefinizione di uno status, tanto quanto ad aderire a un insieme di nozioni, pratiche e pensieri condivisi7. Un numero nutrito iscrizioni bilingui (greco – aramaico medio) ci ricordano però che il monopolio della lingua greca non doveva essere assoluto, ma che essa veniva preferita per diverse ragioni, che rimontano in parte alla fondazione macedone e alla necessità di descriversi dei suoi abitanti come Eurôpaioi. In particolare, tre testi greco-aramaici implicano delle sequenze onomastiche divine e si situano in tre punti diversi della città, nonché utilizzano dialetti aramaici diversi (hatreno e palmireno).
Il bassorilievo di Nemesi
La prima iscrizione bilingue di Dura-Europos della quale ci occupiamo adopera una trasposizione del nome divino. Si tratta di una base di stele ritrovata nei pressi della Porta di Palmira datata dall’iscrizione che segue il bassorilievo al 228-229 d.C.
Greco: Θεᾷ Νεμέσι Ἰούλιος Αὐρήλιος Μαλωχᾶς | Σουδαίου Παλμυρηνὸς εὐξάμενος ἀνέθη-|κεν“Alla dea Nemesi, Giulio Aurelio Malôchas, figlio di Soudaios, palmireno, ha offerto in ex-voto”.Aramaico: ̒bd wmwd’ mlwk’ br šwdy tdmry’ lnmsys | šnt 540“Ha fatto in ringraziamento, Malocha, figlio di …, palmireno (questo) per Nemesi. Anno 540” 8.

Al testo greco, scolpito per primo, di una dedica alla “Θεᾷ Νεμέσι” risponde una trasposizione in aramaico “lnmsys” (“per Nemesi”). In questo caso, dunque, nessuna esitazione interpretativa, in entrambe le lingue si condivide l’informazione che la potenza divina che si vuole mobilitare sia proprio quella conosciuta in lingua greca come Nemesi9. Nel commento all’iscrizione, l’editore (Bertolino) propone Nemesi come ipostasi di Atena-Allat. Sebbene l’associazione sia interessante, non va dimenticato che ci si serve del nome di Nemesi anche nella versione palmirena, non di quello di Allat. Una comparazione utile è quella con un’iscrizione bilingue di Hatra, dedicata a Helios e Allat, in cui il nome della dea Allat è trasposto in greco e non tradotto con Atena o Nemesi, figure assai vicine alla dea per ragioni diverse. L. Dirven a questo proposito commenta: “The fact that the Aramaic name of the goddess is simply transcribed in Greek strongly suggests that she was not identified with Nemesis or any other Greek goddess in her temple in Hatra”10.
Al testo del bassorilievo dureno si associa un’immagine potente: la dea è raffigurata sul lato sinistro, in piedi, il peso è poggiato sulla sua gamba sinistra. Il braccio destro è piegato sino al gomito e la sua mano potrebbe spostare il drappeggio della veste dal petto11. Sopra la spalla sinistra e fin nella mano sinistra doveva trovarsi un oggetto sottile, probabilmente un’asta. La dea è poi vestita con un lungo chitone e un himation che le copre la testa e la parte superiore del corpo, mentre il collo è decorato da una collana. Il suo volto, così come quello degli altri personaggi, è stato distrutto volontariamente già in epoca antica. Il personaggio sulla destra è il dedicante, Giulio Aurelio Malochas, raffigurato mentre offre su un thumiaterion. Egli è in posizione frontale, anche se il suo corpo è leggermente girato, rivolto alla dea, mentre la sua destra doveva probabilmente depositare l’incenso sul thumiaterion. Nella parte bassa, un piccolo grifone di profilo è rivolto anch’esso alla dea. Infine, al centro della scena, si interpone tra le due figure il busto di un dio con corona solare. Sembra sospeso a mezz’aria ed è rivolto completamente verso lo spettatore, quasi fosse il sole esso stesso. È rappresentato con capelli corti e ricci. Sul capo, una corona a sedici raggi è contenuta all’interno di un nimbo rotondo. La parte alta del busto lo rappresenta vestito con un paludamentum romano.
Interpretare la scena è cosa ardua, poiché entrambe le divinità, così come il dedicante, portano attributi e agiscono rispettando delle norme religiose ben consolidate in tutto il mondo mediterraneo. Inoltre, il dedicante proviene da Palmira, ma porta dei nomi latini; la dea, invece, ha un nome greco anche in aramaico palmireno. Insomma, tutto ci fa pensare a uno spaccato di vita religiosa di Dura-Europos, la cui cultura dalle numerose influenze partecipa pienamente al mondo mediterraneo, da un lato, e iranico, dall’altro, ma l’associazione tra un busto solare e la dea Nemesi sembrerebbe insolita. È L. Dirven a sollevare il problema. Difatti, nell’analisi del bassorilievo propone che l’influenza palmirena sia non solo stilistica, ma anche religiosa, poiché a Palmira la dea Allat condivide il suo santuario proprio con una divinità solare. Se questo è vero, d’altro canto bisogna sottolineare che all’interno del Santuario di Allat a Palmira, la dea è univocamente associata ad Atena, e nell’onomastica divina e nell’iconografia, a eccezione della sua statua di culto, nella quale la dea è rappresentata in abiti “civili” e seduta in trono fiancheggiata da leoni. Dunque, nel suo santuario palmireno Allat non è associata a Nemesi, così come non sembra esserlo in quello di Hatra, dove pure figura con Helios.
Se sul bassorilievo di Dura-Europos la dea Nemesi non è tradotta con Allat, si può spiegare diversamente la sua vicinanza alla divinità solare, il cui busto l’accompagna? Di certo, la somiglianza solo iconografica tra Nemesi e Allat, che si trova in alcuni luoghi del Vicino Oriente, potrebbe servire da anello di congiunzione tra la dea e il dio solare, ma la coabitazione di Allat e Helios nel santuario palmireno non basta a spiegare quella tra Nemesi e il dio solare, a maggior ragione che nel bassorilievo di Dura-Europos la rappresentazione e la denominazione di Nemesi non lasciano dubbi sulla sua identità. Su quest’ultimo non c’è visibilmente alcuna interpretatio, né operazione di sincretismo. Abbiamo già ricordato l’iscrizione di Hatra in cui Allat è associata a Helios e conserva il suo nome anche in greco, proprio come qui fa Nemesi in palmireno.
Concentriamoci per un instante sul dio solare, prima di tornare a Nemesi. M. Gawlikowski pensa che nel caso del santuario di Allat a Palmira si tratti di Šamaš, divinità solare mesopotamica, venerato anche a Dura-Europos sotto l’influenza hatrena12. L’iscrizione che analizzeremo di seguito, infatti, testimonia della presenza di Šamaš/Helios a Dura-Europos per il tramite della cultura hatrena13. Dunque, dove si gioca il legame tra il Sole e Nemesi? Nella tradizione di derivazione mesopotamica, il Sole è una potenza che tutto vede e tutto giudica, grazie alla sua distanza e onnipresenza dalla Terra. Come lo nota D. Charpin, in quanto divinità solare “Shamash judges in heaven and decides human beings’ fate”14. Il potere di controllo di ciò che succede sulla Terra, però, non è prerogativa del solo Šamaš, poiché anche nel mondo greco Helios ha a che fare con la gestione. La descrizione che ne fa J.-P. Vernant in Mythe et société (1974) è significativa:
Non qu’Hélios soit omniscient au sens propre ; mais son œil rond toujours ouvert au
haut du ciel en fait un témoin infaillible ; à ce regard de lumière rien n’échappe
de ce qui a pu se passer à la surface de la terre ou des eaux15.
Mi sembra che sia proprio su questo piano, quello della garanzia, del controllo e
dell’ordine che le due potenze divine si associano, nel Vicino Oriente ancor più che
in Grecia16. Guardando al mondo mesopotamico, è a Šamaš che viene dedicata la stele contenente
il primo insieme di leggi del mondo antico, il Codice di Hammurabi. Nemesi, dal canto
suo, è un’emozione, prima ancora che una divinità, per esempio in Omero. D. Bonanno
sottolinea però che nella pratica religiosa Nemesi diventa una dea a pieno titolo
e accoglie come funzione principale quella di garante della buona tenuta del cosmo,
nonostante le diverse adattazioni locali ridescrivano di volta in volta il suo profilo.
Per capire fino a che punto Nemesi e il Sole svolgono dei ruoli prossimi leggiamo
questo passaggio nelle conclusioni del volume che D. Bonanno consacra interamente
a questa emozione/divinità:
Dalla rilettura delle diverse tradizioni sulla sua discendenza, ora da Notte, ora
da Oceano, figure, a loro volta percepite dai Greci come forze di contenimento, viene
fuori il ritratto di una potenza del limite, necessaria alla buona tenuta del cosmo
[…]. (A proposito di un paragone con Tyche) Diversamente dalla fortuna cieca che abbatte
o solleva in maniera caotica e scriteriata, Nemesis invece ha una vista e un udito
acutissimi e la sua azione si inserisce in un orizzonte di attesa che i mortali sono,
in qualche modo, capaci di riconoscere17.
La mancata traduzione di Nemesi con Allat potrebbe significare la volontà del dedicante di riferirsi proprio al concetto di Nemesi di matrice greca. La rappresentazione è in una certa misura anch’essa iconograficamente “bilingue”, perché, se da un lato mette in scena una Nemesi che si confà allo stile artistico greco, il Sole invece riceve un trattamento assai diverso: possiede degli attributi militareschi che a Palmira sono ben diffusi per le divinità palmirene come Malakbel, Aglibol e Yarhibol. Anche quando il loro culto circola al di fuori di Palmira essi possono conservare tale iconografia solare: a Roma, nei Musei Capitolini, è conservato un altare con diversi bassorilievi, tra i quali uno sul lato principale raffigura un busto solare e porta un’iscrizione in latino con dedica a Sol Sanctissimus. Sul lato sinistro, invece, un testo in palmireno commemora la dedica a “Malakbel e gli dèi di Palmira”18.
Tornando al bassorilievo di Nemesi, qualsiasi siano le conoscenze messe in gioco dal suo dedicante, sulle quali non possiamo che congetturare (la belief ascription è, del resto, l’arma di ogni storico), e nonostante il santuario palmireno di Allat sia tra i più importanti nella sua città natale, Giulio Aurelio Malôchas qui non fa di Nemesi un’Allat, non fa opera di intepretatio. Ciò detto, la rinomanza del culto di Allat a Palmira e il suo legame col Sole si riflettono nella tematica della gestione dell’ordine cosmico che il dedicante ripropone in questo bassorilievo, appropriandosi però dell’immagine e del nome di una Nemesi dai contorni greci19. Non va dimenticato, infine, che il documento appartiene al III s. d.C., quando nel Vicino-Oriente Nemesi è associata spesso ad altre figure, come Tyche e Nike, poiché arbitro e moderatrice di ogni cosa (arbitra rerum ac disceptatrix), per dirlo con le parole di Ammiano Marcellino, autore antiocheno di iv s. d.C.20. Con entrambe, infatti, condivide il potere di determinare gli eventi, nonostante il tipo di potere vari poi profondamente a seconda della potenza divina chiamata in causa.
Il culto solare da Hatra a Dura-Europos
Continuiamo sulla falsa riga del culto solare per affrontare un caso in cui la resa dei nomi divini in greco e aramaico è diversa dalla sola trasposizione Nemesis/nmsys. La seconda iscrizione bilingue è redatta in dialetto hatreno e mette insieme più processi linguistici. Si tratta di una lastra di gesso dipinta in rosso e trovata nel canale di scolo dell’acqua del tempio di Atargatis, davanti al pronaos. In mancanza di un’iconografia di accompagnamento, il legame col supporto è meno rilevante che negli altri casi. Analizzeremo il documento a riguardo della traduzione del nome divino. Leggiamo anzitutto il testo:
Greco: Μαλχίων Σομέσου | ἔδωκεν εἰς τὸ ἀνάλω-|μα θεῷ Ἡλίῳ (δην.) ρʹ ὑπὲρ σω-|τηρίας “Malchiôn, figlio di Somesos, ha contribuito alla spesa per il dio Helios 100 denari, per la (sua) salute”. Aramaico: dkrn’ ṭb’ lmlkyn br | šmyšw mḥzy’ dy qryb | mn ̒bd’ hdyn lšmš ’lh’ | dnr’ 100 ‘l ḥywhy l‘lm “Buon ricordo per Malkiôn, figlio di Šamišou, di Maḥoza, che ha offerto per Šamaš il dio 100 denari di quest’opera, per la sua vita per sempre” 21.
La corrispondenza tra i due testi è quasi perfetta. Essi commemorano l’offerta di 100 denari fatta dal dedicante in onore della divinità, cui probabilmente la sua famiglia era devota. Difatti, come lo nota l’editore, il patronimico di Malkiôn è Šamišou, ossia “piccolo sole”. Questo dettaglio ci dice qualcosa sulla storia familiare dell’agente, poiché Šamišou, sebbene attestato ad Hatra, non è un nome comune a Dura-Europos e può dunque essere legato alla speciale devozione della famiglia al culto solare. Inoltre, il patronimico demarca in questo caso una differenza sostanziale tra antroponimia e teonimia: nel passaggio dall’hatreno al greco il nome si traspone, non si traduce (da Šamišou a Somesos), così come abbiamo visto per Nemesi nella prima iscrizione. Invece, in questa iscrizione, il processo cambia sensibilmente quando è il momento di mettere per iscritto il nome divino. Se da un lato troviamo senza sorpresa “per Šamaš il dio”, dall’altro la sequenza è tradotta con “per il dio Helios”. In effetti, il termine ʾlh (dio) è tradotto con theos (dio) e la posizione invertita (“Šamaš il dio” in aramaico e “il dio Helios” in greco) rispecchia pienamente le strutture frasali delle due lingue.
Tuttavia, dire “traduzione” non basta. Šamaš ed Helios non sono l’uno la traduzione perfetta dell’altro. Entrambi divinità solari, essi condividono lo stesso dominio. Nelle rispettive letterature, il primo è anche divinità protettrice della casa reale e delle leggi, nonché della messa per iscritto e fissazione di queste ultime. In quanto Sole che tutto vede, Šamaš ha anche prerogative divinatorie22. Helios non riceve spesso tali competenze, poiché anche altre divinità sono preposte agli stessi compiti. Su tutte si pensi alla prerogativa divinatoria affidata nel mito greco ad Apollo23, oppure la scrittura a Ermes. Il nostro dedicante ricerca però un equivalente di Šamaš in Helios e li pone, sulla base delle nozioni in suo possesso, in equazione, poiché identificano la stessa potenza divina (il sole) nelle due diverse lingue.
Siamo dunque davanti a più processi linguistico-cognitivi in primis, ma anche profondamente radicati e limitati ai saperi condivisi dalle popolazioni antiche in materia religiosa. Questi due casi mettono bene in luce la pluralità delle dinamiche all’attivo nella redazione di un testo bilingue. Tuttavia, alle corrispondenze semplici possono affiancarsi sequenze onomastiche più complesse, veicolanti in forme diverse un contenuto sostanzialmente equiparabile.
Zeus Kurios e Baalshamin, il primo incontro
Sebbene la prima in ordine cronologico (i s. d.C.), l’ultima iscrizione bilingue di Dura-Europos qui discussa è uno dei reperti più affascinanti e complessi della storia Vicino Orientale di epoca greco-romana, il bassorilievo di Zeus Kurios.

Il rilievo porta un’iscrizione nella parte bassa in greco e in palmireno, che recita:
Greco: Σέλευκος Λευκίου ἐδώρησ-|α τò(ν) ἀνδριάντα τῷ Δεῖ κυρ-|ίῳ καì Ἀβαβοῦις υἱòς αὐτοῦ | ἔτους γμτ’ μηνòς Ἀπελλ-|αίου. Μνησθῇ Ἰαραῖος Γ(ι)λλιτης “Seleuco, figlio di Lucio, ha offerto (questa) statua per Zeus Kurios e Ababouis, suo figlio, anno 343, mese di Apellaios. Che sia ricordato Iaraios Gillitès…”. Palmireno: bry[ḥ]…tšr.šnt 343 | mṣb’ dn’ nṣb b[r̒]th br | lwky w’bbwhy brh | lb[̒l]šmyn ̓lh’ “Nel mese di Tišri, anno 343, questa stele hanno offerto Ba[rʿa]the, figlio di Lucio, e ʼAbaboûhî, suo figlio, per Baalshamin, il dio”24.
Durante la settima stagione di scavi finanziati dall’Università di Yale e dall’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, sotto la direzione di M. Rostovtzeff e F. Cumont, nel santuario noto come “di Zeus Kurios” è stata rinvenuta una stele in calcare datata al 31 d.C. (secondo l’era seleucide, utilizzata in entrambe le versioni), recante una doppia iscrizione in greco e aramaico. Il bassorilievo rappresenta due figure cui l’iscrizione dà un nome: a sinistra il dedicante con in mano un giovane ariete e a destra il dio in trono, vestito con una lunga tunica e con un kalathos. Come di consueto nell’arte vicino-orientale, la divinità è molto più grande del dedicante. Per l’analisi iconografica, seguiremo l’interpretazione di L. Dirven, che è tornata più volte su questo documento25.
Il piccolo rilievo testimonia l’influenza palmirena a Dura-Europos e allo stesso tempo della vitalità culturale della città, dal momento che incorpora elementi che potrebbero essere definiti “dureni” nonostante il modello palmireno. Lo stile del rilievo suggerisce che lo scultore fosse originario di Palmira o che fosse fortemente influenzato da una bottega palmirena. In particolare, la rappresentazione del dio frugifero appartiene al patrimonio culturale religioso vicino-orientale fin dall’Età del Bronzo. Nel rilievo, il dio barbuto è raffigurato sul lato destro, con un mantello e una tunica a maniche lunghe. Nella mano sinistra tiene uno scettro e un mazzo di cereali, mentre nella destra vari frutti. Secondo L. Dirven, questa postura riflette l’origine fenicia di Baalshamin. Sul lato sinistro del rilievo, invece, si trova Seleuco, il destinatario della dedica, il cui nome greco è tutt’altro che insignificante a Dura-Europos. Esso ricorda quello di Seleuco I, al quale si fa rimontare la fondazione della prima fortezza sulle cui basi si è costituita la Dura-Europos d’età romana. Egli tiene tra le braccia un giovane ariete, la sua offerta alla divinità. Come il dio, il dedicante è vestito con una tunica a maniche lunghe e un mantello. Infine, anche se è a capo scoperto e indossa scarpe, nulla tradisce il suo status (è un sacerdote?).
Un’unica rappresentazione figurativa dà vita a un “Zeus Kurios” (in greco) / “Baalshamin il dio” (in aramaico) dai caratteri assai siriani e, soprattutto, stilisticamente influenzati dall’arte palmirena, città vicina e una cui nutrita comunità abitava le strade, i mercati, i templi di Dura-Europos. Nel bassorilievo, il dio dai poteri frugiferi è reggente del mondo, siede sul trono e porta un kalathos sul capo. Si raffigura, dunque, la sua preeminenza, come dimostrano gli elementi onomastici “kurios” e “baal”, semanticamente legati alla gestione, protezione e controllo. L’equazione tra i due passa, cioè, per una caratteristica comune, la kuria, che nel caso di Zeus non è espressa dal solo teonimo, ma necessita di un’aggiunta, l’elemento onomastico kurios, per l’appunto. In aramaico, invece, il potere gestionale del dio passa attraverso i caratteri atmosferici e universali, egli è difatti “signore dei cieli”. In questo caso, l’associazione uno a uno necessita di essere descritta ulteriormente.
L’associazione tra Zeus e Baalshamin è facile a farsi, gli studiosi si appoggiano particolarmente su Filone di Biblo, storico del i-ii s. d.C., che ne spiega la natura. Egli è autore di un’opera (una Storia fenicia) a carattere storico-religioso, contemporanea alla maggior parte dei documenti qui trattati e giunta sino a noi in frammenti. Leggiamo il passaggio che interessa Baalshamin:
In seguito, dice (Filone), dal vento Kolpias e da sua moglie Baau (che egli traduce come “la notte”), nacquero Aiôn e Protogonos, uomini mortali così chiamati. Aiôn scoprì il cibo che prendiamo dagli alberi. I suoi discendenti furono chiamati Genos e Genea, ed essi abitarono la Fenicia. Siccome si susseguirono lunghi periodi di siccità, essi tesero le mani al cielo verso il Sole. In effetti, dice (Filone), essi consideravano questo dio come il solo sovrano del cielo e era chiamato Beelsamen, che presso i Fenici significa sovrano del cielo, Zeus presso i Greci26.
Qui Baalshamin è un teonimo a pieno titolo, il suo nome non è tradotto con quello di Zeus, come invece fa Erodoto in un noto passaggio delle sue Storie27. Filone adotta più strategie onomastiche, prima traspone il nome in caratteri greci, poi ne traduce il significato in greco (Baalshamin è ricordato come il κύριος οὐρανοῦ), infine lo equipara ad una divinità del pantheon greco, interpretando così Baalshamin con Zeus28. Tale resoconto filoniano sul dio di origini fenicie è confermato dalla pratica cultuale delle città vicino-orientali. A Palmira, per esempio, Zeus e Baalshamin sono l’uno un equivalente assai valido dell’altro e figurano in un piccolo numero di iscrizioni bilingui.
Come comprendere dunque il bassorilievo di Dura-Europos alla luce di questi dati? Che procedimento c’è dietro questo documento? Le due sequenze onomastiche, “Baalshamin il dio” e “Zeus Kurios”, non si equivalgono alla perfezione da un punto di vista formale, ma insistono entrambe sullo stesso punto, ossia l’esaltazione del ruolo sovrano della divinità, così come si evince dalla rappresentazione. Zeus/Baalshamin è il personaggio più grande su scena, è seduto sul trono e porta diversi indizi del suo potere. L’aspetto sovrano è rispecchiato dagli elementi onomastici, che accompagnano i due nomi: kurios e ʾlh (“dio”) che in posizione predicativa, come lo si trova di frequente nelle iscrizioni semitiche, serve a porre maggiormente l’accento sulla sua preminenza maggiormente, perché semanticamente il nome di Baalshamin porta già su di sé il segno del ruolo ricoperto. “Baal” difatti è semanticamente equivalente di kurios, sebbene i loro usi siano molto diversi29. Tutto il documento spinge alla rappresentazione di una divinità dai tratti locali, ma al tempo stesso dal profilo e competenze universali, nonché dai caratteri sovrani. Un ultimo particolare dev’essere ricordato a questo proposito: Baalshamin a Dura-Europos è sollecitato solo in contesti palmireni, Zeus invece riceve un numero nutritissimo di denominazioni diverse e accompagna tutte le componenti sociali della città. Senza dubbio, in quanto divinità più popolare nel dossier epigrafico di Dura-Europos, il suo profilo è rielaborato profondamente nel corso del tempo e a seconda delle componenti sociali che se ne appropriano.
Dalla rappresentazione alla presentificazione dei nomi. Dushara nelle bilingui di Nabatea
Dura-Europos e i suoi bassorilievi evidenziano la relazione biunivoca tra nome scritto e rappresentazione visiva, due strumenti diversi per descrivere uno stesso oggetto del pensiero, tali le divinità. Talvolta, quando nomi e rappresentazione materiale/visiva partecipano attivamente alla costruzione del divino, sono essi stessi parte integrante della divinità, poiché permettono di “presentificarla” nello spazio, si pensi, per esempio, a oggetti sacri come pietre, troni, o immagini divine (xoana)30 che rendono visibile e attualizzano nel momento del rituale il potere divino in mezzo agli uomini.
Nelle religioni vicino-orientali, durante il rituale diversi oggetti presentificano il dio tanto quanto una statua di culto, al punto che a essi nella pratica religiosa ci si rivolge con la stessa reverenza e devozione che si concede al dio stesso. Ce lo dicono diverse fonti storiografiche, così come reperti archeologici e persino nomi divini. In età bizantina, la Suda (x s. d.C.) ricorda un rituale che si svolgeva per il tramite di questi oggetti a Petra. L’autore riferisce tali rituali al culto di un certo “Theos Ares” nel quale molti studiosi rivedono Dusares/Dushara, divinità nabatea legata alla casata reale. Leggiamo il passo:
Theus Ares: a Petra d’Arabia egli è il dio Ares. Si venera il dio Ares presso di essi, anzi è quello che viene onorato maggiormente. L’immagine è una pietra nera (lithos […] melas), quadrangolare, senza forma (atupôtos) la sua altezza è di quattro piedi, la larghezza di due. Essa è posta su una base d’oro. Gli abitanti (di Petra) sacrificano a questa e versano sopra il sangue delle vittime. Tale è per loro la libazione (spondê)31.
Il passaggio è interessante sotto molteplici aspetti, ma più di tutti la centralità nel rituale, della pietra la quale ricevere il sacrificio, viene unta con il sangue delle vittime. Non mancano nei luoghi di culto di Dushara, a Petra, Bosra, Puteoli bassorilievi rappresentanti altari sormontati da pietre di forma rotonda, o, come nel caso di Puteoli, veri altari in marmo sormontati da queste pietre e con l’iscrizione “DUSARI SACRUM” su almeno una delle quattro facce32. Se ne contano già quattro.
Insomma, tanto nella letteratura, che nel repertorio archeologico, Dushara è un dio la cui rappresentazione si fa per il tramite di più forme (da quella antropomorfa, spesso erculea, a quella litica). Qui si gioca ben più della sola rappresentazione del divino, poiché per il tramite di questi oggetti è il dio (o meglio, la sua dunamis, come abbiamo visto) che si manifesta, che si rende presente “qui e ora”. L’onomastica divina ricorda un numero considerevole di Zeus qualificati non da un epiteto classico, bensì da un sostantivo come “Altare” o “Betilo”33. Non solo Zeus, ma anche dei “Theos Bômos” sono noti nel Vicino Oriente34. Queste costruzioni onomastiche inferiscono che il potere divino passi per l’oggetto o, meglio, si renda visibile tramite esso. Torniamo a questo proposito, sulle iscrizioni bilingui. Nel villaggio di Umm al-Jimāl, sito a 17 km da Mafraq in Giordania del nord su un altare trovato nella corte della Casa VI, a est del villaggio, due iscrizioni, greco e nabateo rispettivamente, databili al i o ii s. d.C., recitano:
Nabateo: mšgd’ | dy ‘bd | mškw | br ‘wy-|d’ ldw-|šr’ “Altare, che ha fatto Mašekō, figlio di ‘Awīda, per Dushara”. Greco: Μασε-|χος Α-|ουειδ-|ανου | Δουσ-|αρει Α-|αρρα “Masekos, figlio di Aoueidanos, per Dousares Aarra”35.
Un tale Masekos dedica dunque un altare a Dushara. Se nella versione nabatea troviamo il nome semplice di Dushara, in quella greca un elemento onomastico lo accompagna, Ααρρα. Esso non trova alcun equivalente nella versione nabatea, ma è davvero così? Lorenzo Petrantoni analizza il nome Ααρρα e propone delle derivazioni dall’arabico, in parte già congetturate da diversi editori: E. Littman ritiene che derivi dalla radice arabica ġarā che significa “buono, bello”, invece J. Teixidor lo fa derivare dalla forma ġry > aġrā che significa “ungere” oppure “tingere”36. In questo secondo senso, l’elemento onomastico potrebbe relazionarsi al repertorio di oggetti che presentificano Dushara (altari, pietre sacre, troni, etc.), che accolgono i sacrifici.
Dushara Aara è noto anche in altri documenti epigrafici in nabateo, tre per l’esattezza. Il primo è un altare, definito msgdʾ nel testo, dedicato a Dushara Aara (ldwšrʾ ʾʿrʾ) a Bosra nel 142 d.C.37. Il secondo, anch’esso un altare datato al 92 d.C. e ritrovato a Mothana/Imtan, è dedicato a “Dushara Aara, il dio del nostro Signore che è a Bosra” (ldwšrʾ ʾʿrʾ ʾlh mrʾnʾ dy bbṣrʾ)38. Una terza iscrizione menziona Aara da solo e lo qualifica di “Aara che è a Bosra, dio di Rabbel” (l ʾʿrʾ dy bbṣrʾ ʾlh rbʾl)39. Il culto di Aara nasce a Bosra, sulla cui monetazione compare l’altare sormontato da pietre a partire dal regno di Eliogabalo. I bronzi in questione portano la legenda ΔΟΥϹΑΡΗϹ ΘΕΟϹ. La città, del resto, nel corso del iii s. d.C. bandisce degli Actia Dusaria, giochi atletici in stile greco40. Insomma, è difficile a dirsi se si sia trattato di un solo culto, quello di Dushara Aara nella città di Bosra, oppure di due culti separati i quali siano poi stati accomunati dalle pratiche rituali e dalla resa visiva sotto forma di oggetto.
Nel caso dell’iscrizione di Umm al-Jimāl, tuttavia, il nome Aarra figura soltanto in greco, in nabateo è il solo nome di Dushara a comparire. Questa differenza sostanziale si può spiegare in più modi: da un lato, possiamo ritenere che l’autore della dedica abbia sentito la necessità di specificare a quale culto stesse facendo riferimento solo in greco e che il nome di Dushara in nabateo bastasse a identificare e attivare il potere di quel dio; dall’altro, possiamo notare che il sostantivo per “altare” manca in greco, come succede spesso, mentre in nabateo è il termine msgdʾ a indicare l’oggetto dedicato. Laddove in greco c’è un’aggiunta nel nome divino che punta verso il rito di unzione dell’altare/pietra sacra, nella versione nabatea basta specificare che per Dushara si offre un msgdʾ, ossia un altare o pietra.
Il termine msgdʾ è diversamente interpretato dalla critica, siccome tradizionalmente rappresenta l’altare e non una pietra sacra. Tuttavia, recentemente Laïla Nehmé ha dimostrato l’ambiguità di utilizzo del termine. Incentrato sui bassorilievi di Hegra, l’articolo di L. Nehmé suggerisce una realtà meno schematica e univoca: a sinistra di un basamento su cui poggiano dei bassorilievi raffiguranti pietre sacre, un’iscrizione fa riferimento agli oggetti raffigurati e li chiama msgdy’, cioè il termine comunemente utilizzato per indicare gli altari. Questa iscrizione e un’altra proveniente da Madāʾin Ṣāliḥ testimoniano quindi l’uso di questo termine per designare una pietra sacra più che un altare41. Mettendo in dubbio l’univocità del termine e le intenzioni del committente e del costruttore del monumento, che non per forza coincidevano, si suggerisce di guardare alla pratica cultuale “sul campo” come a un insieme di nozioni non prestabilite, che si ridefiniscono all’interno di ciascun contesto.
In definitiva, questi testi greco-nabatei aggiungono al percorso fatto fin qui che il supporto può essere qualcosa di più che un elemento accompagnatore o esplicativo del testo, poiché nei casi in cui esso è parte attiva del rituale, o ricorda il momento rituale, esso presentifica la divinità nel momento sacro della pratica. Infondo, il legame tra rito e supporto è esplicitato nel nome stesso. Aara è sia l’atto dell’ungere, dunque il rituale, che il nome divino ed entrambi sottintendono l’oggetto cui queste cure sono rivolte. La materialità del supporto influenza talvolta l’onomastica e può, nel caso di un testo bilingue, essere espressa in maniere diverse nelle due lingue scelte nel rispetto delle norme di cui l’agente è a conoscenza.
Rilevanza contestuale: Zeus/Baalshamin di Palmira e Eracle/Melqart di Arado
Ciascuna traduzione/trasposizione linguistica si radica in un contesto culturale ben preciso, come abbiamo visto, ma in esso può muoversi in più direzioni: quando si tratta di tradurre i nomi divini si scelgono strategie diverse, talvolta si associano due divinità appartenenti a due tradizioni e lingue diverse, talvolta si traslitterano o traspongono i fonemi che compongono un nome in un’altra lingua, oppure, come vedremo con Baalshamin e Durahlûn a Palmira nel cosiddetto “Santuario di Baalshamin”, alcune informazioni compaiono in una sola lingua, ossia quella tramite la quale si vuole veicolare quel preciso messaggio. Vedremo in ciò che segue che nel contesto sociopolitico e culturale palmireno le due divinità sono legate a una famiglia di notabili, la cui produzione epigrafica è quasi interamente bilingue, ma in essa la divinità “minore”, Durahlûn, sconosciuto al di fuori del contesto palmireno, non esiste che in aramaico. Non c’è volontà né esigenza di tradurre il suo nome, così come invece si fa per Baalshamin.
Il santuario di Baalshamin a Palmira fu costruito su terreni acquistati intorno al ii s. a.C. da una famiglia di notabili palmireni, i Benê Ma’azîn42. Esso è un complesso composto da più edifici (tre cortili a portici, una sala da banchetto e una cella) diversamente orientati su una zona di circa 160 m x 60 m. All’interno del pronaos, dove si situano la maggior parte delle iscrizioni greche e/o bilingui, il supporto (una console) della seconda colonna a partire dall’angolo sud è iscritto da dodici righe in greco sulla faccia principale e otto in aramaico sul lato destro; il testo risale al 130/131 d.C., che corrisponde alla data di consacrazione/inaugurazione dell’edificio. Il testo recita:
Greco: [Ἡ βουλὴ καὶ] ὁ δῆ[μος] | Μαλην τὸν καὶ Ἀγρίππα[ν] | Ιαραιου τοῦ Ρααιου, γραμμ[α]-|τέα γενόμενον τὸ δεύτε-|ρον ἐπιδη̣μ̣ίᾳ̣ θεοῦ Ἁδρ[ι]-|ανοῦ, ἄλιμμα παρασχό[ν]-|τα ξένοις τε καὶ πολείτα[ις] | ἐν πᾶσι̣ ν̣ ὑπηρετήσαντα | τῇ τ[ῶν] στρατευμάτων | ὑπο[δοχ]ῇ καὶ τὸν ναὸν | τὸν [τοῦ] Διὸς σ[ὺ]ν τῷ π[ρο]-|ναίῳ [καὶ σὺν τ]αῖς ἄλλα[ις – – -]τ[- – – ἐξ] ἰδ[ίων – – -] “Il Consiglio e il Popolo (onorano) Malês, detto Agrippa, figlio di Iaraios, figlio di Raaios, segretario per la seconda volta; durante la visita del divino Adriano, egli ha fornito l’olio agli stranieri e ai suoi concittadini, ha sostenuto in tutto l’accoglienza dell’esercito e (ha offerto) questo tempio di Zeus con il pronaos e gli altri – – – a sue spese – – -.” Aramaico: mn twḥyt bwl’ wdmws [ṣlm’ dnh dy ml’] | br yrḥy l[šmš] r‘y dy hw’ grmṭws dy trty’ | wkdy ’t[’ ltn]n hdry[n’] ’lh’ yhb mšḥ’ | lbny md[ynt’ wl]’sṭr[ṭwm’] wl’ksny dy ’t’ | ‘mh [wšpr lm]dyth b[k]l md‘n wbn’ hykl’ | wprn’[yn wtṣb]yth k[l]h mn kysh lb‘lšmn | wldrḥ[lwn – – -]h dr[- – -] mn bny ydy‘bl | byr[ḥ – – -]n šnt [4]42. “Per decreto del Consiglio e del Popolo, [questa statua di Malê], figlio di Iarḥaî Lišamš Ra‘aî, che è stato segretario per la seconda volta e che, quando il divino Adriano è venuto qui, ha offerto l’olio tanto ai cittadini quanto all’esercito e agli stranieri che sono venuti con lui, e egli è stato accogliente con la sua città in tutte le cose e ha fatto costruire il tempio e il pronaos e tutto il decoro a sue spese, per Baalshamin e Durahlûn – – – dei Benê Iedî‘bel – – – anno 44243.”

Il testo, interessante sotto più aspetti è stato commentato diverse volte e l’editore di IGLS XVII (J.-B. Yon) ne dà una lunga bibliografia. Qui ci limiteremo ad analizzare la traduzione che è fatta dei nomi divini nelle due versioni, greca e aramaica. Males, detto anche Agrippa (in greco), dietro delibera del Consiglio e del Popolo, è onorato da una statua grazie ai servizi che ha reso alla città. Egli avrebbe in particolare fornito olio ai cittadini, agli stranieri e all’esercito, tutti venuti in occasione dell’ἐπιδημία del divino Adriano, cioè la visita dell’imperatore, collocata dagli storici nel 123 o nel 130 d.C.
Nella versione greca il naos appartiene a Zeus (τὸν ναὸν | τὸν [τοῦ] Διὸς), mentre in aramaico esso è dedicato a Baalshamin e Durahlûn (lb’lšmn wldrḥ[lwn). La corrispondenza tra Zeus e Baalshamin è cosa nota, ce ne parla persino Filone, come abbiamo visto. Tuttavia, in questo testo il rapporto non è di uno a uno, poiché nella versione aramaica il nome di Durahlûn è aggiunto a quello di Baalshamin, mentre in greco non è fornito alcun equivalente. Il santuario è dunque dedicato in palmireno a due divinità, in greco a una sola44.
Baalshamin e Durahlûn sono venerati insieme e al plurale negli altri testi del santuario, come in un’iscrizione vicina alla cella e datata al 59-60 d.C. ricorda: “Baalshamin e Durahlûn, gli dèi buoni”. Durahlûn è una figura divina assai poco nota, il suo luogo di culto, ossia il tempio di Baalshamin di Palmira, potrebbe essere anche l’unico. Egli compare nelle iscrizioni del sito dal 62 d.C., su un altare trovato in un edificio secondario della corte meridionale del santuario. Esso mette già in luce il legame con Baalshamin e i Benê Ma’azîn. H. Niehr ha proposto che alcuni dei simboli lunari che decorano il santuario siano la rappresentazione visiva di Durahlûn e non di Aglibôl, altra divinità palmirena, come la maggioranza dei ricercatori sostiene. L’ipotesi di H. Niehr si basa su una tessera da banchetto, sulla quale si dovrebbe leggere il nome di Durahlûn accanto a un dio rappresentato in piedi e sormontato da una mezzaluna.
Questo testo invita a riflettere accuratamente al bilinguismo in contesto epigrafico, poiché i testi bilingui non sono necessariamente la trascrizione esatta di tutte le informazioni contenute nel testo di partenza. L’operazione non è mai perfetta, soprattutto quando si tratta di confrontare i saperi religiosi: trattando una o più caratteristiche degli dèi messi a confronto, si procede ad un’operazione ermeneutica e culturale, connessa all’ancoraggio contestuale del dio della tradizione familiare dei Benê Ma’azîn, Durahlûn. Egli è menzionato solo nel testo aramaico, perché il suo culto, affare prettamente palmireno, non esiste al di fuori di quella lingua e di quel contesto. A Baalshamin, invece, l’equivalenza consolidata con Zeus è proposta anche qui.
Un ultimo esempio ci sia concesso: lunga e controversa è l’associazione che fanno gli Antichi di Melqart, il dio tutelare di Tiro, con Eracle45. Qui non si discuterà né la loro associazione, né tantomeno la diffusione del culto di Melqart nel Vicino Oriente. Vedremo soltanto il caso di un’iscrizione bilingue la cui peculiarità risiede nel suo forte ancoraggio contestuale. Documento assai celebre, poiché ultima testimonianza della lingua fenicia in Oriente datata al 25/4 a.C., esso testimonia anche l’esistenza nella città costiera di Arado di un ginnasio, luogo adibito alla formazione delle nuove generazioni alla maniera greca. Il testo è inciso su una base calcarea e una giunzione di tipo a tenone e mortasa lascia ipotizzare che sulla sua superficie vi si ergesse un pilastro. Ecco il testo:
Greco: Ανερ[…]| ἱεροποιοῦ γυμνασιαρχῶν τὸ ελσʹ | ἔτος Ἑρμεῖ Ἡρακλεῖ “Aner[X figlio di X ?] | ieropeo, essendo ginnasiarca nel 235 | a Ermes (a) Eracle”. Fenicio: ʿštrtḥwt tmnm . y … ʿlʿ| … t . r|bṣ(?) bn ‘bd .. mw … b bn | ʿštrt .. t qdš lʾrm… lmlqrt bšt ΣΛE lbnt ʿštrtḥwt [— ]figlio di … ? … [preposto ?] su [mare e su] terra, figlio di ʿbd …[preposto ?… ] figlio di | ʿštrt[ḥwt] … ha consacrato a Ermes [e] a Melqart, nell’anno 235 dalla fondazione”46.
Come dimostrato in primo luogo da F. Briquel-Chatonnet, il testo fenicio sembra modellato e tradotto sulla base del testo greco47. Sulla scorta di diversi elementi, tra cui la forma lbnt per indicare l’anno, hapax in fenicio, oppure la posizione dei sintagmi nella frase, nonché l’uso di lettere greche per indicare i numeri, la studiosa ritiene che tra i due testi l’originale fosse quello greco. Del contenuto ricostruiamo due informazioni principali, ossia lo statuto del dedicante, ieropeo e ginnasiarca, e gli dèi cui il monumento era dedicato, ossia Ermes ed Eracle (in greco) e Ermes e Melqart (in fenicio). Anzitutto, bisogna notare che tra i due teonimi non esiste la congiunzione restituita, si tratta di una giustapposizione. Le due figure sono menzionate numerose volte come divinità tutelari del ginnasio e dei suoi giovani e trovarle insieme anche ad Arado non meraviglia. Quello che fa di questo documento un momento di riflessione importante è come il suo offerente pensa alla traduzione. Avendo concepito prima il testo greco, Ermes ed Eracle sono dei destinatari quasi ovvi di atti di pietà nel contesto ginnasiale; diverso è il procedimento che porta il dedicante a costruire la traduzione fenicia. Il primo nome, quello di Ermes è traslitterato in fenicio (lʾrm). Egli riconosce che nel passaggio al fenicio non c’è un equivalente adeguato per esprimere la divinità conosciuta in greco sotto tale nome. Diverso, invece, è il destino che spetta a Eracle, poiché viene fatta valere l’equivalenza con Melqart, nel i s. a.C. ormai divenuta tradizionale. Eracle è dunque identificato con Melqart, dio di Tiro, il cui culto si diffonde in maniera abbastanza uniforme lungo le coste mediterranee. Come lo ricorda C. Bonnet “La puissance de “résistance” de Melqart, ou sa capacité singulière à exprimer une certaine souveraineté phénicienne, mérite d’être aussi soulignée”48. Persino nel contesto del ginnasio, nel quale Ermes ed Eracle sono ben consolidati e largamente attestati, Melqart “resiste” o, meglio, “persiste”, poiché la sua associazione a Eracle è radicata nella cultura fenicia e, soprattutto, nella lingua fenicia. Laddove per spiegare Ermes non si trova un opportuno parallelo, Eracle è invece Melqart, senza esitazioni.
Quest’ultimo documento ci riporta al ruolo della contestualizzazione e all’importanza di iscrivere la storia di una traduzione all’interno dell’insieme di saperi e pratiche note a chi ne è all’origine. La particolare pregnanza contestuale di Durahlûn, divinità palmirena legata a una singola famiglia di notabili, fa sì che non lo si traduca in greco; d’altro canto, il radicamento dell’associazione Eracle-Melqart è all’opera ancora nel i s. a.C. e persino in una traduzione pensata in greco, da parte di un “addetto ai lavori”, un ginnasiarca, che di paideia greca doveva pur intendersene.
Conclusioni
Da Dura-Europos ad Arado e fin in Nabatea, i testi epigrafici bilingui sono una miniera di informazioni per approfondire i contatti culturali e, dunque, linguistici che hanno avuto luogo tra l’età ellenistica e quella romana. Le diverse città/regioni con le loro ricche facies culturali si servono di numerose strategie di traduzione, trasposizione, sottrazione o addizione di informazioni nel passaggio da una lingua all’altra. I nomi divini lo hanno reso evidente a più riprese. Costruire i nomi divini in più lingue significa gioco forza seguire piste diverse, sia semantiche, sia morfologiche, sia sintattiche, oltre che seguire dei processi complessi che talvolta, come nel caso di Dura-Europos o Palmira, esulano dalla sola traduzione. È infatti nel contesto culturale in cui sono custoditi e circolano che i nomi prendono significato e, eventualmente, lo riadattano. Tale lavoro di contestualizzazione è al centro dei processi complessi di belief ascription, di cui i testi bilingui si fanno carico.
Nelle società antiche, come il Vicino Oriente, tradurre vuol dire attribuire dei pensieri, delle conoscenze, all’altro. Nei testi bilingui, i nomi divini in particolare svelano una parte di tali attribuzioni. Tuttavia, in contesti polilinguistici, come il Vicino Oriente ellenistico-romano, si è messo in evidenza che a Dura-Europos o a Palmira la traduzione/trasposizione da una lingua all’altra è una congettura anzitutto sul proprio mondo, e poi su quello dell’altro, poiché il mezzo linguistico non veicola necessariamente una cultura “altra”, ma motivi “altri” adattati ai propri saperi. Nel caso di contatti longevi tra comunità e saperi “altri”, i motivi culturali si rielaborano, si maneggiano con cura, ma finiscono per essere appropriati o rigettati. Così succede, ad esempio, al personaggio messo in scena da Luciano di Samosata nel suo De dea Syria, opera preziosa per lo studio del Vicino Oriente e che va contestualizzata nel suo tempo, nel suo genere (satirico circa gli studi etnografici di stampo erodoteo49) e a seconda del messaggio che l’autore intende lanciare al suo lettore. In esso, il protagonista, novello etnografo erodoteo, descrive il santuario della dea di Ierapoli e nel raccontare delle statue che si trovano al suo interno, si ferma a descrivere attentamente l’iconografia siriana di Apollo queste parole:
Al di là del trono, si vede lo xoanon di Apollo, ma non come egli è rappresentato d’abitudine. Tutti gli altri pensano ad Apollo come a un giovane uomo e lo raffigurano nel fiore dell’età. Solo codeste genti espongono lo xoanon di un Apollo barbuto; essi si autocompiacciono molto di questa usanza e biasimano i Greci, così come tutti gli altri, i quali venerano Apollo come un ragazzino. Ed ecco la causa: essi pensano che sia un grande errore di costruire delle rappresentazioni (eidea) imperfette (atelea) degli dèi, poiché essi considerano che la giovinezza sia imperfetta. Essi creano il loro Apollo anche tramite un altro dettaglio: sono i soli infatti a rappresentarlo vestito50.
Insomma, che i Siriani abbiano accolto l’iconografia greca di Apollo non vuol dire che non l’abbiano originalmente rielaborata: il loro Apollo è barbuto e vestito, non è un giovinetto dal fisico atletico, perché è la vecchiaia a essere simbolo di maturità intellettuale e perfezione – e gli dèi sono perfetti. Se Luciano, nella finzione letteraria, non esita a chiamarlo Apollo, d’altro canto, ci racconta di un’appropriazione culturale che dell’Apollo dei Greci ne fa “il loro Apollo” (ἐν δὲ καὶ ἄλλο τῷ σφετέρῳ Ἀπόλλωνι καινουργέουσι). Nonostante questo, non sia necessariamente il pensiero del nostro autore, icastico è il verbo di cui si serve per spiegare il procedimento: καινουργέω, infatti, significa letteralmente “creare/iniziare qualcosa di nuovo”.
Abbreviazioni
| CIL | Corpus Inscriptionum Latinarum. |
| IDR | Inscriptiones Daciae Romanae. |
| IGLS | Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie. |
| IGUR | Inscriptiones Graece Urbis Romae. |
| MAP | Mapping Ancient Polytheisms, [online] https://base-map-polytheisms.huma-num.fr/. |
| PAT | = Cussini & Hillers 1999. |
| RTP | = Ingholt et al. 1955. |
Université de Toulouse Jean Jaurès – Scuola Normale Superiore di Pisa, giuseppina.marano@sns.it, ORCID: https://orcid.org/0009-0005-6703-0401. Funding Project: ERC Advanced Grant 741182 MAP “Mapping Ancient Politheisms. Cult epithets as an interface between religious systems and human agency”.
Bibliographie
Belayche, N. (2001): Iudaea-Palaestina. The Pagan Cults in Roman Palestine (Second to Fourth Century), Religion der römischen Provinzen 1, Tubinga.
Bertolino, R. (2004): Corpus des inscriptions sémitiques de Doura-Europos, Annali. Supplemento/Università degli Studi di Napoli l’Orientale 94, Napoli.
Bettini, M. (2012): Vertere: un’antropologia della traduzione nella cultura antica, Piccola biblioteca Einaudi 573, Torino.
Bonanno, D. (2023): Nemesis: rappresentazioni e pratiche cultuali nella Grecia antica, Potsdamer altertumswissenschaftliche Beiträge 85, Stuttgart.
Bonnet, C. (1988): Melqart: cultes et mythes de l’Héraclès tyrien en Méditerranée, Lovanio.
Bonnet, C. (2015): Les enfants de Cadmos: le paysage religieux de la Phénicie hellénistique. De l’archéologie à l’histoire, De l’archéologie à l’histoire, Parigi.
Briquel-Chatonnet, F. (2012): “Les inscriptions phénico-grecques et le bilinguisme des Phéniciens”, Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 156, 619-638, [online] https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2012_num_156_1_93458 [consultato il 05/06/2025].
Brody, L. R. e Hoffman, G. L., ed. (2011): Dura-Europos: crossroads of antiquity, Chicago.
Camodeca, G. (2006): “Comunità di peregrini a Puteoli nei primi due secoli dell’impero”, in: M. G. Angeli Bertinelli e A. Donati, ed.: Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazioni di idee nel Mediterraneo antico, Atti del II Incontro Internazionale di Storia Antica, Genova, 6-8 ottobre 2004, Serta antiqua et mediaevalia 9, Roma, 269-287.
Charpin, D. (2010): Writing, Law, and Kingship in Old Babylonian Mesopotamia, Chicago.
Delalonde, M. (2021): L’histoire phénicienne de Philon de Byblos au prisme du multiculturalisme, Le religioni e la storia 4, Roma.
Dentzer-Feydy, J., Vallerin, M., Fournet, T., Mukdad, R. e Mukdad, A., ed. (2007): Bosra, aux portes de l’Arabie, Guides archéologiques 5, Beirut, [online] https://doi.org/10.4000/books.ifpo.666 [consultato il 05/06/2025].
Dirven, L. (1999): The Palmyrenes of Dura Europos: A Study of Religious Interaction in Roman Syria, Religions in the Graeco-Roman World 138, Leida, [online] https://doi.org/10.1163/9789004295926 [consultato il 05/06/2025].
Dirven, L. (2022): “Representing and Naming the Gods. Iconography and Nomenclature of the Goddess Allat in Palmyra and Hatra”, Mythos, 16, [online] https://journals.openedition.org/mythos/5538 [consultato il 05/06/2025].
Eco, U. (2003): Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione, Studi Bompiani, Milano.
Gawlikowski, M. (1990): “Le premier temple d’Allat”, in: Matthiae, P., van Loon, M. e H. Weiss, ed.: Resurrecting the Past: A Joint Tribute to Adnan Bounni, Uitgaven van het Nederlands Historisch-Archeologisch Instituut te Istanbul 67, Istanbul, 101-108.
Gernet, L. e Boulanger, A. [1932] (1970): Le Génie grec dans la religion, L’évolution de l’humanité: au format de poche 22, Parigi.
Gubel, E., Caubet, A. e Fontan, E. (2002): Art phénicien. La sculpture de tradition phénicienne, Parigi.
Invernizzi, A. (1989): “The Investiture of Nemesis-Allat in Hatra”, Mesopotamia, 24, 129-175.
Jarry, J. (1968): “Inscriptions arabes, syriaques et grecques du Massif du Bélus en Syrie du Nord”, Annales Islamologiques, 7, 139-220, [online] https://www.persee.fr/doc/anisl_0570-1716_1967_num_7_1_913 [consultato il 05/06/2025].
Le Bihan, A. (2012): “Bétyles et plates-formes cultuelles : un aspect des pratiques religieuses en Syrie du Sud”, in: Le Bihan, A., Blanc, P.-M., Braemer, F., Dentzer-Feydy, J. e Villeneuve, F., ed.: Territoires, architecture et matériel au Levant: Doctoriales d’archéologie syrienne. Paris-Nanterre, 8-9 décembre 2011, Colloques et journées d’études 1, Beirut, [online] https://books.openedition.org/ifpo/2962 [consultato il 05/06/2025].
Leriche, P. (2003): “Europos-Doura hellénistique”, Topoi. Suppl., 4, 171-191, [online] https://www.persee.fr/doc/topoi_1764-0733_2003_act_4_1_2861 [consultato il 05/06/2025].
Leriche, P. (2010): “Europos Doura séleucide”, Electrum, 18, 23-40, [online] https://ejournals.eu/en/journal/electrum/article/europos-doura-seleucide [consultato il 05/06/2025].
Leriche, P. (2020): “Doura-Europos ou Europos-Doura?”, in: Oetjen, R., ed.: New Perspectives in Seleucid History, Archaeology and Numismatics: Studies in Honor of Getzel M. Cohen, Beiträge zur Altertumskunde 355, Berlino-Boston, 632-647, [online] https://doi.org/10.1515/9783110283846-035 [consultato il 05/06/2025].
Marano, G. (2022): “Objets dans les séquences onomastiques divines : présentifier dieux (et) choses en Syrie du Nord”, Mythos, 16, [online] https://journals.openedition.org/mythos/5796 [consultato il 05/06/2025].
Marano, G. (2023): Portraits onomastiques de Zeus au Proche-Orient (IVe s. av. n.è. – IVe s. de n.è.) : contextes, appropriations, agents, thèse de doctorat, Université de Toulouse Jean Jaurès-Universität Münster.
Nehmé, L. (2011): “Note sur deux “autels” de Hégra”, in: Rondot, V., Alpi, F. e Villeneuve, F., ed.: La pioche et la plume. Autour du Soudan, du Liban et de la Jordanie. Hommages archéologiques à Patrice Lenoble, Passé-présent, Parigi, 45-54.
Petrantoni, G. (2015): Corpus of Nabataean Aramaic-Greek Inscriptions, Antichistica. Studi orientali 11, Venezia.
Pisano, C. (2011): “Satira e contro-storia nel De Syria Dea di Luciano”, Mythos, 5, 117-130.
Ribichini, S. (1999): “Rileggendo Filone di Biblo. Questioni di sincretismo nei culti fenici”, in: Bonnet C. e Motte, A., ed.: Les syncrétismes religieux dans le monde méditerranéen antique. Actes du Colloque international en l’honneur de Franz Cumont, à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort (Rome, Academia Belgica, 25-27 septembre 1997), Bruxelles-Roma, 149-177.
Rosso, E. (2016): “Isotheoi timai. Les empereurs, les « honneurs divins » et leur refus, entre Orient et Occident”, in: Bonnet, C., Pironti, G. e Pirenne Delforge, V., ed.: Dieux des Grecs, dieux des Romains. Panthéons en dialogue à travers l’histoire et l’historiographie, Artes 5, Bruxelles-Roma, 211-228.
Seyrig, H. (1932): “Antiquités syriennes”, Syria, 13(1), 50-64, [online] https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_1932_num_13_1_3662 [consultato il 05/06/2025].
Teixidor, J. (1977): The pagan god: popular religion in the Greco-Roman Near East, Princeton, [online] https://www.jstor.org/stable/j.ctt13x140z [consultato il 05/06/2025].
Vernant, J.-P. (1974): Mythe et société en Grèce ancienne, Textes à l’appui: Histoire classique, Parigi.
Yon, J.-B. (2002): Les notables de Palmyre, Bibliothèque archéologique et historique 163, Beirut.
Notes
- Eco 2010, 45.
- Bettini 2012, 21.
- Rimandiamo all’introduzione al presente volume per una discussione teorica.
- Tale è l’approccio del Progetto ERC MAP 741182 (Mapping Ancient Polytheisms. Cult epithets as an interface between religious systems and human agency) coordinato da Corinne Bonnet all’Université de Toulouse Jean Jaurès tra il 2017 e il 2023 e all’interno del quale ho svolto la mia ricerca dottorale sui nomi di Zeus nel Vicino Oriente antico (Marano 2023).
- Gernet & Boulanger [1932] 1970, 222‑230.
- Pérez Yarza & Bonnet 2024, 759-779.
- Leriche 2003, 171-191; 2010, 23-40; 2020, 632–647.
- Bertolino 2004, BA.F1.02 (= DBMAP, S#1102).
- Su Nemesi, vid. Bonanno 2023.
- Dirven 2022 [https://journals.openedition.org/mythos/5538]. L’elemento onomastico nmsys, utilizzato nell’iscrizione di Dura-Europos dalla parte di un palmireno è attestato anche sul Jebel el-‘Abiad, 50 km a nord-est di Palmira. Qui la dea è raffigurata su un altro bassorilievo ed è accompagnata da numerose altre divinità locali della città. Difatti, due uomini sono i dedicanti lbl wbʿšmn [wʿglbwl wlml]kbl wlʿštrt wlnmsys wlʾrṣw wlʾbgl ʾlhy ṭbyʾ[wskry’], ossia “per Bel e Bashmin, e Aglibol, e per Malakbel, e per Ashtart, e per Nemesis, e per Arsu, e per Abgal, divinità buone e caritatevoli”, vid. PAT 1568 (= DBMAP, S#2697). Dirven 1999, 68, da cui dipende la nostra descrizione iconografica.
- Tuttavia, l’interpretazione di tale gesto rimane insidiosa e dubbia.
- Dirven 2022 contra Invernizzi 1989.
- Infra, par. 2.2.
- Charpin 2010, 82.
- Vernant 1974, cap. 5.
- Lo riteneva a giusto titolo già Seyrig 1932, 50-64, almeno per il caso di Dura-Europos.
- Bonanno 2023, 270-271. Ricordiamo anche un passo di Macrobio in cui Nemesi non è altro che la potenza del Sole, solis potestas (Sat., 1.22.1: “Ma torniamo a discorrere del molteplice potere del Sole. Nemesi, invocata contro la superbia, che altro è se non il potere del sole?”).
- CIL VI, 710, +30817 (= DBMAP, S# 13867).
- Andrebbe infine indagato il peso degli ateliers locali nella scelta, composizione e realizzazione delle offerte. Lo stile, difatti, non si discosta di molto dagli altri prodotti dureni dello stesso periodo. La scelta di tali iconografie potrebbe dunque appartenere non solo o non in toto all’autore della dedica e, dunque, committente del documento. Sull’artigianato palmireno e dureno vid. Brody & Hoffman 2011.
- Amm. 14.25.
- Gawlikowski 1990, 101-103.
- Ne è un caso emblematico un testo che racconta la storia dell’invenzione dell’arte divinatoria, la quale sarebbe stata offerta dagli dèi Šamaš e Adad al re di Sippar, Enmeduranki, che l’avrebbe a sua volta tramandata agli uomini di Sippar, Nippur e Babilonia, vid. Lambert 1967, 126-138.
- Tuttavia, Apollo condivide un legame speciale con Helios, via il dominio solare.
- Bertolino 2004, BA.N 7.01 (= DBMAP, S#1399).
- Dirven 1999, 212-218.
- Euseb. PE. 1.10.7: Αὗται δὲ ἦσαν αἱ ἐπίνοιαι τῆς προσκυνήσεως ὅμοιαι τῇ αὐτῶν ἀσθενείᾳ καὶ ψυχῆς ἀτολμίᾳ. εἶτά φησιν γεγενῆσθαι ἐκ τοῦ Κολπία ἀνέμου καὶ γυναικὸς Βάαυ (τοῦτο δὲ νύκτα ἑρμηνεύει) Αἰῶνα καὶ Πρωτόγονον, θνητοὺς ἄνδρας, οὕτω καλουμένους· εὑρεῖν δὲ τὸν Αἰῶνα τὴν ἀπὸ δένδρων τροφήν. ἐκ τούτων τοὺς γενομένους κληθῆναι Γένος καὶ Γενεάν, καὶ οἰκῆσαι τὴν Φοινίκην· αὐχμῶν δὲ γενομένων τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν ὀρέγειν πρὸς τὸν ἥλιον. τοῦτον γὰρ (φησί) θεὸν ἐνόμιζον μόνον οὐρανοῦ κύριον, Βεελσάμην καλοῦντες, ὅ ἐστι παρὰ Φοίνιξι κύριος οὐρανοῦ, Ζεὺς δὲ παρ’ Ἕλλησιν. Tradotto sulla base dell’edizione francese di J. Sirinelli ed E. Des Places.
- Hdt. 1.131.
- Vid. Ribichini 1999, 149-177; Rosso 2016, 215-216; Delalonde 2021, in particolare il cap. 5 sull’interpretatio.
- Marano 2023.
- Vid. l’articolo di Le Bihan 2012.
- Suda, s.v. Θεύς Ἂρης˙ τουτέστι θεός Ἂρης, ἐν Πέτρᾳ τῆς Ἀραβίας. σέβεται δέ θεὸς Ἂρης παρʼ αὐτοι̃ς˙ τόνδε γάρ μάλιστα τιμω̃σι. τὸ δὲ ἄγαλμα λίθος ἐστὶ μέλας, τετράγωνος, ἀτύπωτος ὕψος ποδω̃ν τεσσάρων, εὖρος δύο˙ ἀνάκειται δὲ ἐπὶ βάσεως χρυσηλάτου. τούτῳ θύουσι, καὶ τὸ αἷμα τω̃ν ἱερείων προχέουσι καὶ του̃το ἐστιν αὐτοι̃ς ἡ σπονδή.
- Camodeca 2006, 269-287. Sulla fortuna delle divinità siriane nel Mediterraneo occidentale rimandiamo al contributo di A. Kubiak-Schneider nel presente volume.
- Marano 2022.
- Jarry 1968, n° 161.
- Petrantoni 2021, 15 con una bibliografia completa sull’iscrizione.
- Littman PPAES IVA, 35; Teixidor 1977, 85-86.
- RES 676 (= DBMAP, S#11817).
- RES 83 = (DBMAP, S#11335).
- CIS II, 218 = (DBMAP, S#11255).
- Dentzer-Feydy et al. 2007, 43.
- Nehmé 2011, 45-54.
- Sui notabili di Palmira, vid. Yon 2002.
- IGLS XVII, 145.
- Sulle iscrizioni bilingui asimmetriche rimandiamo all’articolo di G. Benedetti nel presente volume.
- Rimandiamo per questo a Bonnet 1988; 2014.
- Gubel et al. 2002, 32, n° 8; IGLS VII, 4001, 25-26, nonché Bonnet 2015, n. 73 con una bibliografia recente.
- Briquel-Chatonnet 2012, 619-638.
- Bonnet 2015, 131.
- Vid. Pisano 2011, 117-130.
- Luciano, DDS 35.