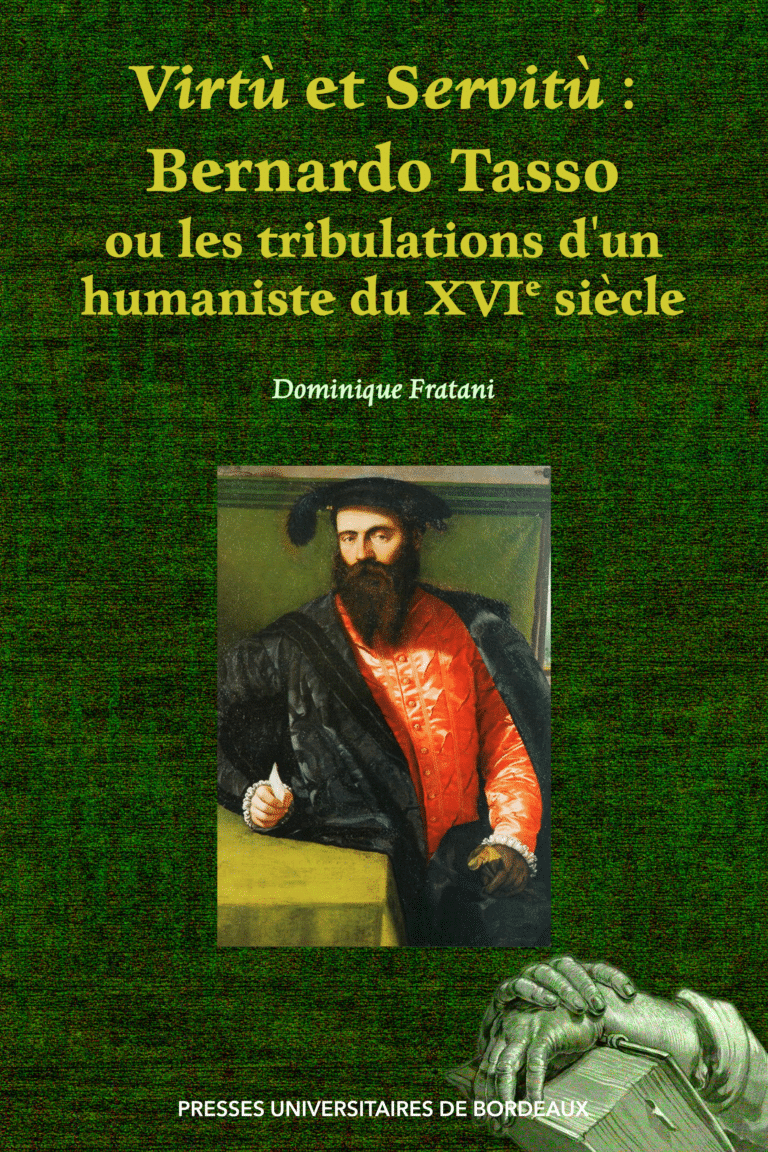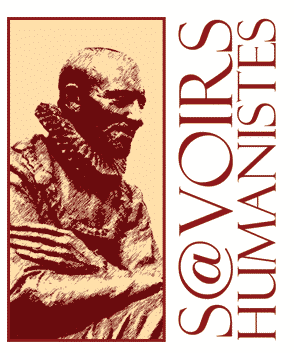Les lettres qui figurent ci-après illustrent quelques-unes des problématiques abordées au cours de cette étude. Elles sont extraites du premier et du deuxième recueil épistolaire, mais aussi des Famigliari de Comino, des lettres à Marc Antonio Tasca, des inédits de Campori et de Ravelli, ainsi que des Archives royales de Parme, afin de permettre la consultation de textes parfois plus difficilement accessibles que les éditions de Rasi et Chemello. J’omets volontairement de transcrire un ou plusieurs des textes mis au jour par Panizza, car ils nécessitent une connaissance détaillée de la période au cours de laquelle Henri II envisageait une nouvelle descente dans la Péninsule et feront l’objet d’un travail ultérieur. Les lettres réunies par Giuseppe Bianchini reprennent textuellement celles de Panizza et ne nécessitent donc pas qu’on s’y arrête1. Pour des raisons différentes, celles publiées par Portioli2, qui relatent la dernière période de la vie du Tasse, ne sont pas non plus prises en considération.
Volume I
A Guido Rangone3
Illustre Signor mio,
Non senza dispiacere ho intesa la causa che vi muove e la vostra deliberazione di partirvi da quella eccelsa Repubblica. La causa è assai leggiera, la deliberazione poco prudente; e se non è maggior causa ne l’animo vostro, ne l’ambizione e nelle [sic] speranze, le quali il più delle volte gli animi nostri sogliono ingannare, a parlarvi chiaro, voi ancora ne sarete tenuto per leggiero. Mi duole estremamente che le lettere mie non siano state di tanta auttorità appò voi che vi abbiano fatto mutare opinione; il che doveva fare, se non la prudenza de le loro ragioni, almeno la sincerità della mia fede. Piacemi che sforzato, non volontario è stato il mio consiglio, che altrimenti di fedele e amorevole, arrogante e temerario forse giudicato ne sarei. Et perché conosciate che io sono più pronto a servirvi che non sono stato a consigliarvi, vi dico che io ho parlato col Gran Maestro e con la maggior reputazione e dignità vostra che io ho potuto, attaccato la prattica. Desidererei più tosto che il loro bisogno avesse pregato voi, che la vostra volontà pregato loro. E perché vedo la qualità del negozio e conosco la maniera di queste genti, dubitando, non succedendovi con quella reputazione che vorreste il vostro desiderio, non diate più tosto la colpa alla mia negligenza e alla mia fede che al poco bisogno e giudizio loro, per levarvi ogni sospizione che v’avesse potuto portare ne l’animo l’aver io cercato di rimovervi da questa opinione. Vi prego quanto più caramente posso che vogliate mandare un uomo alla corte per questa prattica, al quale tutto quell’aiuto, quel consiglio, quel favore, che potrà darli la mia poca auttorità, darò io tanto volentieri, quanto volentieri vorrei che non me n’avesse data occasione. Fatelo Signor mio; così Dio vi ponga in cuore ciò che più d’utile e d’onore vi debba arrecare. Ma poi che una volta ho i termini della vergogna trapassati, non mi curo che mi tenghiate per presontuoso se, di nuovo e contra vostra voglia, vi ricorderò le parole che disse Cicerone a Lentulo, sperando che l’auttorità, la prudenza e il consiglio d’un tanto uomo, in ogni età maravigliosissimo, dal vostro proposito vi possa rimovere; le quali sono tali; «Non sono quegli uomini nel governo della Repubblica famosi da laudare, i quali quasi ostinati stanno di continuo in una opinione; ma sì come è proprio del nocchiero alle voglie della tempesta ubidire, eziandio che li vieti di pigliare il porto, fin tanto che il vento prospero e il mar piano, mutata la vela, ve lo conducano, così è cosa indegna d’un uomo prudente piuttosto un cominciato camino con pericolo seguitare, che per un altro caminando aggiungere alla meta del suo desiderio». Tale o simile è la sentenza delle parole sue, le quali, se col giudizio della ragione considererete, del nocchiero voi, della nave la vostra volontà facendo, forse ne caverete qualche frutto. Il che, se averrà, io sarò contento quella obligazione ch’io non ho potuto avere a me averla a Cicerone. State sano e perdonate a la mia libera natura. Di San Germano4.
Alla medesima [marchesa di Pescara]5
La lettera di Vostra Signoria, piena d’amore e di carità, ha destato nell’animo mio alcuni spiriti di virtù e di religione e, se così fusse pronta la carne com’è lo spirito, io sarei così presto ad ubidirvi come voi amorevole a persuadermi. Ma questo spirito, dalla massa della terra che lo circonda aggravato, non può senza l’aiuto del suo redentore sollevarsi dalle miserie di questa vita e da i falsi piaceri di questo mondo. Io cerco quanto posso di spogliarmi di questi mondani desideri, d’uccider queste vane speranze che, a guisa di sirene, col dolce canto delle lor fallaci promesse, ne tirano ne’ legami delle loro volontà, ma non vagliono a tanto le forze mie ed è di mestieri che Quello che col suo preziosissimo sangue lavò le nostre colpe e ne cavò della servitù del peccato e della morte mi porga anco la mano del suo favore e della sua grazia e mi sollevi del fango dell’umane calamità e, come sua creatura che crede e spera nell’infinita bontà sua, rompa questi lacci che la carne ad ogni ora tende contra lo spirito e, col lume della sua grazia, sgombri tutte le nebbie del peccato che adombrano il sereno di questa anima poverella che, ad ora ad ora, l’ali dimenando, cerca d’uscir di questo fango e d’indrizzar tutti i suoi pensieri e le sue voglie a Quello che l’ha creata. Voi che sete in grazia di Dio, siatemi così liberale, ora e per l’avvenire, del vostro aiuto e del vostro favore, come sete stata per lo passato delle vostre facultà e, continuando in quest’ufficio, mostratemi la strada per la quale così secura caminate all’eterna salute e pregate Colui che vi scorge per questo camino che, con la voce della sua pietà, mi chiami, e non vi sdegnate se, per l’orme della vostra virtù, seguitando i vostri passi, vi verrò dietro. Io farò quell’inno che mi commandate, se pur mi verrà fatto ch’io sodisfaccia al vostro giudizio e al mio desiderio. Vivete lieta, Signora mia, e pregate Dio che mi faccia degno della grazia sua. Di Salerno.
All’Abbate Peres6
Questa mattina, signore Abbate mio, date mi furono le vostre lettere, tanto piene d’umanità e di cortesia quanto d’uno intenso desiderio di virtù. Di quelle, infinite grazie vi rendo con le parole poiché non posso con gli effetti; di questo, mi rallegro con esso voi e vi essorto a seguitare il vostro proposto viaggio e a caminare per questo sentiero della virtù, ricordandovi che rari quelli sono, i quali con la scorta del desiderio per questo calle caminano, che non aggiungano alla bramata meta dell’immortalità. Né vi sgomenti l’asprezza e le altre molte difficultà che, nel principio di questa strada, vi si appresentano, che non vi debbono potere spaventare le fatiche, per lunghe che siano, poiché la mercede che vi si promette dalla virtù non è fragile, breve né caduca, ma salda, stabile e eterna. Anzi, preponendo alle vostre faticose vigilie e studiose fatiche un premio così nobile, così glorioso, com’è l’eternità del vostro nome, vincete con questa speranza e con la ferma deliberazione dell’animo vostro tutti i travagli e i disagi che vi vengono ad incontrare, tenendo sempre fermi gli occhi del vostro pensiero a quel fine che nell’animo proposto v’avete, accioché le lusinghe del sentimento non v’allettassero e volgessero incautamente a caminare per lo camino della volontà7, il quale, eziandio che nel principio sia ampio, piano, agevole, tutto verde e tutto fiorito, al fine, l’uomo conduce nelle oscure tenebre della morte e dell’oblivione. Non sapete voi che la virtù è una donna illustre, reale, invitta e infaticabile? e che la volontà8 è vile, bassa, servile, timida e debile? e che la stanza di quella è ne’ tempii, nelle republiche, ne gli esserciti, fra l’arme, fra il fuoco, ne’ pericoli e nelle morti? e di questa, nelle cocine, ne’ bagni e ne gli altri luoghi, i quali nominare non si potrebbono senza rossore; dove, quasi vergognosa di lasciarsi vedere, il più delle volte si nasconde? quella bagnata di sudore, carica di polvere, con un color vivo e ardente, sempre più forte e più gagliarda si ritrova; questa di vino e d’unguenti molle, pallida e di fuco macchiata, allor che più diletto seco porta, ci vien meno? Seguitate adunque il cominciato viaggio, nel quale vorrei che migliore e più secura scorta che io non sono di seguitare vi aveste proposto, accioché a voi non avenga sì come al cieco dall’altro cieco guidato alle volte suole avenire. Nondimeno, qual’io mi sia, caro sovra modo mi sarà che mi venga occasione di potervi utile e onore fare; sì per pagare quel debito che io tengo alla affezione che mostrate di portarmi e alla opinione che avete di me (segno più tosto di vero amore che di purgato giudizio), come per non essere ingrato alla natura, la quale non mi ha dato questo dono dello intelletto (benché picciolo sia), perché a guisa che fa l’avaro il suo tesoro, per me solo chiuso e guardato lo tenga lungamente. State sano. Di Sorrento.
A Messer Marc’Antonio Flaminio9
La speranza che in Fiorenza mi diede la molta cortesia di Vostra Signoria di venire ad onorar la casa mia e a pigliar la possessione di questo animo, già tanto tempo affezionato e devoto delle vostre virtù, ha causato che prima, come era mia volontà e mio debito, non v’abbia io scritto, desiderando più tosto da le vostre parole piene di dottrina e di bontà ricevere consolazione, che con le mie sciocche lettere darvi fastidio. Ma poiché dal fine del mio desiderio mi veggio tanto lontano, voglio, se voi alle voglie mie non potete compiacere, io almeno al debito mio sodisfare; accioché voi, conosciuto l’amore e l’osservanza ch’io vi porto, conosciate ancora che sete tenuto d’amarmi e vi ricordiate, qual’or da cotesti negozi ardui e di molta importanza disobligato sarete, di venire ad osservare la vostra promessa e al mio ardente desiderio sodisfare, il quale è tanto maggiore quanto è maggiore la commodità ch’io avrei di potermi godere della vostra virtuosa e utile conversazione, per avermi io (mercè della gratitudine e liberalità del prencipe mio) levato dal collo il duro giogo delle occupazioni e per esser tornato a gli studi miei con tanta quiete e tranquilità di mente, quanta sopporta la miseria di questo secolo. E piacesse a Dio che, sì come già alcuna vostra poetica composizione mi proposi d’imitare, or la vostra vita d’imitare mi proponessi, e così questo come quello ben fatto mi venisse, che dove di quello una falsa e breve gloria ho pensato d’acquistarmi, di questo una vera e eterna sperarei di guadagnare, ma l’uno seppi fare, l’altro non vaglio. Io mi sforzo quanto posso da questi caliginosi e terreni pensieri, da queste brutezze del mondo sollevandomi, gli occhi della mente di purgarmi; accioché purgati in quel divino lume del sole io gli possa indrizzare; sperando che quella infinita luce, veduta la purità della mia vista, illumini lo intelletto e qual sia la differenza da questo ben finito a quello infinito mi faccia conoscere; non per conoscerlo solo, ma per amarlo sommamente, ma sin’a questa ora degno di tanto dono conosciuto non mi sono e dubito che (come dice Platone) a volermi congiungere a quelle forme dalla materia separate, l’intelletto da questa carne in que’ due modi che egli nella sua divina epistola dipinge, del tutto sia di mestieri di separare. La qual cosa, per molto che di fare affaticato mi sia, non ho potuto né potrò, se la mano dell’infinita grazia del Signor da questo fango non mi solleva. Beato voi, che in questo secolo di tempeste pieno, con la compagnia di pocchi in porto vi ritrovate, dove del frutto della vostra dottrina godendo, quelle cose trattate e considerate, l’uso e la dilazione delle quali a tutti gli umani piaceri anteporre si dee. Pregovi che quella fragile navicella della fede, nella quale voi con tutti i buoni, quasi come uno de i più savi nocchieri alla poppa sedete, dal fiato de’ venti contrari e dal tempestoso mare dell’eretica confusione, insieme con gli altri con la vostra virtù vogliate difendere; acciò noi altri col vostro essempio, la vita a bellissimo corso dirizzando, dalle tenebre alla luce con le vostre fatiche siamo sollevati. Ma perché più lunga scrittura più tosto fastidio che piacere vi porterebbe, a Vostra Signoria di tutto cuore mi raccomando, pregandovi che al Magnifico Priuli mio antico e meritissimo Signore, degniate in mio nome di basciar le mani. Di Sorrento.
Al Signor Girolamo Morra10
So bene che il sinistro accidente di questa giornata darà occasione a gli emuli dell’Eccellenza del Signor marchese, con le parole dell’invidia e della callunnia d’accusarlo e di riprenderlo, ma non con quelle della ragione e della verità. I successi della guerra (come per altre mie ho scritto) furono in ogni tempo dubbiosi, né fu mai sì prudente, né sì valoroso capitano che d’una battaglia si potesse promettere certa vittoria, nella quale ha il più delle volte maggior parte la fortuna che la virtù. Al mio giudizio, dee rimaner senza colpa e senza biasimo quel capitano che, necessitato di combattere, ordina bene l’essercito suo, dispone cautamente le genti, piglia buona occasione del combattere, si guadagna l’avantaggio del loco e che, nella disperazione della vittoria, avventura la persona sua accioché il suo pericolo dia animo agli altri di fare il medesimo. Queste e altre cose, degne d’un savio capitano, ha fatte sua Eccellenza senza pretermetterne alcuna, né mi pare che sia obligato a più salvo se la colpa della viltà de’ soldati non si dee chiamar sua. Io tengo per fermo che sì come egli ha saputo ben ordinare e disporre le genti, avesse potuto dar loro cuore e animo, l’avrebbe fatto, ma se la fortuna e Dio non ha voluto darlo loro, non può far altro se non attristarsene e dolersene. E a chi volesse dire che si conviene al prudente capitano di conoscer se i suoi soldati temono la giornata o la desiderano e fuggirla e procurarla secondo che fusse necessario, risponderei che niuno essercito si mostrò mai tanto volontoroso di combattere quanto questo. E chi averebbe creduto che quelle genti che, altre volte, hanno sì valorosamente combattuto e datoci tante vittorie, dovessero, senza veder faccia alcuna di pericolo, volgere le spalle? Voi sapete ch’io non ho tanta obligazione al Signore marchese che dovessi far questo ufficio per difenderlo; ma ancor che fusse nimico mio, vorrei dire la verità e io mi contenterei, se la fortuna o la mia virtù mi ponesse di questi carichi su le spalle, sempre che mi accadesse qualche sinistro, di perdere così felicemente. Tutto l’essercito ha veduto il suo merito e l’altrui colpa; però senza dirne altro, scrivendovi particolarmente il successo, mi tacerò; del quale mi rendo certo che di già ne saranno venuti gli avisi, ma si confusi che non averanno portato nulla di vero.
Già ho scritto per l’altre mie come Sua Eccellenza, astretta dalla necessità del danaio, il quale le mancava per pagare più lungamente questo essercito, si era risoluto di soccorrere Carignano e, non potendo altrimenti arrischiarsi alla giornata, parendole men male con una nuova occasione e con buon ordine avventurando di vincere perdere, che perdere al securo senza far prova di vincere e, per questo effetto, essendosi Sua Eccellenza partita d’Asti e noi da Montechiaro, si venne alla Montada, loco vicino a’ nemici sei miglia, dove impediti dal tempo, il più tempestoso che si sia veduto di molti anni – quasi presagio di questa nostra disgrazia –, siamo stati fin’al giorno di Pasqua. E, avendo egli dissegnato di fare quel giorno uno alloggiamento a Somma Riva del Bosco, fece marciar l’essercito, ma impediti dalla difficultà del camino, ci fu bisogno, per fuggire gli inconvenienti che sogliono succedere nell’alloggiar di notte, fermarsi a Ceresola. Quella sera, si fece una bravissima scaramuzza. L’altra mattina, avendo notizia Sua Eccellenza che [i] Francesi s’apparecchiavano al combattere, ordinò l’essercito e divise le fanterie in tre battaglie; dell’una pose gli Spagnuoli che erano da mille e cinquecento in due mila co i mille Alamanni del colonello Barone; nell’altra i sei mila Alamanni del Signore Aldiprando; nella terza, gli Italiani che erano poco meno di quattro milla. La cavalleria, che era da ottocento in mille cavalli, divise medesimamente in tre parti e da ogni una delle tre battaglie della fanteria, ne pose una per farle spalla. A le dodici ore si cominciò una grosissima e gran scaramuzza, la qual durò fino alle sedeci. E, avendo già [i] Francesi pigliate alcune bellissime case sovra certi colli, dove per avventura dissegnavano loro di porre artiglieria per battere lo essercito nostro, Sua Eccellenza in una parte vi mandò Gottieres Chesada e Don Giovanni de Ghevara con quattrocento archibuggieri spagnuoli e, nell’altra, il Signor Antonio Maria Sanseverino con alcuni altri capitani italiani a levarli di quel forte, i quali a colpi d’archibugiate ne gli cacciarono e guadagnarono i colli, né per molto che s’affaticassero poi [i] nemici di racquistargli, poterono mai. Scaramuzzato che s’ebbe sì lunga ora tanto strettamente che era un orrore a rimirarlo, da tutte due le bande si appresentò la giornata. Allor la battaglia de gli Spagnuoli co i mille Alamanni ruppe quella de gli Italiani e d’una parte de’ Svizzeri e tanto innanzi si spinse che, non pur prese l’artiglieria, ma avrebbe ancor presa Carmagnola se dalla viltà de’ nostri non fusse stata richiamata. In quel punto, la vittoria che fino allor batteva l’ali sopra le nostre insegne, pentitasi dalla grandezza del Signore marchese, s’accompagnò con le schiere nemiche, conciosiacosa che la battaglia de gli Alamanii, nella quale stava la maggior parte della nostra speranza, essendosi rincontrata co i Guasconi, che non arrivavano a cinque mila, al primo abbassar delle picche, non pur s’incominciò a ritirare, ma a fuggire. La cavalleria, tutto che il prencipe di Sulmona, il Signor Ridolfo Baglioni, il Silna e il Signor Carlo Gonzaga valorosissimamente combattendo facessero ogni opera perché essa ancora menasse le mani, non pure volse mostrar la fronte, ma nel fuggirsi fu per rovinar le nostre battaglie. De gli Italiani, eziandio che la maggior parte il prencipe mio Signore, per esser eglino archibugieri, avesse sbandata, perché a loro toccò il sostentare la scaramuzza, la quale durò per tanto tempo, quel poco corpo che vi era rimaso, che non arrivava al numero d’ottocento uomini, si difese valorosissimamente dall’impeto della cavalleria nemica che venne ad investirli; di maniera che non ebbe forza di movergli dall’ordine loro, anzi, senza alcun segno di timore né di viltà, stettero sempre fermi a apparecchiati a combattere quall’ora loro fusse commandato, innanzi la cui battaglia Cesare di Napoli mostrò grandissimo valore. Vedendo l’Illustrissimo Signor marchese che la fortuna de’ nemici combatteva con la sua virtù e con la viltà de’ cavalli nostri e de gli Alamanni, poiché più volte in vano gli ebbe e con persuasioni e con l’essempio della persona sua invitati a combattere e procurato di far loro volgere il volto, ferito d’una mazzata nella man manca e d’un’archibuggiata sopra il ginocchio diritto (non però di momento) per non perdere ogni cosa insieme si ritirò in Asti; e tengo per fermo che se non fusse stato soccorso da’ suoi, sarebbe stato o prigione o morto. Perché, avendosi nel principio della giornata posto fra le due battaglie de gli Spagnuoli e de gli Alamanni, vedendosi tor così certa vittoria di mano e la faccia della battaglia cambiatasi per la viltà di quelli ne’ quali più si sperava, quasi desideroso di perdere insieme con la vittoria anco la vita, due o tre volte entrò nelle schiere nemiche con tanto animo che a fatica si potè ritirare. Il prencipe mio che, quasi primo feritore di quella giornata, aveva già combattuto con Monsignor di Thermes, generale de i cavalli leggieri del Re, vedendo che il corpo de gli Italiani non era atto a sostentar cotanto peso, giudicando che più servizio sarebbe a Sua Maestà salvando queste genti col ritirarle che perdendole col menarle a combattere, raccolta l’archibugieria, che tutto il giorno avendo animosamente scaramuzzato era sparsa per quelle colline, si pose a retroguardia del campo nostro fuggitivo e, combattendo ora co i soldati, ora co i villani quanto durò il camino, molta ora dopo Sua Eccellenza – essendo già passata gran parte della notte – aggiunse in Asti con quelle povere reliquie dell’essercito. A me pare che la fortuna abbia invidiata la virtù del Signor marchese. Ma sia come si voglia, non si potrà mai dire che egli sia mancato né di prudenza né di valore, né che abbia lasciato di far alcun atto degno di savio capitano e d’animosissimo soldato. Il generale de i cavalli leggieri di Francia, allor che era alle mani col prencipe mio, da uno incontro gittato per terra, fu preso da alcuni fanti italiani e lo abbiamo prigione in casa. Viva lieta Vostra Signoria e dolgasi delle nostre disaventure. D’Asti.
Volume II
A Messer Gio. Battista Giraldi11
La continua guerra che da cinque anni in qua mi fa la malignità de la fortuna mia, senza mai darmi pur una brevissima triegua, m’ha fatto tanto tardare a dar risposta a le lettere di Vostra Signoria piene altrettanto di cortesia quanto di dottrina e tutte a guisa di fecondo prato d’aprile sparse di vari e vaghissimi fiori di erudizione. Certo ch’io mi sento d’aver fatto un grand’acquisto avendo ristretta l’amicizia ch’io aveva con voi, dal tempo, da la lontananza e da gli accidenti del mondo se non del tutto sciolta, almeno rallentata; e poi che con lo scrivervi alcuna volta faccio tanto guadagno, mi tornerà a grandissimo utile lo scrivervi spesso, il che farei se i rabbiosi venti de la mia nemica fortuna non travagliassero senza riposo alcuno la conquassata e fragile barchetta de l’animo mio, da’ quali per molto che in mio favore s’opponga il consiglio de la ragione, non mi posso difendere né schermire sì che a le volte da l’ondoso flutto de la sua malignità non mi veggia sommerso. Ma perché non voglio, con la lunga istoria de le mie miserie, fastidirvi, passerò ad altro. Io pregai al partir suo di qui Messer Ambrosio, che volesse conferir con Vostra Signoria alcuni dubbi che, ne la publicazion di questa opera mia, mi danno molestia affine che il chiaro sole del vostro giudizio sgombrasse ogni nebbia di dubbitazione che mi potesse l’animo molestare; e poi ch’egli per avventura, per dimenticanza, non ha fatto quest’ufficio, avendo risguardo a le vostre e publiche e private occupazioni, uno solo ve ne dirò per non darvi tanto fastidio de li molti che forse di scrivervi necessario mi sarebbe; ed è questo che, essendo questo mio poema diverso da l’epico ne la disposizione e ne l’artificio, ragionevol cosa anco mi pare che debba esser differente nel titolo e che si convenga che il titolo corrisponda a la preposizione, perché il voler li epici scrittori solamente ne la maniera del titolo imitare e nel resto dell’artificio essergli differente, mi pare da ogni ragione lontano e crederei che fosse bene che il titolo a la proposizione de l’opera conforme fosse e, sì come essa più cose propone, così anch’egli, quasi suo interprete o messagiero a li lettori, più cose promettesse; fondandomi più tosto sovra i saldi argomenti de la ragione che sovra i deboli puntelli de l’usanza né su l’auttorità de’ passati scrittori – ch’eziandio che il vostro dottissimo e non mai a pieno lodato Messer Lodovico Ariosto non l’abbia osservato, potrebbe essere stato per in advertenza o per la imperfezione de la nostra natura, la quale non consente che l’umane operazioni siano da ogni parte perfette – ma perché come in molte altre cose, così ancora in questa mi potrei ingannare, desidero (se molesto non vi sarà) che me ne scriviate il vostro parere.
Io scrivo un’oda a Vostra Signoria la quale, nel fine, risponderà a quella parte de la lettera, che parla del vostro poema. Restami solo di ringraziarvi de l’amorevol ufficio che fate con esso meco, dolendovi de le mie adversità e dandomi con molte ragioni quella medicina che da sì dotto e eccellente filosofo si poteva desiderare. Le lettere stampate mi sono state carissime, eziandio che per vostra giustificazione presso di me non fossero necessarie. Io avrei data la vostra a Messer Benedetto Egio, come mi comandate, ma non la trovai nel plico.
Vivete felice e non vi sia grave di raccomandarmi a l’eccellente mio compadre Messer Pauolo di Lione. Di Roma, il III di luglio del LVI.
A Messer Vincenzo Laureo12
Io ebbi le di vostra Signoria de li cinque del presente, piene d’una infinita affezione, di molta prudenza e quasi una vera imagine d’un animo tutto composto di virtù. S’io volesse ringraziarvi sempre che da voi ricevo piacere o beneficio saria di mestieri ch’io di continuo tenesse la penna in mano, poi che voi con continuati uffici di cortesia e d’amorevolezza a questo fare m’obligate; ma perché so che a ciò non vi move speranza di premio ma solo sovrabbondanza di virtù, affine che il mio obbligo sia sempre integro e il vostro merito sempre maggiore, non possendo pagarvi con gli effetti, non vo manco pagarvi con le parole. Io ringrazio Monsignor Illustrissimo de la cortese e liberale profferta che Vostra Signoria mi fa in nome suo e son certo che, se le molte spese estraordinari di quest’anno lo consentissero, che l’offerta sarebbe maggior e conforme a la grandezza de l’animo suo e voglio averle quell’obbligo, considerata la qualità dei tempi, che se m’avesse donato mille scudi; e tant’è maggiore la mia obligazione quanto che nullo mio merito, né servizio fatto a Sua Signoria Illustrissima, a ciò fare l’ha potuto movere. Volesse Dio che questi cento scudi fossero bastanti a condurmi in Avignone13, ch’or ora mi porrei in camino. Ma con che onore mi potrei io partir d’Italia, e specialmente di qui, senza pagar i miei debiti? Lascio di dirvi che non stampando il mio poema adesso, sarei constretto di ritornar per sì lungo camino in Italia con grandissima spesa fra pochi giorni. Più vergogna mi sarebbe a lasciar tanti amici che, cortesissimamente, m’han sovvenuto ne le mie avversità che lasciar il servizio del prencipe, il qual con tanta ingratitudine ha riconosciuta la mia lunga e fedele servitù e non solo non ha ricompensato ma ne anco mostrato d’aver desiderio di ricompensare in parte il grave danno mio. Signor mio, chi meglio di voi sa l’obbligo del signore e del padrone? s’io credessi ch’il partirmi dal servizio del principe dovesse porre in disputa l’onor mio, non ne parlarei, perché come voi meglio di me sapete, dice Tullio ne gli Offizi, che l’uomo non debba cosa fare de la qual stia in dubbio, se è ben fatta o no. Io son certo d’aver pagata tutta l’obligazione ch’io gli aveva con aver perduta la facultà, la moglie, la quiete de l’animo e de la mia vecchiezza e fatta perder a’ miei poveri figliuoli la robba de la madre, che deveva esser sostegno de la vita loro, per seguir la sua fortuna, e che questo atto sia di tanta forza, ch’essendo io libero d’ogni obligo di fedel servitore oblighi lui come grato padrone al remunerarmi e a l’emenda del danno mio. Che posso io più sperare da lui, se trecento scudi che m’aveva consignati con fede di notari sovra la provisione de la sua compagnia, con certe colorate scuse si ha ritolti? E se la scusa è vera, perché gli ha lasciati a Ferante Pagano? Se la magnanimità di questo prencipe14 e la cortesia di questi gentiluomini amici miei, non m’avessero sovvenuto, come avrei io fatto quest’anno calamitoso, nel quale hanno avuto fatica di viver i ben ricchi? Debbo io più lungamente col volto ogni or rosso di vergogna andar affrontando questo e quello e consumarmi ne gli interessi e ne l’usure per vivere? Io conosco che all’età mia non si conviene nova servitù, la quale non può esser senza fatica di corpo e di mente. So bene che mi parrebbe strano dove soleva esser il primo e il più onorato ne la casa del prencipe, aver da onorarne molti che sarebbono presso al padrone in più stima e di più auttorità ch’io non sono. Considero che, per ragion d’età, la mia servitù non può esser sì lunga che possa sperare remunerazione con la qual mio figliuolo possa sostentar quel grado di gentiluomo nel quale l’ha fatto nascer Dio, ma manco male è far così che sfacciatamente aggravare di continuo gli amici senza speranza di poter pagar il debito. Che posso io sperar d’un prencipe, che da che partì15 d’Italia, non s’è degnato di risponder ad alcuna lettera mia? il qual sol col mostrar con chi parla di me d’amarmi oltremodo e di tenermi in molta stima, cerca di pascermi di vento. Io so che gli pareria esser sgravato d’un grandissimo peso qual’ora intendesse ch’io avessi cominciata nova servitù e se lo recarebbe a grandissima ventura non avendo egli più bisogno di me. Io aspettarò la risposta de l’ultime lettere ch’io scrissi e dapoi mi risolverò e secondo la risposta, o accettarò o ricusarò la profferta di Sua Signoria Illustrissima16 assicurandola che in qual si voglia stato, in qual si voglia fortuna conoscerò l’infinito obligo che io ho a Vostra Signoria e procurerò d’esserle grato. In questo mezo non mancate di conservarmi ne la solita grazia di Monsignor Illustrissimo e vostra e tenetemi per raccomandato a Mons. di Villars, così Dio d’ogni vostro desiderio vi faccia contento. Di Pesaro, il X di giugno, del MDLVIII.
A Messer Benedetto Varchi17
Non so, Eccellente Signor mio, s’in così lungo corso di tempo avrete perduta la memoria de l’affezione ch’io ho sempre portata a la molta vostra virtù. So ben io che, dal principio che in Venezia vi posi nel più onorato loco de l’animo mio, vi sete sempre stato caro e amato ma le continue e varie azioni de la vita mia, che a guisa di nave da diversi venti sospinta questo e quel pelago di mare va solcando, dal servizio del mio ingratissimo signore e da i vari accidenti del mondo trasportato, non ho potuto con continui uffizi tenermi vivo ne la memoria vostra. Ora ch’io son libero da quel servizio del prencipe e d’ogni altro signore, desidero col benefizio di queste mie di rinovar l’amicizia e far che mi conosciate per vostro, come sempre son stato. Et eziandio ch’io sappia che con niuna persona di giudizio, come sete voi, sia di mestieri di giustificare questo mio esilio né la cagione che ora mi move a lasciar il servizio del prencipe, mi gioverà però di scrivervene queste poche parole. Signor mio, io non poteva senza grandissimo biasimo e senza giustissima nota d’ingratitudine, avendolo servito vintitre anni ne la prospera fortuna e trovandomi beneficiato da lui, abandonarlo ne l’adversa, non avendo obligo con la Maestà cesarea, né di vassallaggio, né di feudo, né di fede. Onde per non mancar a l’onor mio, volsi perder tanta facultà, abbandonar la moglie da me sovra tutte le cose del mondo amata, i figliuoli piccioli, tante altre cose che io m’aveva con sì lunghe e onorate fatiche de la mia giovenezza acquistate, per sostegno, riposo e diporto de la mia vecchiezza, sperando pur che, avendo io con questo atto non solo pagata tutta l’obligazione ch’io aveva a Sua Eccellenza, ma di debitore ch’io le era, di molto maggior obligo divenuto suo creditore, che dovesse con liberali e essemplari dimostrazioni riconoscer questa mia tanta fede e, avendo negoziato per lui e segnata la capitulazione con Sua Maestà Christianissima, sendo Sua Eccellenza ritornato da Costantinopoli, parendomi già di vederlo in porto di quiete le dissi; «Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace», e lo supplicai che, non avendo più bisogno di me, sendo egli in stato di salute, mi lasciasse andar a proveder a le miserie de la mia infelice casa e mi volesse dar il modo ch’io potessi viver onestamente con la mia sventurata famiglia. Egli mi fu liberalissimo di questa licenza e, con molte cortesi e affettuose parole, mi promise trecendo scudi d’oro l’anno e di più di procurar con Sua Maestà che mi mostrasse qualche segno di liberalità, sì che potesse onoratamente trattenermi; il che m’osservò un tempo, benché talmente ch’una parte di quei denari ne consumava in interessi e usure. Ho poi perduta la moglie, la quale per dolore di non poter venir a viver con esso meco, per la malignità d’alcuni de’ fratelli, se n’è morta disperata e, con la morte sua, perduti cinque millia scudi de la dote e antifato da’ ministri di Sua Maestà cesarea ingiustamente adiudicati, parte a la corte, parte a’ miei cognati; sentenza veramente troppo severa e empia voler privar un povero figliuolo, che allora aveva dodici anni, della eredità materna perché si nudriva appresso di me. Tosto che l’Eccellentissimo Signor duca d’Alba mosse guerra a Sua Santità, avendo già, al mio partir di Francia, rinunziati a tutti i negozi del prencipe, restituite le ziffre e solutomi di attender a vivere e a li studi miei, mi partì da Roma, e mia ventura – per esser la peste in Venezia dove aveva deliberato d’andare – mi condusse in Pesaro, dove da la liberalità di questo magnanimo duca fui cortesemente raccolto, senza l’aiuto del quale, in questi due anni calamitosi, abbandonato da chi mi doveva, per legge di gratitudine, col proprio sangue sovvenire, sarei caduto sotto il peso de le mie miserie. Poi, vedendo l’ingratitudine del principe e che mi lasciava morir di fame, son stato astretto a chiedergli licenza; e eziandio che non me la voglia dare, sono risoluto in ogni modo di volerla, sperando, ancor che mal volentieri ogn’uno compri cavalli vecchi, che non m’abbia da mancar la grazia di Dio che inspiri qualche prencipe ad aiutarmi. Questo è quanto per giustificazione e sodisfazione mia son stato necessitato di dirvi; perdonatemi s’io vi son stato più molesto di ciò ch’io doveva. […] Di Pesaro, il XV di luglio del LVIII.
Lettere inedite di Bernardo Tasso
a Marcantonio Tasca
Al Magnifico come figliuolo carissimo, il Signor MarcantonioTasca18
Magnifico come figlio onorato. Alle vostre vorrei, come sarebbe mio debito e vostro desiderio, poter risponder con altro che parole; e sovra tutto mi duole ch’io conosco che vi date a credere ch’io possa e non voglia pagarvi. Io vi giuro, M. Marcantonio, e se vi mento ch’io possa morir in disgrazia di Dio e degli uomini e ch’io mi veda questo figliuol morto innanzi, ch’io per viver, oltre quel ch’io son debitore a dei gentiluomini miei amici, oltre trenta ducati ch’io debbo al Mazzola e a Messer Jacopo Rosso, ho in pegno 110 ducati di robbe al Giudeo, talmente che questa settimana, per l’ultimo, non essendomi rimasto altro, ho impegnato un paro di lenzuola. E di che volete ch’io abbia il modo, se son stato appresso a due anni senza aver altro che un quartiero di Francia, del quale non me ne venne in mano che 17 ducati. Quando fui richiesto per nome di questo illustrissimo principe, mi fu dato intenzione che Sua Eccellenza mi darebbe la medesima provisione che mi dava il principe, né perancora – sì perché il Signor duca è stato nel letto invisibile da giugno sino a mezzo ottobre, sì perché sin a pochi giorni si è tardato di scrivere al re cattolico per la mia grazia – non mi è stata specificata, né assignata provisione alcuna, né risoluto in che officio l’abbia da servire; né credo se ne farà altro per quanto mi pare di conoscere, se non dopoi che sarà venuta la grazia di Sua Maestà. E se sin a quest’ora ho avuto un quattrino da Sua Eccellenza ch’io possa vedermi quella figliuola in mano di Turchi. Quelle poche spese son andate a poco a poco mancando per queste carestie, sendo per questa cagione diminuite tutte le spese della casa di sorte che non fu mai in tanta necessità. Sua Eccellenza mi ha promesso del primo quartiero, che gli verrà da Napoli, darmi il modo da stampare il poema; ma posto che mi desse 300 ducati, il che non si crede, senza le figure che disegnava di farvi a ogni principio di canto, mi vi va di spesa 275 ducati, con che ho io poi a vivere in Venezia con due servitori quattro mesi che mi bisognerà starvi. So che mi direte che avete bisogno del vostro, ma che poss’io? Volete ch’io faccia del sangue denari! La necessità non ha legge. Avete usate tante cortesie a’ vostri giorni ed a gente che non ve ne sono state grate né con gli effetti, né con l’animo; non vi aggravi avendo aspettato tanto, aspettar anco quattro o cinque mesi, sin ch’io abbia stampato il poema, col quale solo mi si darà il modo di pagarvi senza punto mancare.
Volesse Dio che potessi per altra via provvedervi, che così sarei presto a farlo come voi a chiedergli; e vi prometto che s’io non avessi sperato di stringer l’amicizia con quel modo che voi sapete, ch’io non mi sarei indebitato con voi di tanta somma; e dal registro delle lettere potrete vedere se l’ho premirato e se ho mai voluto consentire a questo. Magnifico Messer Marcantonio, quella cortesia ch’avete usata tante volte con altri, muovavi per un vostro compatriota de la qualità ch’io sono ad aspettar questo poco di tempo di più e fate di vostra volontà e per nobiltà di natura ciò che la mia necessità vi faria per forza. Il modo non v’è altrimenti, come al passar che farete di qui potrete, se vi piacerà, chiarirvene; che per molte rigorosità che potreste usare non vi potreste pagar di altro che di sangue prima di quel tempo. Io ho aspettato Pre. Gio. né l’ho veduto, né novella di lui. Non vi sia grave di scrivermi la causa di questa sua mutazione e, s’esser può, procurar che venga. Il duca ha scritto gagliardamente per la grazia mia e pregatone Don Gio. Marie e il cardinale Santafiore v’ha fatto e fa caldissimo officio.
Vivete lieto e raccomandatemi al Signor mio compare ed a vostro fratello.
Delle lettere di M. Bernardo Tasso, accresciute,
corrette e illustrate, volume primo. Presso Giuseppe Comino
M. Vincenzo Martelli al prencipe di Salerno19
Io ho fatto sempre professione, poi ch’io mi diedi a’ servigi vostri, Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori, di servirvi del vero e di dirvi quanto m’è occorso per grandezza e quiete vostra; e perché, fra tutte le deliberazioni che voi avete avuto a far fin qui, non è passata a giudizio mio cosa di maggior considerazione che questa d’andar alla corte, m’è paruto come servidor interessato nella vostra grandezza, ancorché senza richiesta alcuna, scrivervi queste poche parole. Se le cagioni che possono persuadervi l’andata fussero pari o poco differenti a quelle che vi debbon dissuadere, io concorrerei che s’usasse da voi questo ufficio pietoso verso la patria vostra e questa gratitudine alla confidenza di questa città verso di voi; ma poiché il frutto può essere poco che da voi e dalla città se ne trarrà e il danno molto – che sarà tutto vostro – mi pare che si vada a manifesta perdita. Non dico del pericolo della vita, del quale pur si debbe far caso in questa stagione, né di lasciar le sue cose imperfette che cominciavan pure a pigliar qualche forma, né della disgrazia del Viceré dalla quale nasceranno mille incomodi alle vostre facultà e mille oltraggi a’ vostri servidori e vassalli; ma sì bene del mettere in pericolo in un medesimo tempo la grazia di Sua Maestà e la vostra stessa riputazione. Perché poi giudice di questa causa ha da esser Sua Maestà, la quale ci è interessata in due modi; l’uno per la riputazione de’ ministri, li quali saranno renduti più deboli da qui innanzi in tutti i suoi servigi, l’altro perché le saranno state dipinte congiure, sedizioni e quasi ribellioni. E queste informazioni avranno già fatto fondamenti saldissimi nella mente di Cesare, sì per non avere avuto contraddizione fin qui, come per essere state porte da persone di credito e d’autorità; non veggo che buon successo se ne possa sperare. Perché chi andrà a questa impresa, bisogna che sia persona d’altrettanta fede appresso del giudice come quelli che l’hanno informato; anzi di tanto più quanto basti a gettare in terra le prime impressioni per poter poi disputar la causa del pari; la quale, ancorché sia piena d’onestà e di giustizia, non mancheranno però ragioni a chi la voglia impugnare. Perché e’ diranno che le novità di Germania hanno avuto il principio da queste sette e che, in questo Regno, non mancan faville per nutrir questo fuoco, e che l’ufficio d’un principe prudente è di rimediare a’ principi. Diranno ancora che da’ ministri di Cesare non s’è mai proposta in questo Regno generale inquisizione ma un modo di persecuzione contra gli eretici soli; cosa non compresa ne’ capitoli passati da Sua Maestà e permessa nondimeno dalle leggi; sicché la dimanda avrà più presto apparenza di grazia che di giustizia e ne seguirà che il Regno abbia voluto violentemente la grazia che si doveva cercar per ogni altra via che tumultuaria. Queste ragioni, dette innanzi a Cesare o allegate da lui medesimo, gitteranno in terra tutte l’altre che fussero portate di qua per molte che potessero essere. Non resterò di dire che a Sua Maestà non piacerà che col valore e con la nobiltà e con la moltitudine de’ vassalli vostri vi sia aggiunto ancora una volontà generale di questo Regno e una confidenza sì grande; perché queste cose tutte insieme pongono negli animi de’ principi timore di novità allo interesse de’ successori e, per consequenza, desiderio di stinguerli per quelle vie che s’offeriscono loro. E voi medesimo sapete che pure è paruto troppo a Sua Maestà aggiugnere alle grandezze vostre una compagnia di gente d’armi; sicché non veggo come, e dalla causa medesima e dal difensor d’essa, non vengano offese l’orecchie di Cesare, al quale non si può persuadere che la disperazione de’ popoli possa fare gran progresso, perché con la fresca memoria della vinta Germania piuttosto s’irriterebbe l’altezza della sua natura, che si placasse. Né vi persuadete poterci andar di consenso né aperto, né tacito, del Viceré, perché si va diretto contro di lui, essendo la intenzion di chi manda e l’uffizio di chi va la conservazione de’ capitoli, dalla quale nasce o la privazione del Viceré o la diminuzione in maggior parte della sua autorità e quasi in tutto della sua riputazione; sicché non c’è mezzo di compiacere all’uno senza estremo dispiacer dell’altro. E pogniamo che non ci fusse in causa né la disgrazia di Cesare, né lo sdegno del Viceré, né il pericolo della vita, né la diminuzion delle facultà, né l’abbandonare i vassalli e le cose sue in preda altrui, né il privarsi de’ suoi diletti, ma che solo restasse la causa nuda d’ottenere, o non ottenere, quel fine per lo quale voi siete mandato dalla città; dico che, se l’otterrete (il che tengo difficile) acquisterete poco nell’opinione di questi popoli a’ quali pare aver tanta giustizia che per essa si son poste l’arme in mano e, per conseguente, pensano che non debba esser loro negata per mezzo vostro. Sicché, ottenendo avrete fatto quel solo perché eravate mandato e che nell’opinion di costoro non ha difficoltà niuna, ma, non ottenendo, vedete in che pericolo vi ponete di stare a giudizio delle genti ignoranti, di non aver soddisfatto alla città, avere offeso il Viceré, non servito a Sua Maestà intrinsicamente; oltre agli altri incomodi che ne sentiranno i vassalli e i servidori e le vostre facultà. E io per me, quand’io credessi, con tutti questi danni e pericoli, n’avesse a nascere il benefizio della vostra patria, sarei di quelli che vi consiglierei a prepor l’utile universale a’ danni vostri particolari, per farvi degno d’una memoria eterna. Ma perché io non veggio dove possa nascere questo benefizio, anzi son d’opinione tutta diversa, ché per aggiugner Sua Maestà alla grandezza dell’altre vostre qualità l’amor di questo Regno, benché tenga animo di fargli qualche grazia, non la farà mai per lo mezzo vostro; anzi, cercherà differirla in altro tempo e mandarne voi male spedito, con poca soddisfazione di quelli che aspettano che e la grazia e la giustizia sia maggiore e più spedita per opera della vostra autorità ch’ella non sarebbe per niun altro mezzo e si troveranno ingannati con danno loro e con diminuzion della dignità vostra; sicché vedendo che anche il beneficio della città con la vostra andata diventa minore, non so conoscere né utilità, né gloria che pareggi il danno e la vergogna che se ne può aspettare. Io fui sempre d’opinione che le forze s’avessero a fare in divertir l’elezione per non avere a venire a questo punto di negare alla città; e ora sono d’opinione che quando si potesse evitar l’andata con colore che abbia dell’onesto, che non si lasci di farlo, rimettendomi però al vostro più saldo giudizio e supplicandovi di perdono della mia temerità.
Delle lettere di M. Bernardo Tasso, accresciute,
corrette e illustrate, volume terzo, appresso Giuseppe Comino20
Al molto magnifico Signor mio osservandissimo, il Signor cavalier Tasso21
Perché io credo che a quest’ora averete ricevuto un’altra mia, ancorché con questa vi replichi il medesimo, sarò più breve, avendo nell’altra scritto di soverchio e parendomi che non sia necessario. Poiché non sete venuto, né avete mandato in questa nuova elezione di Papa a proccurar di ricuperare l’ufficio e già Sua Santità si trova aver confirmato Mattio ed espeditogli il breve, ancorché giudichi non pur difficile, ma quasi impossibile per li molti favori che egli ha, nulladimeno quando vi piacesse di cedermi le ragioni vostre libere, io provarei – se col prometter il mio servizio, il quale so che a Sua Beatitudine non sarebbe ingrato, e coll’oprar l’autorità di tanti padroni ch’io ho in questa corte – movendogli lite di far che la vostra giustizia fosse non solo conosciuta, ma esequita; e farò la lite a mie spese e, in caso che la vinca, io pagherò li trecento ducati e di più mi vi mostrerò grato di sorte che ne rimarrete soddisfatto. Vi potrete risolver subito e, volendolo fare, far la cessione, perché quanto più si tarda a dar principio alla lite, tanto si pregiudica alle nostre ragioni e si accrescono quelle dell’avversario. Né mi rimarrò di ricordarvi che dovete per obbligo di natura piuttosto desiderar che l’abbia io, che vi son parente e servidore e della casa vostra, che uno strano, e che da me potrete sperare alla giornata infiniti piaceri e comodi, come la esperienza ve ne potrà far testimonio. Ma io passo omai i termini della brevità. Vivete felice ed amatemi, com’io osservo voi.
Mi s’era dimenticato di dirvi che in ogni caso, ancorché la causa si vincesse, bisognerà pagar li 300 ducati di Camera ogni anno a quel favorito del Papa, come paga Matteo, oltre le spese dell’ufficio, che sono infinite, e massime standovi io con la casa. Alla Signora cavaliera bascio infinite volte le mani e la bocca alli figliuoli, i quali prego Nostro Signore che accresca sì in virtù ed in fortuna che siano la contentezza de’ parenti e la grandezza della casa loro. Di Roma, il XXI di aprile del L.
Al medesimo [Sperone Speroni] a Padova22
Molto Eccellente Signor mio Osservandissimo. Io non ho mai preso dispiacere della negligenzia che avete molte volte usata in risponder alle mie lettere; sì perché amo più le vostre comodità che il mio piacere; sì ancora perché la maggior parte delle lettere ch’io v’ho scritte da molti anni in qua sono state piuttosto per mostrarvi l’osservanza mia verso di voi, che per alcun bisogno ch’io avessi dell’opera e favor vostro. Ora, io vi vo’ confessar il vero ch’io n’ho preso grandissimo dispiacere, perché avrei pensato che, in questo caso, dove il consiglio e giudizio vostro m’importa tanto, deveste vincer la negligenzia della vostra natura, sapendo voi quanto sete obbligato all’infinita affezione che v’ho di continuo portata e porterò sempre ed all’opinione che ho sempre avuta del vostro giudizio. Ho pigliato anco dispiacere che avendovi quel Gentiluomo23 per accompagnar le lettere mie, poiché il cardinale Tornone non veniva a Padova, scritto una cortesissima lettera, non gli abbiate risposto; perché le sue rare ed onorate qualità meritano che la sua amicizia sia desiderata, non disprezzata. Pur mi consolo con la speranza ch’io ho che dopo la data delle lettere sue, che sono de’ 25 del passato, gli abbiate risposto e scritto anche a me. Se non l’avete fatto, fatelo vi prego e non ricusate l’amicizia d’un caro gentiluomo. Né v’incresca, se pur merito tanto, di scrivermi il vostro parere circa le due difficultà ch’io v’ho scritto, senza il quale non posso riveder l’opera. Fatelo, Signor mio, che sete obbligato, per l’affezione ed osservanzia ch’io vi porto, a far maggior cosa per me e vi bascio la mano. Di Pesaro, il XII novembre del LVII.
Al medesimo [Sperone Speroni ] a Padova24
La fortuna non è ancor stanca di travagliarmi; anzi, ora m’ha fatta la maggior ingiuria ed offesa di quante n’ho ricevute da lei. Ho avviso da Ferrara che il Signor Pio degli Obici ha portato doi fogli stampati del mio Amadigi e che, essendo stato letto in casa del Vescovo d’Adria, fu commendato assai e spezialmente da Messer Lorenzo Gambara, al quale fu risposto dal Signor Pio; «Voi sete di contrario parere di Messer Sperone, i qual m’ha detto che questo poema non val nulla»; ed essendogli replicato che non deveva aver bene inteso Vostra Signoria e che difficilmente si poteva ch’avendola io già tanti anni osservata e riverita avesse detto queste parole, ancorché il poema fosse stato tale; esso Signor Pio replicò che così era come egli avea detto prima. Io credo, Signor mio, che non sia vero che Vostra Signoria l’abbia detto, ma essendo le persone di questo mondo inclinate piuttosto a credere il male che il bene, e tanto maggiormente sendo fondato questo romore sovra l’autorità di Vostra Signoria, mi è per far grandissimo pregiudizio e nell’utile e nella riputazione. Io la prego caramente che, possendo in questo caso che tanto m’importa, però senza strepito, giovarmi, che lo faccia; ché se il poema non lo merita, lo merito io e mi farà grazia segnalatissima di destramente proccurar di sapere chi abbia stampato questi fogli.
Io mi licenziai dall’Accademia e, con tutto questo, la vicinità mi faceva dar di molti fastidi, il che è stato cagione ch’io son venuto qui, nelle case di Messer Lionardo Moro, dalla parte verso Murano. Se la lontananza non darà fastidio a Vostra Signoria, la comodità vi sarà maggiore. L’ho tolta solamente per sei mesi, sperando in quel tempo di dovermi partir di qui. E le bacio la mano. Di Venezia, l’VIII di marzo del LX.
Vostra Signoria potrà indirizzar le lettere a Rialto alla Libreria della Fenice, perché ho dato ordine che mi siano portate.
Lettere inedite di Bernardo Tasso precedute dalle notizie intorno
la vita del medesimo, per cura di Giuseppe Campori
Al principe di Salerno25
Dal razionale ebbi le lettere di Vostra Eccellenza in risposta delle mie e, perché mi fu detto che mi scriveva con molta collera, subito ch’io lessi le due prime righe le prometto da leale servitore che non volsi leggere più oltre dubitando che l’affezione che vi porto, che è moltissima, non fosse vinta da qualche giustissimo sdegno. Potrebbe essere che io avessi passati nello scrivere i termini della modestia che si conviene d’aver al servidore verso il padrone e, s’avessi serbata copia di quella lettera, l’avrei considerata, ma la disperazione (come sapete) è quasi una sorte di pazzia, e la necessità nella quale veggio me e la povera abbandonata mia famigliuola m’ha fatto entrare non pur nella prima, ma quasi nell’ultima specie di disperazione. Poi che a Vostra Eccellenza è stato lecito di farmi tanti torti, sia almeno lecito a me di dolermene; e se pure ho trapassato i segni del mio debito, iscusatemi e perdonate questo errore alla giusta cagione che mi muove, alla mia necessità e a voi stesso. Corpo di Dio, come non volete ch’io sia disperato vedendomi in tanta povertà che mi bisogni star nel letto per acconciarmi le calze; ché se non fossero i ferri vecchi che mi portai da casa, non avrei di che nascondermi le carni, e gli altri che vengono da quelle parti tutti carichi d’oro e di seta risplendono a guisa di raggio di sole. Insegnatemi, Signor mio, di rimediare alla necessità con belle parole, ch’io sarò più modesto, altrimenti io dirò; il poverel digiuno viene ad atto talor ch’in miglior stato avria in altrui biasimato. Io non ho più amici né credito perché nelle infelicità e nelle miserie non si trovano amici e ho bisogno o di presto aiuto, o di presta risoluzione. La pazienza è virtù, ma ogni virtù (come sapete) ha i termini suoi oltre i quali non si può in alcun modo trapassare che non si cada nel vizio. Io vi supplico che usiate quell’uffizio con me che sete debitor di fare e ch’io merito, e circa questo non dirò più altro.
Io diedi le lettere al Reverendissimo di Bellai e all’ambasciatore accompagnandolo con quelle poche parole che mi parvero accomodate alla materia, poiché Vostra Eccellenza non ci scrisse ciò che avessimo a dirgli. Oggi l’ambasciatore è gito a portare la lettera al Papa, il quale siccome m’ha detto Sua Eccellenza, manderà un personaggio di chi si fida; ed ancor che detto Signor vi scriva, m’ha comandato ch’io vi ricordi che siate cauto nel negoziar con quello che manderà Sua Santità, sì che non iscopriate con lui alcun vostro disegno, quasi certo che quanto gli direte verrà a notizia degli Imperiali, i quali lo potrebbono impedire e fargli danno… (1554).
Lettere inedite di Bernardo e Torquato Tasso. Saggio di una bibliografia delle lettere a stampa di Bernardo Tasso,
a cura di Giuseppe Ravelli26
Al mio carissimo figliuolo, Torquato Tassi27
Carissimo figliuolo. Io risponderò alle due parti della tua lettera più brevemente ch’io potrò e comincierò da quella ch’importa più a te. Per gli avvisi che ha il duca28 e il cardinale nostro da Roma, il Papa29 non è in termine che se gli prometta sì breve vita. Si ha ben per certo che farà buon numero di cardinali, ma non so se vi sarà Monsignor tuo Reverendissimo, non perché non lo meriti forse tanto e più di quelli che sono nominati, ma per alcuni rispetti, mossi dalle umane passioni. Se pur sarà (che Dio voglia) sarà un gran cardinale e de’ più stimati di quel collegio. E quando potesti aver col mezzo del Signor Papio da Sua Signoria Reverendissima onesto trattenimento, non mi spiacerebbe l’elezione. Perché col Signor duca v’ho poca speranza, mandando Sua Eccellenza il principe a viver alla corte di Spagna, la qual risoluzione toglie a noi la speranza ed a Sua Eccellenza il modo di mandarla a fine. Ma quello che più mi piacerebbe è che, succedendo il caso, il Signor Papio vedesse di darti qualche altro appoggio affine che potessi finir il tuo studio30, il che so quanto importi alla tua dignità; e questo procura con ogni diligenza, né ti lasciar vincer dalla vanità che alla fine ti ritroverai di aver fatto utile a te e data contentezza a me.
Ora, passando alla parte del mio poema ti dico ch’io fingo il padre un gran re, che di grandezza competeva con Lisuarte e che si dilettava di trattener non pur cavalieri, ma uomini rari nelle scienze e, sovra tutto, poeti ed istorici. Fingo che Floridante si partisse dal padre secretamente e contro sua voglia, il che gli diede cagione d’infinito dispiacere. Talmente che dodici cavalieri erranti di gran grido, che si trovavano allora in corte, giurarono d’andar a cercarlo e di non tornar giammai senza lui, la qual cosa consolò il re e volse che ciascun di loro gli prometesse con giuramento in capo dell’anno, se pur non l’avessero ritrovato, di mandarli fedelmente a dire ogni ventura che avessero incontrata. E ordinò che, secondo che venivano, ciascuna di loro fosse data ad uno de’ suoi poeti, i quali, ridottala in versi, gliela cantasser alla mensa, e queste dodici venture saranno dodici canti. La proposizione del poema sarà l’amor di Floridante e di Filidora. Fingo che, partito dal padre per andar a soccorrere Pericone suo zio, trovato già il Donzello del mare, fosse menato da quel vecchio dove trovò Filidora e come è scritto nell’Amadigi. Fingo che, partito da Lisuarte dopo la battaglia del Canileo, trovasse un servitore d’Agramoro Prin, di Borgogna suo cugino, che gli narrò il caso della fanciulla che trovò col vecchio nel bosco e tutta quella ventura e, di più, ciò che gli era avvenuto con la regina di Tessaglia sin che, tornato nella sua forma, fuggì. Fingo che, Argea, quando ultimamente partì da lei Floridante, gli dicesse che troverebbe Agramoro che, disperato, andava cercando il giardino della fata Montana per liberar quella fanciulla e che vada con lui a liberarla ed a menarla nel suo regno, ché a lui solo è concesso di dar fine a quella ventura, e che poi subito vada alla selva perigliosa.
Eccoti, figlio mio, il disegno dell’opera. Saranno, oltre le stanze contenute nell’Amadigi, sedici altri canti che in tutto saranno trentaquattro canti. Raccomandami al Signor Papio e a tutti que’ gentiluomini e governati talmente ch’io meni contento a fine questi anni che mi restano.
Di Mantova, il XXIIII di dicembre del LXIII.
Lettere d’uomini illustri conservate in Parma
del R. Archivio dello Stato31
All’illustrissimo e eccellentissimo Signor mio osservandissimo, il Signor duca di Parma32
Se la cagione che m’ha posto in questo stato fosse stata turpe e vergognosa non sperarei di trovare chi, ne le mie necessità, mi soccorresse, ma perché la causa fu onorata – e per non abbandonar un principe, il quale aveva servito tanti anni e da qual mi trovava beneficato – spero di trovar chi mi avrà compassione e nondimeno vengo a quest’atto con molta erubescenza. Signor mio eccellentissimo, io son sforzato a stampar di novo l’Amadigi perché non ve ne son più e mi bisogna far una grossa spesa, né io ho altro modo che ricorrer a la liberalità de’ principi virtuosi e che hanno parte in questo poema. Però supplico quanto umilmente posso Vostra Eccellenza che insieme co gli altri mi voglia soccorrer di quella parte che le tornerà comodo, ch’io riporrò la memoria di questo beneficio ne la più cara parte de l’animo mio. E quando altrimenti non possa mostrarlemi grato, con la lingua e con la penna m’affaticherò di pagar parte del debito mio. Io non voglio più lungamente pregarla perché non paia ch’io mi diffidi de la grandezza e liberalità de l’animo suo che ha già fatto un lungo abito in questi offizi di cortesia. Nostro Signore con corso di felicità accompagni tutte le sue operazioni.
Di Ferrara, il 2° d’ottobre del LXII.
Pietro Aretino, Lettere
Lettre de l’Arétin à Bernardo Tasso33
Io che vi sono più fratello in la benivolenzia, che voi non mostrate d’essermi poco amico in l’onore, non mi credevo che il sereno del mio animo devesse mai più comprendersi da la sorte di quei nuvoli che dopo i tuoni e i baleni iscoppiarono nel folgore che mandò Antonio Broccardo sotterra. Onde coloro che tal miracolo viddero, e sono così fatti, devrieno tenerlo più tosto per essempio che per ricordo. Alterezza d’ingegno vano e non cautela d’intelletto esperto è suto il di voi scrivere al non men buono che illustre Anibal Caro, che niuno autore di lettere è degno ch’ altri lo imiti al dì d’oggi, aludendo con tale sagacitade avertita al come voi quello sete che si deve imitar senza dubbio. Egli è certo che il troppo amore che portate ale cose vostre e il non punto che ne tenete a l’altrui vi hanno posto in compromessa il giudizio. Che se ciò non fusse, io, che me ne risento perché mi tocca e vi rispondo perché lo debbo, non entrarei a dimandarvi qual Dio vi parrebbe essere, caso che ne aveste posto in luce i volumi tanti anni prima di me, quanti gli ho messi inanzi di voi. Se nel divulgare in le stampe una così indiscreta aroganza, ne escludevate me come inimitabile, oltra il confrontarvi con l’oppenione di chi sa venivisi confermando ancora i modi del proceder vostro in le pistole. Nel cui necessario essercizio, suplite al mancamento del non mi potere contrafare in le sentenzie né in le comperazioni (che in me nascano e in voi moiano) co i lisci e co i beletti de le fertili conrispondenzie ch’io uso ne l’ordine del come sarebbe a dire «egli ve ne rendarà gratitudine», «io ve ne terrò obligo» e «voi ne ritrarete laude». Invero che nel contesto di simili andari mi venite drieto a piè saldi; né potreste però fare altrimenti, essendo il vostro gusto inclinato piú a l’odor de i fiori che al sapore de i frutti. Onde, con grazia di stile angelico e con maniera d’armonia celeste, risonate in gli epitalami e ne gli hynni. Le cui soavità di dolcezze non si convengano in lettere, che a loro bisogna il rilievo de la invenzione e non la miniatura de l’artifizio. Or per entrare nel poco rispetto che avete avuto e a i vivi e a i morti, dico che poi che il Bembo non può e che Tolomeo nol cura, l’uno per non esserci e l’altro per non degnarse ch’io, che fui divoto a quello e che sono riverente a questo, mi stupisco, non pur maravigliomi, del come possibil sia che la conscienza non vi rimorda, circa il niente aver di riguardo a l’autorità del vescovo e a la memoria del cardinale, ne la professione del far lettre. Lo studio de i quali, nel farle, l’ha sì ben fatte, che pochi le faranno sì bene. In tanto voi, che più che non si può sapere, sapete, nel principio de l’opera a Monsignor D’Arasse, gite togliendo ala mia natura «con la man dell’ arte»; ciò ch’io non batezo per furto, quando non mi neghi che l’avertenza del tor via le repliche risplenda in tutta la moltitudine de le carte che ho scritto; concedendomi in dono il non volere ch’io impari da altri quel c’ho insegnato ad altrui. Del che tanto più mi si dee quanto men ne favello. E ciò faccio perché voi nel destinare e legge e termine e norma a le signorie, a le eccellenze e a le maestadi, ci date suso, ve ne compiacete e gitevene empiendo da senno. Ben che astuzia e non disavertenza è la trama, che se metteste in esecuzione i di voi precetti in tal cosa, la vostra Signora cognata, il vostro Signore cugino e la vostra Signora consorte se apellarebbono al magistrato de la loro sublime prosapia. Ora al dirmisi che la somma di tutto il mio dire, nasce dal vostro non me ne avere pur una, de le infinite già scrittemi, impressa, rispondo che ieri uno iscolare di conto mi converse in riso il silenzio, dicendo in cotal proposito; «Rallegrati, o Pietro Aretino, del non vederti nel registro di Bernardo Bergamasco, che staresti a rischio, essendoci, che il tuo nome sodo si diminuisse in fette». Or, perché non è errore il laudarsi a l’uomo di qualche merito in presenzia di chi nol conosce, a ciò sapiate chi sono, massime ne lo scrivere lettere, vengo a dirvi che Visco e Don Diego, grandi in Roma e vostri anco, giurano che Inghilterra e Portogallo tre volte nel proprio consiglio fecer replicarsi quella a Francia, alora ch’era il Turco a Corfù. E il Contarino medesimamente qui scrisse al Legato, in nome del Papa, che in cambio d’Imbasciadore al Re si mandasse. «Solo la tua ci poteva consolare in la mora de la imperatrice», dissemi lo imperadore a Peschiera; soggiugnendo che «tutti i primi di Spagna, de la a noi nel sinistro d’Algieri, han la copia». «Ha possuto tanto in me la vostra affettuosissima lettra; che subito comandai che il Lioni fusse tratto di carcere», così mi scrisse Fiorenza. Dimandasi la eleganzia del singular Manuzio ciò che gli è parso la indrizzata al gallico sire, quando la sorte depositollo prigione. Siena a popolo tutta, laudando io le condizioni che mi credevo in Frate Bernardino alotta, in vertù d’una che di lui ragionavo al Nello, idolo se lo fé d’odioso. Che più? Il celebre, il celeberrimo, il celebratissimo Isperone, afferma che mi manda presenti e non lettre per che … io nol vo’ dir per modestia. Ma da che il presumersi è un fume di grandezza in ombra, il quale aceca in modo chi gli pare essere e non è, che si rimane assai da meno ch’ei non si teneva da più, io, per non simigliarmi a la spezie di tali, non dico che i vertuosi devrebbono farsi il dì che ci nacqui festivo, da che io senza correr poste senza servir corti, e senza mover passo, ho fatto a la vertù tributario qualunche duce, qualunche principe e qualunche monarca si sia. E per che in tutto il mondo per me negozia la fama, in la Persia e ne la India il mio ritratto si pregia e il mio nome si stima. Sì che, o spirto eletto, pentitivi d’alterare l’amistadi con il dispetto, con la ingiuria, col biasimo; e quando pure vi piaccia di estollervi sopra le stelle benemerto col grido, concludetela in le ragioni che in pro de la impresa alegaste al duca d’Urbino, però che de i piccoli agenti e non de’ gran capitani, si eseguiva il parere a quel tempo. Non iscordando a voi negoziante le paghe del conte Guido Rangone, le pratiche che de le guerre e de le paci apresso di Francesco primo e di Clemente settimo trattaste in Salerno. Ma tutto è sogno, salvo il pronostico che di Cremona, di Pavia e di Milano, dopo il fatto, faceste concorrenza de le profezie che Messer Virgilio pose in bocca ad Anchise, dieci secoli dopo i successi. La fine è mo’, che in mentre vi gite inpennando l’ale de lo Amadis che reducete in romanzi, non vi scordiate de i canti che qui indrizzaste a quei due che non ve ne dierono risposta; per che nel dire il vero è pericolo e nel parlare la menzogna peccato. Ben ch’io in ultimo vi saluto con assicurarvi che nessuno in compor lettre vi biasima per invidia, ma ben molti, in averle composte, vi laudano per compassione.
Post scritta; io vi faccio intendere che ognun tien per fermo che verremo insieme a duello. La qual cosa acadendo, più certa è in me la vittoria, che in voi dubbioso il combattere. Onde vi esorto al consiglio, e non ala furia. E quando pure più possa nel petto vostro l’ira che il senno, la elezzione de l’armi vi dono e la eletta del campo concedovi. D’ottobre in Vinezia. mdxlviiii.
L’Amadigi del S. Bernardo Tasso.
A l’invitissimo e catolico re Filippo34
Préface de Lodovico Dolce
Eccovi, giudiziosi e benigni lettori, il da voi tanto disiderato e aspettato Amadigi dello Eccellentissimo Signor Bernardo Tasso, il quale uscendo finalmente nella luce de gli uomini viene nelle vostre mani. E, benché senza dubbio è da credere che questo poema sia per piacere generalmente a tutti, vincendo di gran lunga l’aspettazione, ed è soverchio a lodar cosa che al giudizio comune sia lodatissima; non dimeno, perché alcuni, dati del tutto allo studio delle greche e delle latine lettere, non pur non comendano, ma riprendono questa nuova, vaghissima e dilettevolissima maniera di poesia ed ogni altra che non sia disposta secondo l’arte d’Aristotele ed ad imitazione di Virgilio e d’Omero, né vogliono che così fatti poemi siano ammessi per eroici né per buoni, giudico che sia bene di discorrere alquanto con esso voi intorno a cotal maniera a sodisfazion vostra e de gli amatori di questa nuova poesia.
Dico adunque che, se coloro che tengono sempre in mano le bilancie d’Aristotele e hanno tutto dì in bocca gli esempi di Virgilio e di Omero considerassero la qualità de’ tempi presenti e la diversità delle lingue e vedessero ch’a la prudenza del poeta si conviene l’accomodarsi alla dilettazione e all’uso del secolo nel quale egli scrive, non sarebbono d’opinione che si dovesse scrivere sempre ad un modo. Ché, sì come i tempi introducono nuovi costumi e la varietà delle lingue diverse forme di favellare apportano, così pare che ragionevolmente si ricerchi che si faccia nello scrivere. Onde si vede che Virgilio sia molto differente da Omero; sì come quello che, trovandosi in età diversissima da quella di Omero, seguitò l’uso del suo tempo e quello che questo divino poetà giudicò che convenisse alla grandezza della lingua romana. E con la stessa ragione è da credere che altretanto si sarebbe egli discostato dal costume del suo secolo quando si fosse trovato nel nostro, percioché chi altrimenti fa, si può dire che scriva a’ morti. Noi veggiamo che molte cose si contengono in Omero che ai suoi tempi erano lodatissime, le quali, ove fossero prese da’ poeti d’oggidì, sarebbono stimate senza fallo ridicole. Alcune anco si leggono maravigliose in Virgilio che, a’ nostri giorni, non sarebbono molto grate. A che, se riguardo avessero i riprensori dell’Ariosto, non sarebbono al mio parere così arditi. Ma, perché intorno a ciò dall’Eccellente Signor Giovambattista Giraldi e da alcuni altri è stato scritto a bastanza, dirò solo che il dottissimo Signor Tasso, come anco l’Ariosto, aveva molto ben veduto quanto intorno al poema epico scrive Aristotele e ottimamente osservate le strade tenute da Virgilio e da Omero. E già aveva dettata una buona parte dell’Amadigi a imitazion loro e secondo le leggi di Aristotele; e la preposizione del suo poema, per farlo d’una sola azione, era la disperazione d’Amadigi; e divisa l’opera in libri. Da poi vedendo, tutto che di farlo vago e piacevole si fosse affaticato, che non dilettava e veduto che non dilettava parimente il Giron cortese dell’Alamanni che si era dato a quella imitazione e che, d’altra parte, l’Ariosto, che se n’era dilungato, andava per le mani di ciascuno con lode e grido universale, mutò con miglior giudizio consiglio e diede al suo Amadigi quella forma che vedete al presente, abbracciando più azioni e accostandosi a quella piacevole varietà che, nell’Ariosto, è stata dall’universale giudizio de gli uomini lodata e approvata; e ha conseguito insieme con lui, come tosto leggendo questo poema vi sarà lecito di vedere, parimenti il medesimo fine che è il dilettare; intento principalissimo del poeta. Percioché, quantunque un soggetto da sé stesso sia dilettevole, se la testura, che è il modo di spiegarlo, non aggradisce alle orecchie di chi legge, come potrà egli partorir questo effetto? I poeti non si leggono se non principalmente per cagione del diletto. É vero che col diletto è congiunto l’utile, ma non come necessario, senon in quanto il buon poeta (e specialmente l’epico) non si pone a scriver di cose vane ma non meno da proposito che dilettevoli, adombrando sotto il piacevole velo delle invenzioni i precetti della moral filosofia. Di qui credo io che il Signor Tasso si prenderà in pazienza se il suo poema non sarà approvato da que’ dotti così scrupolosi, pure ch’egli abbia ottenuto (come nel vero si vedrà avere) quel fine per cui si muovono a scrivere i buoni e giudiziosi poeti che è la dilettazione, come si vede aver fatto l’Ariosto. Il quale, quando avesse così le vestigia d’Omero e di Virgilio seguitate, o non sarebbe forse letto da alcuno, o per avventura da pochi, non ricevendo il nostro tempo né la nostra lingua, quelle forme e maniere di scrivere che furono usate da loro. É ben vero che, avendo il Signor Tasso la invenzione col mezo di molte belle favole trovate dal suo felicissimo ingegno e con la disposizione e con l’arte ristrigendo, allargando, mutando, fatta di comune propria e sua particolare, non s’è obligato ad alcune cose che piacquero all’Ariosto, come di serbare la moralità ne’ principi di ciascun canto, ma quelli è ito variando per maggior vaghezza e cose simili. Appresso, trovando già per lunga esperienza la nostra lingua capevole d’ogni ornamento, ha voluto in ciò arricchir la sua opera di epiteti, di traslati, d’iperboli e di molte figure che abbelliscono il poema e lo fanno magnifico e grande, come eziando felicissimamente ha fatto nelle altre sue amorose Rime, in questo imitando volentieri i Latini ed i Greci, che ne sono abondevoli, e seguendo il suo genio, il quale gli ha dato uno stil florido, vago e più ornato di quanti hanno scritto fin qui. Le quali cose, per essere elle in questa maniera di volgari poemi in gran parte nuove, stimo che, da i poco intendenti forse non saranno del tutto gustate. Nella lingua è sceltissimo ed accurato; non però tanto che si sia voluto ristringere superstiziosamente nelle parole del Petrarca, sapendo che al poeta eroico non conviene la delicatezza delle voci che appartiene al Lirico. Il verso è puro, alto e leggiadro, né si parte giamai dalla gravità, la qual serba più e meno secondo la qualità de’ soggetti. In ogni sua parte è facile e accompagna la facilità con la maestà, mistura tanto difficile. Nelle sentenze è abondevole quanto conviene e grave. Usa belle e propriissime comparazioni, alcune delle quali, se possono parere alquanto simili, oltre che se ne trovano in Omero di più simili, egli le fa dissimili con la varietà delle figure; e altrettanto si vede aver fatto nelle descrizioni de’ tempi, de’ luoghi e di altre cose. Serba la convenevolezza in qualunque cosa mirabilmente, né parte è di questo suo dottissimo poema che non diletti e che non giovi tenendo sempre in una dolce e grata aspettazione il lettore. Ci appresenta ciò ch’ei vuole dinanzi gli occhi con tanta efficacia che non più potrebbe far dipingendo il pennello di Apelle o di Tiziano. Nel raccontar le dolcezze, le amaritudini e le passioni d’amore, vince al mio giudizio di gran lunga ciascun poeta e in descriver le battaglie e gli abbattimenti de’ cavalieri, de’ giganti e de’ mostri che v’intervengono è altresì incomparabile, dimostrando quanto importi l’essersi trovato ne’ fatti tra l’orribil suono delle trombe e de’ tamburi. Nelle cose della cosmografia ha usato tanta diligenza che pare che conduca il lettor, senza niuna fatica, di città in città e di luogo in luogo, per mano. Muove gli affetti in guisa che sembra tiranno de gli animi, senza laqual parte necessarissima i poemi rimangono freddi e come corpo senza anima. In fine, tutto quello che da perfetti giudizi si può forse nell’Ariosto disiderare, con molta felicità ha egli adempiuto in questa opera. Con tutto ciò, il suo purgatissimo giudizio infino a qui non si è compiaciuto. Anzi, come ho inteso da lui medesimo, non l’avrebbe egli ancora mandata fuori se il sovra detto Signor Giraldi non gli avesse scritto che già in Ferrara se ne erano venduti, stampati, due canti. É avenuto ancora che, dove a’ poeti (e specialmente a’ componitori di tali poemi) si ricerca ozio e tranquillità di animo, si può dire che il Signor Tasso abbia composta la maggior parte dell’Amadigi a cavallo, tra i rumori delle armi e ne’ disturbi di diversi negozi che gli hanno apportato i tempi, la fortuna e le occasioni. E non è dubbio che, nelle altre impressioni, egli non sia per farvi diversi miglioramenti, non dovendo in questo esser men lecito a lui che sia stato al Reverendissimo Bembo e all’Ariosto di coregger più volte le opre loro, mutando essi in più luoghi i versi e le stanze intere. Il quale Ariosto, come quello che, fra tutti gli altri che in questa maniera di poesia fino a questo tempo hanno scritto, senza alcuna contradizione tiene il principato, ha voluto che ne la disposizione del suo poema gli serva per legge. Il che viene ad approvare il giudizio di quel poeta e sarà esempio a’ belli ingegni, i quali volendo che i loro componimenti sian letti gli indrizzeranno per questa via. E certo non sarebbe se non sciocchezza lo allontanarsi da quell’uso ch’è approvato dal mondo. Già l’Ariosto è stato accettato comunemente per poeta non pur raro, ma divino. Et è da riportarsi al giudizio comune, il qual solo è quello che toglie e dà la riputazione e la immortalità a qualunque poema.
Notes
- Les deux éditions donnent à lire les mêmes textes, parfois dans un ordre différent, comme c’est le cas pour le Discorso o memoriale presentato da Bernardo Tasso al contestabile del re di Francia Enrico II nel 1553 qui figure à la fin du fascicule publié par Panizza et qui, dans la version de Bianchini, est présenté comme une lettre portant le numéro 29, mais n’offrant aucune référence de destinataire, de date ou de lieu.
- À une première lecture, elles ne semblent pas avoir un grand intérêt pour notre propos, d’autant qu’une partie d’entre elles n’est pas du Tasse mais de ses différents mandants ou destinataires, mais là aussi, il faudra se pencher de façon plus approfondie sur leur contenu dans un essai à venir.
- Lettere, I, XVIII, p. 47-50. Lettre de conseils, voire de réprimandes, à son protecteur du moment.
- Cette lettre a été expédiée de la cour française, qui logeait alors à Saint-Germain. Le comte Rangone avait chargé le Tasse de négocier son éventuel passage au service du roi de France. La période précise n’est pas déterminable mais on peut la situer après le mois d’août 1528, car dans la lettre XXIII qui précède il est fait allusion à la mort de Lautrec survenue le 16 de ce même mois.
- Lettere, I, LXVI,p. 118-119.
- Lettere, I, CXX, p. 212-214. Lettre à tonalité spirituelle où le poète exhorte l’abbé à suivre le chemin de la vertu. Probablement rédigée dans les années 1542-1544.
- Les citations étant tirées de la réimpression de l’édition de 1559, je conserve le terme de « volontà », tout en rappelant qu’il s’agit en fait de « voluttà ». Cf. le chapitre sur les abréviations, paragraphe : « Interventions sur le texte ».
- Idem.
- Lettere, I, CXXXIII, p. 242-244. Lettre dans laquelle le Tasse émet le souhait de pouvoir s’élever au-dessus de ce bas monde et d’être illuminé par la grâce. Datée des années 1542-1544.
- Lettere, I, CXLVII, p. 269-274. Ce texte a été cité dans le chapitre 2, mais il mérite d’être lu dans son intégralité pour le rôle de chroniqueur de guerre que le Tasse s’y attribue et pour les déformations de la réalité des faits qui ont été soulignées.
- Lettere, II, LXXV, p. 226-229. La correspondance que Bernardo entretient avec ses pairs sur les difficultés qu’il rencontre dans la composition de son poème chevaleresque est très fournie, que ce soit dans ce deuxième recueil épistolaire, dans les Famigliari éditées par Comino et jusque dans les inédits mis au jour par Campori. Pour éviter d’alourdir cette partie consacrée aux transcriptions de textes choisis, j’ai opté pour un seul exemple de questionnement.
- Lettere, II, CL, p. 486-490. Cette lettre a été choisie pour mettre en lumière la différence de tonalité qui sépare souvent le premier du deuxième volume. À comparer avec celle qui est adressée à Guido Rangone.
- Où résidait alors le prince de Salerne après être passé dans le camp français.
- Guidobaldo II della Rovere, duc d’Urbin.
- Le manuscrit comporte la graphie « parte », mais au vu du contexte, il s’agit d’un passé simple.
- Le Tasse évoque la proposition qui lui fut faite en 1558 d’occuper un emploi à la cour d’Urbin.
- Lettere, II, CLIV, p. 498-504. Cette lettre, qui est datée du 15 juillet 1558, résume le parcours du poète-courtisan après son retour à Rome en 1554. Son contenu reprend certains des leit-motiv qui caractérisent une bonne partie de la correspondance de ces années-là, notamment ceux de la sévérité des juges et de l’ingratitude du prince de Salerne. J’interromps sa transcription au début de la page 502, lorsque le Tasse commence à parler de la composition de l’Amadis.
- Lett. MTasca, I, p. 9-11. Cette lettre explicite les raisons de la pauvreté de Bernardo Tasso après son départ de Rome.
- Lett. Com. 1, p. 570-574. Cette lettre qui n’est ni adressée à notre secrétaire, ni même rédigée par lui, est d’une certaine importance pour notre propos dans la mesure où elle expose clairement les dangers qu’encourait le prince de Salerne en acceptant l’ambassade que voulait lui confier la ville de Naples. Elle redimensionne donc la responsabilité du Tasse dans la décision prise par le noble napolitain.
- Ce troisième volume de Comino, dénommé aussi Le Famigliari, comprend nombre de lettres inédites du Tasse à ses proches mais aussi à des amis de longue date comme Sperone Speroni. Dans leur ensemble, bien qu’ils apportent parfois quelques éléments nouveaux, notamment sur certaines de ses affaires, ces textes, qui accordent une large place à la composition de l’Amadis, ne modifient pas fondamentalement les analyses effectuées sur les autres recueils.
- Lett. Com. 3, 6, p. 66-68. Cette lettre fait partie de celles qui évoquent les affaires du poète. L’image qu’il y donne de lui n’est pas exactement celle du chantre de la moralité, du pater familias et courtisan exemplaire qu’il décrit dans son recueil de 1549.
- Lett. Com. 3, 34, p. 129-130. Évoque l’agacement du poète face au silence qui lui opposé par Speroni à ses demandes de conseils.
- Vincenzo Laureo, médecin du cardinal de Tournon.
- Lett. Com. 3, 36, p. 149-151.
- Lett. Camp., XV, p. 99-102. Lettre de reproches adressée au prince et censurée dans le volume de 1560. Bernardo Tasso y reprend et développe le thème de sa pauvreté.
- Ce volume ne comprend que cinq lettres, quatre de Bernardo et une de Torquato.
- Lett. B&T , IV, p. 17-19. Quatrième lettre du Tasse de ce bref recueil, elle est adressée à Torquato et présente un intérêt tout particulier parce que c’est l’un des rares témoignages sur la manière dont, à quelques années de son décès, le poète entendait concevoir son Floridant.
- Probablement le duc Guillaume de Gonzague.
- Pie IV, 1560-1565.
- Entre 1560 et 1565, Torquato se trouvait à Padoue où il étudia d’abord le droit, puis la philosophie et la poésie.
- Dans ce florilège, deux lettres seulement sont de la main de Bernardo Tasso.
- Lett. Parma, I, p. 607-609. Tout l’intérêt de ce document réside dans la remise en question de l’opinion communément admise que l’Amadis ne connut qu’une seule édition, car ici le Tasse sollicite l’octroi de fonds pour une nouvelle impression. Peut-être ne s’agit-il que d’un retirage.
- Pietro Aretino, Edizione nazionale…, lettre 345, p. 267-270. Dans ce texte vengeur, l’Arétin se plaint de ce qu’aucune des lettres du « famoso padre » qui lui avaient été écrites précédemment ne soit publiée.
- Amadigi, Ai lettori (pages non numérotées). Cette préface – véritable défense passionnée de l’Amadis – plonge immédiatement le lecteur dans la querelle entre partisans de l’Arioste et tenants de la littérature antique. Elle offre aussi un condensé de l’histoire de la composition du poème.